“Ernesto il disingannato” (romanzo del 1874) a cura di Gianandrea de Antonellis (X)
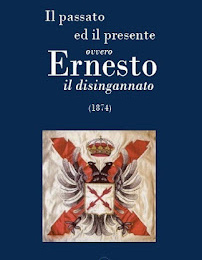
Capitolo XI. Il Demonio tentatore
Fin dal [primo] momento in cui la Contessa si era trovata fortemente imbrogliata pel fatto del Militare che era stata costretta a sedurre e che l’aveva necessariamente fatta allontanare da Ernesto, essa aveva pensato al modo col quale riscattarsi del tempo perduto e meditato al come tornarsi ad avvicinare a quell’uomo che, dopo tanti anni, le aveva di nuovo fatto palpitare il cuore.
La sua mente fervida ed immaginosa le suggeriva tanti espedienti da poter mettere in campo, onde arrivare ad ottenere lo scopo di riavere al suo fianco e fra le sue braccia colui che aveva avuto la disgrazia di essergli troppo piaciuto; ma per quanto avesse potuto fare, non le era riuscito di sfuggire alla sorveglianza di colui presso il quale aveva dovuto necessariamente rimanere per tutto il tempo che abbiamo di sopra descritto.
[Intanto] il 18 ottobre era spuntato, le urne preparate pel famoso plebiscito erano situate da per tutto, Ernesto in quel giorno era occupatissimo a fabbricare voti ed accrescere il numero dei “Sì”, che tanto improvvidamente si gettarono in quelle; lo avresti detto non più un uomo, ma bensì moltiplicatosi per dodici, tanto che dal lontano rione di Foria lo si vedeva verso Chiaia e quindi a poco verso la via Santa Teresa, per incontrarlo di nuovo più tardi al Mercato ed al Porto; dovunque egli si accostava, seguito dai suoi seguaci subalterni, le urne si riempivano a manate di cartelle. Insomma egli in quel giorno, senza esagerazioni di sorta, si può dire fu colui solo che bastò a precipitare questo misero Paese nelle disgrazie, riempiendo in un attimo le urne di migliaia e migliaia di falsi voti, non dettati dal cuore ed anzi rifiutati dalla prudenza e dall’affetto che il di più dei Napoletani portavano pei loro Signori.
In una delle scorrerie che Ernesto faceva per assistere e vigilare dappertutto, pervenuto in via San Giovanni a Carbonara e precisamente nel palazzo Caracciolo di Santobuono, nel cui cortile stavano apparecchiate le urne per il quartiere Vicaria, occorse una scena degna di essere narrata, la quale fu l’origine di poter di nuovo la Contessa avvicinare Ernesto.
Avanti all’urna in dove si depositavano i “Sì”, c’era quella posta illusoriamente ed a pompa, dove per dar polvere negli occhi e gonzi si depositavano i “No”.
Un vecchio gobbo e contraffatto[1], nel mentre Ernesto, dopo di aver depositato almeno un altro centinaio di cartoline, stava osservando quello che succedeva, si accostò arditamente all’urna del “No” e stese la sua mano per gettarvi un voto. La sua figura originale e il suo volto da melenso[2] più l’atto che andava a compiere, che in quel momento di falso e vero entusiasmo nel medesimo tempo era tale da muovere in molti lo sdegno, in moltissimi le risa, produsse precisamente questo effetto in un gruppo di giovinastri che tutti correvano a gettare il loro “Sì” nell’urna d’appresso.
– Toh, guarda, guarda Giovanni, – disse uno di loro, rivolgendosi ai compagni – quell’animale anfibio[3] pretende fare l’opposizione al voto di una popolazione intera: egli si appresta a gettare il suo voto nell’urna del “No”.
– Va là, che se manca il suo cartellino il Plebiscito non avrà effetto e l’unità d’Italia non si farà, brutto maledetto!
– Ma che cos’è, perché non getti il tuo “Sì” come tutti gli altri, melenso! – gridò un altro di quegli assembrati.
– Per la semplice ragione che vi getto il mio “No”.
– Si vede dalla tua figura che non sei altro che un retrogrado oscurantista e che hai le tue idee stravolte come le tue gambe!
– Ed il cervello più gobbo del tuo dorso!
– Alto là con questi insulti – disse il malcapitato – in questa giornata io vengo ad esercitare un mio diritto come tutti gli altri ed il mio diritto voglio regolarlo come mi suggerisce la mia mente e la mia coscienza.
– Bella mente!
– Magnifica coscienza!
– Va là, che se fossi io, non ti farei accostare a quell’urna in verun modo, cialtrone che sei!
– Ed io invece mi vi accosterò e depositerò il mio “No”, con tutta la forza possibile!
E ciò dicendo si aprì una via in mezzo a quella calca, raggiunse il pianerottolo dove era situata la cassetta del “No” e con mano ferma vi gettò il suo voto.
Un grido d’indignazione si sollevò in tutta la calca che era colà ed uno dei più arditi si avanzò per ghermire il gobbetto e bastonarlo.
– Va là! – gridò costui – Non insultate un libero cittadino nell’esercizio del sacro suo diritto! A che dunque avete ampollosamente pubblicato con i vostri editti che il voto era libero e che ognuno, mercé un semplice monosillabo di senso contrario, avrebbe potuto palesare il suo pensiero, quando poi al momento che questo si viene a far conoscere a tutti, si vuole imporre e forzare forse a dire il contrario? Per Dio, che se la bisogna va di questo passo, levatela quest’urna di qui; anzi, era meglio che non l’avreste posta nemmeno!
– Abbasso, abbasso! – gridarono molti e si scagliarono contro quel meschino ad onta che la Guardia Nazionale di servizio avesse opposta tutta la possibile resistenza per impedire che quel vecchio fosse tormentato di vantaggio[4]; ma egli, che forse attendeva quel punto della scena incominciata, immediatamente si rivolse ad Ernesto, che dal suo posto tutto guardava, dicendogli:
– Signore, io vi conosco, voi siete un galantuomo ed un uomo onesto; abbiate la compiacenza di proteggermi, tanto più che mi accorgo esser voi uno dei capi di questa riunione: non vi chiedo altra grazia che quella di accompagnarmi di persona fino al mio domicilio, altrimenti sono sicuro che, partito di qua, potrò imbattermi forse lungo la strada in qualche altro spiacevole incontro che potrà costarmi forse la vita.
– Volentieri – rispose Ernesto e profittando dell’occasione, per far vedere agli allocchi che i veri liberali non avevano a schifo nemmeno i nemici, disse:
– Volentieri vi servo, buon vecchio; voi appartenete ad un colore molto diverso dal mio, ma ciò non toglie che siate pienamente nel vostro diritto. Le urne per raccogliere i voti sono precisamente situate per tutti; voi credeste di gettare il vostro “No”: avete fatto benissimo e questi signori malamente hanno agito, opponendosi alla vostra spontanea manifestazione; io vi accompagnerò e voi sarete sicuro di giungere sino alla vostra abitazione incolume e senza paura di cattivi incontri. Andiamo.
Ciò detto prese il vecchio gobbo per sotto il braccio e si avviò secolui verso la strada Pontenuovo e quindi, svoltando a destra, s’inoltrarono entrambi nel così detto Vico Lungo, in dove giunti in un palazzino, salirono al primo piano e colà, penetrati in una decente stanzetta, mentre il gobbo invitava Ernesto a sedersi e questi si scusava, dicendo non poter perdere il tempo, essendo questo prezioso per lui, s’intese tutto ad un tratto battere nella spalla e si vide di fronte un giovinetto che, facendogli segno di tacere mentre con l’altra mano imponeva al gobbo di partire, lo sollecitò a fermarsi.
– Chi siete voi? – disse Ernesto alzandosi e mettendosi nella difensiva, temendo che in una casa di retrogradi[5] gli fosse stato preparato un qualche agguato – Che cosa volete da me?
– Che mantenga ancora i tuoi giuramenti.
– I miei giuramenti?…
– Sì, che forse li hai di già dimenticati, come hai dimenticato del tutto colei a cui li facesti!
E nel dir ciò si tolse dalla testa una grossa coppola a visiera lunga che aveva e fece vedere le lunghe anella del biondo crine, che caddero inanellate lungo le spalle.
– Ravvisami, traditore.
– Erminia!…
– Quella son io.
– E che cosa ancora pretendi da me?
– Quell’amore che un tempo mi giurasti.
– E che tu, scellerata, tradisti.
– Non io tradii, ma furono una quantità di circostanze, che mi fecero comparire spergiura e traditrice. E che!, forse non sai come noi altri addetti alla santa causa d’Italia non possiamo pensare come noi stessi vogliamo? Noi siamo vittime dell’obbligo assunto e quante volte dobbiamo agire contro il nostro istinto. Allorché io, per ordine di chi poteva comandarci, dovetti piegarmi ad amoreggiare con quel maledetto Militare, che dopo d’avermi fatto perdere un lungo tempo e prezioso per guadagnarlo alla Santa Causa diventò talmente innamorato e geloso che non volle giammai più farmi allontanare dal suo fianco ed io dovetti tremare, gelare e star sempre sulla guardia per la mia vita; ed allorché tu, per la tua malaugurata gelosia, ti mettesti in collusione con esso e battendoti fosti ferito, palpitai per te e ad ogni istante avrei voluto correre al tuo fianco per assisterti, per sollevarti dai tuoi dolori, per lavare con le mie lagrime la piaga a te fatta da quello scellerato. Ma non potei: non potei sfuggire un istante alla sua sorveglianza, ed allorché egli partì dal paese dove si trovava in quel tempo, fui obbligata mio mal grado a seguirlo e ad essere sempre al suo fianco. Seppi le tue smanie, seppi il tuo dolore, seppi che la mia rivale ti aveva raggiunto e che tu, credendomi infedele, eri ritornato al suo amore e saresti di già suo sposo, se…
– E lo sarò.
– Lo sarai!… sconoscente!
– Sì, lo sarò, perché ho promesso, perché ho misurato la differenza che passa fra il suo cuore ed il tuo, fra l’amore che dessa mi porta e quello che tu dici di sentire. Emilia sarà mia moglie.
– No!
– Chi potrebbe impedirmelo?
– Io!
– Ed in qual modo, se lice sapersi?
– Col diritto che tu mi hai accordato su te.
– Diritto!… oh! non fare che io mi muova a sdegno in questo giorno in cui l’opera mia è tanto necessaria al trionfo della nostra causa; fa che io non sia distratto nell’adempimento dei mie doveri. Lasciami e fa che io parta: è necessario che io ritorni ad assistere all’opera imponente del plebiscito. Scostati, fuggi, allontanati da me: i miei momenti sono preziosi.
– Tu mi scacci? Ti pentirai, Ernesto, della tua ostinazione!
– Non avrò certamente a pentirmi di essermi sciolto dai lacci di una serpe, che consigliandomi il male mi ha allontanato per tanto tempo dalla ingenua Emilia, da colei che veramente e solamente mi ama.
– No, che non è dessa che veramente ti ama, sono io! Io, che per troppo affetto che ti porto sono stata debole a segno di sacrificarmi interamente per te! Ma no, tu non lo farai, Ernesto: tu non abbandonerai quella che tanto sacrificio ha fatto per te, e che… Ma tu abbassi gli occhi, tu quasi quasi piangi e t’affliggi; tu ti commuovi e non mi volgi più quel ciglio così irato e terribile, ma già mi guardi compassionandomi… Ernesto, Ernesto mio, pietà di me, pietà della tua Erminia! Non configgermi un pugnale nel cuore, non farmi morire di dolore, non fare che il rimorso strazi il tuo cuore in eterno, per avermi immersa nell’affanno e nella disperazione!
Ernesto, il cui cuore era troppo tenero e compassionevole, non ebbe più la forza di contenersi e, scoppiando in pianto:
– Erminia, – disse – le tue parole sono di fuoco, i tuoi sguardi mi fanno l’effetto di un ferro rovente! Tu dici di amarmi, ed io voglio ancora crederti. Ma Emilia anch’essa mi adora; quell’anima ingenua e pura, si è totalmente affidata alla mia parola, ella attende da me la felicità e la gioia: a che strappare il suo misero cuore? Noi, oh!, noi abbiamo di già molto goduto del nostro amore: spezziamolo, spezziamo questo affetto, rientriamo in noi stessi, cancelliamo quella macchia che abbiamo entrambi fatta al nostro onore e, conservandoci sempre amici, battiamo ognuno la propria via, la via della indipendenza e della libertà!
– No, tu devi essere mio, solamente mio!
– Erminia, per pietà, ascolta la mia voce!
– Sei tu, che devi ascoltare la mia: io voglio che tu ritorni al mio amore.
– Tu lo vuoi?
– Io te lo impongo!
– Inutilmente lo esigi e se tu, ostinata, cerchi di forzarmi, oh! sappilo, l’amore nasce spontaneo nel cuore degli uomini, e quando si vuol forzare, desso spesse volte si cangia in rabbia, in dispetto, si cangia in odio.
– Ebbene, sia pure così. Tu disprezzi l’amor mio? Temi dunque del mio odio!
– Lo sfido!
– Ti pentirai della tua pervicacia.
– Non ti temo, vipera velenosa.
– Guardati dalle mie morsicature: desse saranno terribili, e tu, nel momento dell’essere colpito dalla mia vendetta, bestemmierai e verserai lagrime molto più amare di quelle che in questo momento io verso innanzi a te.
– Lasciami uscire da questa casa d’inferno!
– Parti, esci pure; ma rammentati che hai visto troppo pregare l’innamorata Erminia e che nelle donne della sua tempra l’amore sprezzato diventa furore. Ed il furore di una donna abbatte, distrugge, uccide.
– Addio.
– Addio.
Ernesto scostando con braccio fermo la sciagurata Erminia che l’attraversava[6] il passo, chiuse l’uscio ed uscendo da quella casa, precipitandosi per la scale, corse nel resto della giornata a seguitare l’opera sua di vigilanza per i diversi posti in dove si eseguiva il Plebiscito.
Erminia, rimasta sola, prima pianse di nuovo e si disperò, indi, raccolte di nuovo le auree chiome sotto il berretto, si allontanò anch’essa da quella casa e partì meditando vendetta. La più terribile e spaventevole vendetta.
Capitolo XII. I vantaggi del Regno d’Italia
Il Regno d’Italia era stabilito, le provvide leggi (!) emanate dalla rappresentanza nazionale avevano incominciato a funzionare e tutti coloro che dopo tanti secoli si trovavano per forza riuniti sotto una medesima bandiera, ma non affratellati in verun modo, perché quantunque i paroloni erano stati assai, tuttavia si evidenziava la differenza d’interessi, d’indole, di costumi e di leggi dei sette Stati preesistenti d’Italia, erano talmente in disaccordo fra di loro, che difficilmente potevano tutti amalgamarsi e la premeditata unione, quantunque eseguita di fatto, pure in diritto non esisteva e non esisterà giammai nella Penisola.
Tutti coloro che sapevano tutto ciò che doveva succedere nell’avvenire gongolavano di essere riuniti con sì poco spargimento di sangue alla desiderata da essi unione d’Italia e pensavano ora che i fatti cambiati li avrebbero portati certamente al potere, mentre fin d’allora avevano dovuto mantenersi in disparte; pensavano, dico, d’impinguarsi e riempirsi le tasche, meditando la spoliazione di tutti i loro fratelli, come con titolo pomposo e sonoro avevano nominati gli abitanti dall’intera Penisola.
Si principiò l’ora di demolizione dallo scioglimento generale di tutte le preesistenti amministrazioni e furono viste sia nel nostro Regno, sia nella Toscana, sia da per tutto abolite le più belle istituzioni, tutte le antiche ed inveterate costumanze cui i popoli avevano fiducia e devozione e si introdusse un malinteso piemontesismo irragionevole, ridicolo e pregiudizievole completamente, perché, a prescindere che dalle prove fatte in seguito si può benissimo desumere che tutte le leggi di quel piccolo Stato, a qualunque branca fossero appartenute, erano sempre al di sotto di tutte le altri consimili degli altri Stati italiani; ma il pensare che tutto quello che o bene o male poteva essere adottato da un popolo ristretto ed educato in una certa maniera, che conservava tradizioni ed aveva costumi diversi, e quanto!, da tutti quelli degli altri appartenenti agli altri Stati, avesse potuto essere buono per ognuno, e che tutti obtorto collo avessero a quello dovute adattarsi, senza sentirne un terribile scuotimento, era idea sciocca e priva di fondamento.
Ed intanto i primi ministri che regolavano la cosa pubblica nei primi tempi del Regno d’Italia, scelti sempre tra i Piemontesi, non sapevano far altro che applicare le antiche leggi sarde a tutti i popoli italiani, distruggendo a man franca, sconvolgendo, adottando malamente e facendo in tal modo nascere la confusione, il malcontento, la svogliatezza in tutti, che fin dal principio, vista la mala parata, cominciarono a capire quali danni ci sarebbero piovuti addosso senza ombra di rimedio.
In quel primo impeto di cose avresti veduto un rimescolarsi d’impieghi, un accatastarsi di attribuzioni, una smania di trasmutamenti, un salire dei traditori dei loro connazionali sotto l’aspetto di martirio e di sofferenze non mai patite, o patite appena da far diventare nel paragone il compenso centuplicato per diecimila di ciò che si era patito…
Tutti coloro, di qualunque regione italiana fossero stati, i quali non volevano o non potevano adattarsi a lunghi tramutamenti di sedi, perdevano di botto i loro posti, senza logica, senza pietà, senza giustizia veruna. Nel rimpasto delle amministrazioni, i posti principali e più onorifici e lucrosi si accordarono ai Piemontesi, mentre gli altri dovevano contentarsi di quelli di scarto, di risulta e raccogliere le briciole che cadevano dai lauti pasti a cui si assidevano i subalpini; ed in questo caso si trovarono maggiormente i Napoletani che, senza offender poche specialità, si trovavano al di sopra di tutti per istruzione, onestà e pratica di affari. Mille famiglie furono poste sul lastrico delle strade e non valsero lamenti, diritti e rimostranze, ché i primi furono disprezzati, le ultime non accolte ed i diritti formalmente conculcati e derisi.
Lo sfacelo nel corso di pochi anni fu completo, il pubblico Tesoro depredato, le spese enormi a cui il Paese fu sobbarcato non potevano con le ordinarie risorse sostenersi e fu quindi giocoforza ricorrere a nuove tasse, balzelli ingiusti, vessatori e qualche volta ridicoli; i finanzieri, senza conoscere scienza finanziaria, non sapendo colle loro teste piccole ritrovare altre risorse, tassavano tutto: e fino l’aria che si respirava, starei per dire, fu colpita da imposta, non risparmiandosi cosa alcuna.
Il preteso[7] incameramento dei beni ecclesiastici diede un magnifico pretesto alla distruzione della religione e furono visti perseguitati i preti, i frati, i vescovi e tutti coloro che fino a quel punto avevano conservato il sacro palladio della Fede, della morale, della religione.
Gli uomini di buon senso, che da principio avevano interpretato l’enigma ed avevano capito dove sarebbe andata a terminar la bisogna, fremevano fra di loro e si dispiacevano; ed anche qualche patriota di buona fede, vedendo qual era mai l’andazzo che le cose prendevano, pentitosi, quantunque troppo tardi, fece sentire la sua voce nei consigli, nelle assemblee ed anche nell’aula parlamentare si sentì alzare una generosa voce che, esponendo i veri fatti, pronosticò, se non si accomodava la faccenda, sciagura, scioglimento, sfacelo.
Però il destino di questo povero Paese, e specialmente di queste misere province meridionali, era stato deciso ed inutilmente si tentò di poter trattenere la rovina che era succeduta; e furono inutili le proteste dei popoli, specialmente delle Due Sicilie – che gridando, piatendo ed inalberando la bandiera preesistente cercarono di fare comprendere il loro desiderio di non rimanere più uniti in un affratellamento inutile, impossibile e rovinoso – ed i miseri forniti di coraggio maggiore a quello degli altri, furono perseguitati, condannati e giustiziati come vili briganti; pagarono col sangue loro l’affetto che portavano veramente alla patria e furono esecrati in terra, quantunque forse glorificati in cielo.
Le cose, arrivate ad un tal punto, fecero tanto male alla così detta causa italiana, che quantunque la forza degli avvenimenti e le baionette prussiane nel 1866 avessero fatto aggregare al già formato Regno tutta la Venezia ancora posseduta dall’Austria, pure quell’aggressione più che di gloria, come si volle dire, ci fu di vergogna, perché ci costò la perdita, ad arte succeduta, di due battaglie, Custoza e Litta, e lo spargimento di tanto sangue italiano sacrificato all’apparenza e sparso senza una precisa e vera ragione di farlo.
Ernesto, in tutto questo tempo agente segreto e prezzolato dei grandi, finché fu necessario alla setta camminò di grado in grado, di posto in posto e pervenne ai primi onori fra i suoi compagni; egli fu fermo nel suo pensiero nel primo tempo della sua fortuna pose da banda interamente la sua seduttrice e sposò la giovinetta Emilia, che con le sue grazie, col suo amore, con la sua modestia lo rendeva felice, se felicità poteva esservi mai per uno che aveva avuta tanta parte nella rovina della sua patria.
È necessario, per venire ad una conclusione del nostro racconto e dello scopo precipuo di esso, di abbandonare la narrazione dei fatti accennati, riportando il lettore ai tempi del plebiscito e precisamente al momento in cui Erminia, dopo di essere stata abbandonata da Ernesto, aveva nel suo interno giurato vendetta: la più crudele e terribile vendetta.
[1] Storpio.
[2] Sciocco, tardo d’intelligenza.
[3] Come dire: «quel ranocchio».
[4] Di vantaggio: di più, ulteriormente.
[5] Reazionari.
[6] Gli sbarrava.
[7] Il preteso: l’imposto.



 invio in corso...
invio in corso...



