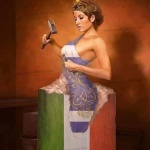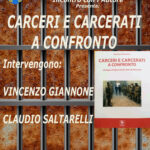La Favola delle Sirene

Fin dai tempi più antichi i vaticinii erano pronunziati con canti dalle donne.
Or le Sirene altro non furono che due di tali donne, dalle terre dell’Acheloo venute fra noi su i navigli dei Teleboi, le quali partite da un luogo famoso per i profetizzanti Cureti, approdavano ai nosti lidi, nelle cui vicinanze la negromanzia dei Cimmeri era in gran voce. Scelsero a stanza Capri, luogo marittimo, perché l’acqua credevasi dotata di profetica virtù, e in quella spiaggia predicevano ai viandanti il futuro.
E siccome l’arte del canto è dono di natura conceduto largamente agli abitanti di questa parte d’Italia, così fu detto che i vaticinii delle Sirene venivano pronunciati con tale dolcezza di voce, “… che uomo, ascoltandole, dimenticherebbe la consorte, la patria ed i figliuoli, anzi ridurrebbesi a perir di fame in lido straniero, come venne admbrato con i pulrescenti cadaveri e con le ossa di che il re d’Itaca vide biancheggiare la spiaggia delle Sirene.”.
E ciò corrisponde appunto al modo come Omero ed i mitologi rappresentano le Sirene.
Appena l’errante Greco passa loro dinanzi, già sanno che si chiama Ulisse, già conoscono le sue sventure, le sue battaglie, i luoghi dove furono combattute e con quali nemici: e questo non solo, ma quando accade su la terra – che fu poi la scienza ondi si facevan belli gli oracoli.
Ma Ulisse seppe sfuggire alle Sirene, come apprendiamo dall’Odissea – XII:
“Dopo che Ulisse ebbe dato sepoltura ad Elponore nell’isola Eea, chiamato da Circe in disparte dai suoi compagni, veniva istrutto di molti avvedimenti, con che i pericoli della navigazione avesse potuto evitare”.
Quella, tra le altre cose, dicevagli:
Delle Sirene all’isola da prima
Tu giungerai, quelle da cui rimansi
Affascinano chi ne tocchi i lidi.
Stoldo chi le Sirene appressi e ascolti!
La patria ei più non rivedrà, né in festa
Incontro gli verranno e sposa e figli;
Ma le Sirene coll’arguto canto
Lusingheranno assise in mezzo a un prato,
Dove qua e là d’umane ossa vedrai
E di putride carni ingombro il suolo.
Or tu va innanzi a tutta lena e chiudi
Con vergin cera a’ fidi tuoi le orecchie,
Perché a quel suono ingannator sien sorde.
Che se di udirlo poi desio ti punga,
Quanti sono teco all’arbor della nave
Ti leghin ritto con le mani e’ piedi,
E ad esso in cima della fune i capi
Ravvolgan si, che a te delle Sirene
La cara voce di ascoltar sia dato:
E se tu chiegga per comodo o priego
Esser disciolto, le ritorte addoppinsi.
Epperò giunto appena l’Itacense a quell’isola, esse parlavangli così:
Qui deh! T’appressa, molto chiaro Ulisse
E ad ascoltar noi due la nave arresta;
Che mai con nera nave alcun quest’onde
Non valicò senza che il dolce suono
Del nostro canto lui toccasse, e senza
Che colmo d’ineffabile diletto
E di più cose istrutto si partisse.
Conte a noi sono le sciagure tutte
Da’ Teucri sopportate e dagli Argivi,
De’ Numi per voler, là sotto Troia,
E tutto che nell’alma terra avviene.
Per indicare poi che le Sirene originavano dall’Acarnania, furono dette nate del sangue che grondò sulla terra quando Ercole ruppe il corno all’Acheloo (Euripide nell’Elena).
E da un frammento di Plutarco nei “Simposiaci” si rileva che le Sirene, perché giunte qui per mare, furono da Sofloche chiamate: Figlie di Forco che ubbidisce a Pluto.
Nei tempi di poi, l’omerico racconto perdette la semplicità natia. Le acheloiche donzelle diventarono tre, ebbero nomi significativi della bellezza, del canto e della castità, come “Telxiepea” – “Aglofeme” – “Leucosia” – “Ligea” – “Partenope” – che volevano dire “La modulatirce lusinghiera degli epici versi” – “La famosa per la voce” – “La camera” – “La bianca” – “La vergine”.
Furono chiamate figlie di Melpomene, e portarono in mano musicali istrumenti, ebbero ali per dinotare l’estro ondi si alzavano alla cognizione del futuro.
Come tutto finisce, così anche le Sirene a poco a poco scapitarono nel valore del canto, e vuolsi che osarono di gareggiar nei versi colle Muse, le quali, vintele, tarparono loro le ali per farsene ornamento alle trecce. E poscia perdettero quasi tutta la figura con cui Omero le dipinse.
E fu perciò che se i loro vaticinii riuscivano ancora graditi per soavità di melodia, erano ad un tempo involti nell’oscurità del significato. E meritarono le Sirene il nome di uccelli, di usignoli, di rondini, appunto perché inintelligibile è la voce dei volatili, e come barbara fu tenuta da’ Greci; onde “parlar come uccello”, valse presso di loro un proverbiare che non si lasciava intendere (Aristofane negli Uccelli).
L’arte poi, volendo significare in plastica o in pittura questa proprietà delle Sirene, le raffigurò col corpo di uccello e col viso di vezzosa vergine.
… Partenope la Diva,
Donzella solo il volto, il resto augello.
Alla fine, dell’isola in cui da tempo immemorabile avevano profetizzato, trasferite in altri luoghi, vi morirono. I favoleggiatori narrano che vinte da Ulisse si gettarono per rabbia in mare.
Licofrone vuole: “Partenope” morta in Napoli, “Ligea” a Terina e “Leucosia” alle sponde dell’Ocinaro.
da “Favola delle Sirene” in “Napoli Antica”
di Matilde Serao
fonte
La Favola delle Sirene | Lazzaro Napoletano – Gennaro Agrillo
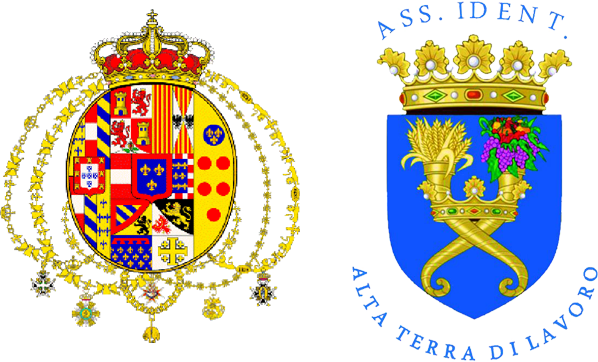


 invio in corso...
invio in corso...