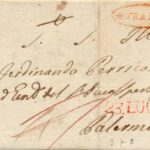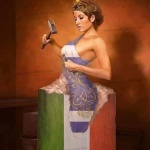La mostra a Capodimonte/La bellezza esce dai depositi e intreccia con gli spettatori una storia tutta da scrivere

Dimenticare il brutto del quotidiano.
Andare, per una full
immersion nel bello, al Museo di Capodimonte. Che non ha la
pesantezza tipica di un museo perché è una Reggia. Accogliente e ariosa, è
stata appunto costruita, nel Settecento, dal Re Borbone, per contenere opere
d’arte. E per abitarvi, contemplandole.
Oggi,
ogni visitatore può girarvi nelle sale come un Re.
La sensazione, per anni appannata, di trovarsi in una Reggia, è stata, da
qualche tempo, ritrovata per l’attenta manutenzione di cui ora è oggetto
l’edificio e per l’atteggiamento diverso del personale nelle sale, che ha
abbandonato la sciatteria disinformata di un tempo. In più, da qualche
settimana, l’illuminazione con centinaia di lampade a led ha creato, nel Salone
delle Feste, la scintillante atmosfera di una fiaba principesca.
Mentre
la “Flagellazione”, la famosa opera di Caravaggio (1571/1610) custodita qui,
in una sala tutta per sé, è ora circondata da una cornice coeva che, in
complesse fitomorfiche curve, esprime il naturalismo barocco napoletano e
storicizza l’artista, non più nume avulso dal tempo, riportandolo all’epoca
sua. Il parco (grande due volte quello di Caserta.) che circonda la Reggia
suggerisce chiaramente come l’arte si ispiri alla natura. Intorno all’edificio,
i prati ora sono ben curati e c’è la vista del mare dal Belvedere
liberato dalla siepe che ne impediva la vista.
Questa sorta di révolution heureuse
nella Reggia e nel Real Bosco riguarda
anche la strategia culturale che vi viene attuata. Attenta a non
abbassare il livello della comunicazione culturale, diversamente da quella che
ha l’unico fine di ottenere un maggior numero di visitatori, questa strategia
mira a educare il pubblico all’arte e al bello sollecitandone le capacità e
l’attenzione.
Un esempio ne è la mostra (dal 21/12/18 al 15/5/19) “Depositi di
Capodimonte. Storie ancora da scrivere”, intelligente nella impostazione,
ricca di stimoli e di idee. Una sua originale caratteristica è l’attuale
mancanza del catalogo, che sarà pubblicato al suo termine, per contenere i
pareri degli esperti che converranno in un convegno internazionale e le
osservazioni, i suggerimenti e i desideri dei visitatori.
Le 120 opere tirate fuori dai depositi (il 20 /100 circa di quelle lì
conservate) sono dipinti, ceroplastiche, gessi, marmi, tessuti e armi,
porcellane e terracotte. Tutte di pregio. Non sono presentate secondo una
successione cronologica, secondo il prima e il dopo. Ma sono collocate in modo
che si trovino vicine tra loro quelle che hanno tra loro delle analogie.
Qui si sfida anche il visitatore a trovare degli elementi in comune tra opere
diverse e, in base a questi, raggrupparle e magari scoprirne lo sconosciuto
autore. Se la prosa letteraria ha un linguaggio razionale, quindi pressappoco
univoco, l’opera figurativa, invece, è, a suo modo, polivalente. Le
somiglianze, quindi, possono trovarsi in base a diversi elementi. In base
alla materia usata, al colore, alla tecnica, al tema rappresentato, all’aspetto
che vi viene evidenziato….Ogni opera racconta una sua storia, tutta ancora da
scrivere.
Da un’ attenta osservazione delle opere si comprende anche la fallace
superficialità del detto “Non è bello quel che è bello. E’ bello quel che
piace.” Perché il Bello oggettivamente esiste. Ma piace all’osservatore
quell’aspetto dell’opera d’arte che gli è più consentaneo, e quindi più per lui
comprensibile. A questo si deve anche il criterio secondo il quale le opere
sono state mandate nei depositi, da cui ora sono state tratte per questa
mostra.
Vi sono state mandate perché non erano consentanee al gusto o al clima
politico all’epoca o alle preferenze del critico al tempo più in auge. In
proposito c’è l’eclatante esempio di Caravaggio (1593/1610), molto apprezzato
ai tempi suoi ma poi a lungo tenuto in non cale. Finché, nel Novecento, un
critico che allora andava per la maggiore, Roberto Longhi, lo riabilitò. Perché
-come ancora si dice- a suo avviso Caravaggio aveva avuto il pregio di porre in
primo piano la povera gente con i suoi piedi sporchi. Sebbene un valore
maggiore potrebbe attribuirsi alla sua cancellazione, con la resa del buio,
dello spazio canonico e la creazione, a volte, di uno spazio diverso, formato
dai movimenti delle persone. Come nelle “Sette opere di Misericordia”, la prima
opera che l’artista geniale produsse al suo arrivo a Napoli.
Tra i liberi accostamenti che in questa mostra si realizzano, c’è il
confronto ravvicinato tra i personaggi ritratti nelle opere dell’Ottocento e in
quelle del Seicento napoletano. Da cui appare chiara la diversissima
sensibilità tra le due epoche. Il sentimentalismo ottocentesco rivela lo studio
dei sentimenti, risentendo dello storicismo letterario, del positivismo e
dell’eredità del neoclassicismo. Il Seicento napoletano rivela un’abundantia
cordis irrefrenabile e la sensualità di una carnalità dirompente.
Tra le tante opere citiamo la veduta seicentesca di una irriconoscibile
Messina, che dai terremoti, epocale quello del 1908, fu travisata del
tutto. Ma, a prescindere dai luoghi, questa veduta rivela, nello stile della
composizione avvolgente, i suoi rapporti con l’arte napoletana. E ci
viene in mente Antonello (Messina 1430/1479).
Molto interesse suscitano, tra gli oggetti in mostra, anche quelli portati
in Europa dal Capitano James Cook e poi donati a Ferdinando di Borbone da
Lord Hamilton, ambasciatore inglese presso la Corte Borbonica. Sono armi, un
copricapo, una maschera di pelle e e altri oggetti provenienti dall’Oceania.
Che testimoniano il senso della bellezza e dell’arte di un popolo ritenuto
selvaggio. E suggeriscono un modo di vivere altro ma non per questo meno
felice.
Nella stessa sala, statuette in terracotta riprendono precisamente le
figure e gli abbigliamenti di popoli esotici vestiti nei loro abiti
tradizionali. Sono riproduzioni perfette. Ma poco suggestive. La conoscenza
storica è fatta anche di immaginazione. Prendendo spunto da tutti questi
oggetti, Carmine Romano, curatore della mostra insieme a Maria Tamayo e ad
altri collaboratori, tra cui Linda Martino, ha raccontato una storia su
Ferdinando di Borbone. Questi, personaggio vitalissimo, amante delle donne e
del suo popolo, con cui, quando poteva, si mischiava festaiolo, durante una
festa carnevalesca del 1748 si era abbigliato alla turca secondo una moda
esotica di fantasia. Un pittore francese, Joseph-Marie Vien (1716/1809), lo
ritrasse insieme ai suoi e portò questi dipinti a Londra. Dove i membri
dell’ambasciata turca li videro, e, rimanendone suggestionati, si abbigliarono
a quel modo di fantasia. Se l’arte copia la vita, a volte anche la vita copia
l’arte.
Le opere in mostra ritorneranno nei depositi? Sulla loro sorte non si
hanno ancora notizie precise. Mentre c’è in progetto la creazione di un altro
spazio espositivo in un grande edificio nel Real Bosco, quello che si trova di
fronte la Reggia. Ma, nel frattempo, meglio andare a visitare queste
“imperdibili” opere, prima che vadano in qualche deposito. E scompaiano alla
vista.
LA MOSTRA
Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere
Fino al 15 maggio
Per saperne di più
http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/portfolio_page/depositi-di-capodimonte-storie-ancora-da-scrivere/
Adriana Dragoni
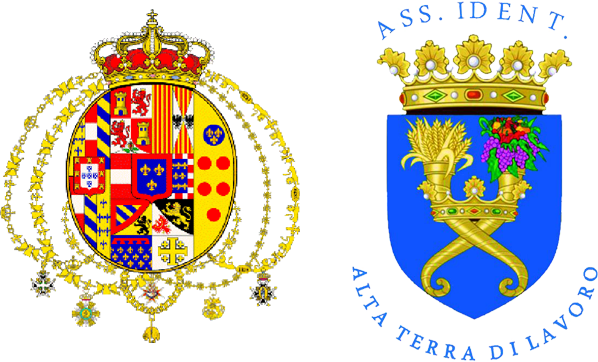


 invio in corso...
invio in corso...