La Calabria Post-Unitaria Il Brigantaggio, la Povertà e le Grandi Ondate Migratorie (II)

2) Situazione sociale ed economica della Calabria nel periodo post-unitario e le grandi ondate migratorie
Le grandi ondate migratorie hanno interessato l’intera Europa, per tutto il XIX secolo.
In Italia, l’emigrazione si manifestò a partire dalla seconda metà del XIX secolo e crebbe, in modo abnorme, fino al 1915, con la caratterizzazione di una prevalente destinazione europea per gli emigrati del Centro-Nord e transoceanica, per quelli del Meridione.
Per quanto riguarda la Calabria, l’indice migratorio della regione, fino al 1885, si rivelò molto più basso rispetto a quello della quasi totalità delle altre regioni meridionali (51.290 emigrati).
Successivamente, il ritmo di crescita dell’emigrazione fu, invece, rapidissimo, tanto è vero che, nel successivo quindicennio 1886/1900, espatriarono 224.363 persone, mentre dal 1901 al 1915 ne emigrarono 421.694[7].
Durante questo periodo, solo il Veneto superò la Calabria in questa spaventosa ondata migratoria, mentre le altre regioni restarono molto al di sotto.
Nel complesso, dal 1876 al 1915, il saldo migratorio estero fu pari a 697.347 unità[8], cioè circa il 50% dell’intera popolazione.
Le due più grandi ondate migratorie, fuori dal territorio nazionale, di tutte le regioni italiane, riguardarono, la prima il periodo 1904-1907, con una punta nel 1905 e la seconda, il triennio 1912-1914, con una punta nel 1913.
Entrambe queste ondate trovano, nel rapporto espatri-popolazione, la Calabria in testa: quella del 1904-1907, la vede al primo posto con 202.085 emigrati (62.290 nel 1905) e quella del 1912-1914, al terzo posto con 127.429 emigrati (55.910 nel 1913), preceduta dagli Abruzzi e dalla Sicilia.
Molti studiosi hanno annoverato, tra le cause di questo fenomeno, anche il carattere emotivo ed avventuroso del calabrese[9].
Esaminando l’ampiezza del flusso migratorio all’interno della regione, e, in particolare, a livello provinciale, si nota che la provincia di Cosenza fu quella che diede il contributo di gran lunga maggiore all’emigrazione, seguita da Catanzaro e da Reggio Calabria.
In merito alla destinazione, l’emigrazione calabrese si caratterizza, rispetto a quella del resto d’Italia, perché spiccatamente transoceanica.
A livello nazionale, il numero degli emigrati transoceanici, in valore assoluto, balza da 328.231 persone, durante il periodo 1880-1885, a 1.928.161, durante il sessennio 1910-1915.
Più specificamente, i censimenti, a partire dal 1881, registrarono un numero sempre maggiore di italiani assenti, in quanto residenti all’estero al momento del censimento, per raggiungere dimensioni colossali proprio in conseguenza dell’emigrazione transoceanica.
Infatti, nel 1881, gli italiani all’estero furono poco più di un milione e, nel 1891, sfiorarono i due milioni; nel 1901 salirono al di sopra di tre milioni e mezzo e nel 1911 furono quasi sei milioni[10], di cui 4.894.532 verso i Paesi transoceanici e 910.568 verso i Paesi europei[11].
L’esplosione vera e propria dell’emigrazione transoceanica, però, si ebbe nel Mezzogiorno e, più particolarmente, in Calabria, dove, nel decennio 1876/1885, emigrarono 51.290 persone, mentre, nel quindicennio 1901/1915, gli emigrati furono 421.694.
Nessun’altra regione italiana toccò questi livelli, nel rapporto tra emigrati e popolazione.
A sottolineare l’enormità delle dimensioni dell’emigrazione transoceanica calabrese basta ricordare che, dalla sola Calabria, partirono, oltreoceano, più lavoratori che dall’intera Italia centrale.
Infatti, tra il 1880 e il 1915, varcarono l’oceano, in cerca di lavoro, ben 870.670 calabresi, mentre dall’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche e Lazio), nello stesso periodo, emigrarono, oltre oceano, 757.236 persone[12].
L’emigrazione dalla Calabria, per esser quasi esclusivamente transoceanica, ha portato ad un depauperamento umano maggiore rispetto a tutte le altre regioni italiane dove l’emigrazione fu quasi esclusivamente o prevalentemente, europea.
Valutando il numero dei rimpatriati dai Paesi transoceanici, dal 1905 al 1915, e confrontandolo col numero di emigrati oltre oceano dello stesso periodo, si nota come i rimpatri, in percentuale, siano molto meno frequenti in Calabria, rispetto al resto d’Italia.
Infatti, durante tale periodo, rispetto a 4.760.000 italiani emigrati, ne sono ritornati 2.520.000 (52,7%); dalla Calabria, invece, sono partiti, sempre nello stesso periodo, 456.780 emigrati, di cui sono ritornati 181.411 (39,7%).
Per quanto riguarda i Paesi di destinazione, l’emigrazione calabrese si riversò, quasi per intero, nelle Americhe, soprattutto in Brasile, Argentina e Stati Uniti, mentre verso l’Asia e l’Oceania fu praticamente nulla: la sua punta massima fu di 150 emigrati nel 1910[13].
Per quanto riguarda l’emigrazione in Europa, essa si è sempre concentrata su Francia e Svizzera; unica eccezione si ebbe nel 1902, quando dei 3.608 calabresi emigrati in Europa, ben 1.586 si diressero verso l’Austria[14]. L’emigrazione verso l’Africa toccò la punta massima, nel 1882 e nel 1885, con circa 2.300 emigrati. La destinazione prevalente agli inizi è l’Algeria, spostatasi, poi, verso l’Egitto e la Tunisia[15].
Circa l’emigrazione verso le Americhe, c’è da osservare che i calabresi, nei primi anni si dirigevano, in prevalenza, verso il Brasile e l’Argentina; poi, intorno al 1890, verso gli Stati Uniti, con una contrazione tra il 1894 e il 1900, per poi affermarsi, definitivamente, come corrente prevalente fino al 1915, con la conseguente riduzione percentuale degli emigrati verso il Brasile e l’Argentina.
Tale tendenza generale dell’emigrazione regionale non si riproduce nelle correnti direzionali dell’emigrazione delle tre province.
Ad esempio, l’emigrazione cosentina fu, soprattutto, orientata verso l’Argentina e, in misura lievemente minore, verso il Brasile.
L’emigrazione verso gli Stati Uniti d’America segna un certo incremento nel periodo 1882-1893[16].
L’emigrazione catanzarese si orientò, inizialmente, verso l’Argentina e gli Stati Uniti; dal 1893 in poi, si ridusse la prima e si consolidò la seconda, mentre crebbe anche quella verso il Brasile[17].
L’emigrazione reggina, agli inizi, segue la stessa direttrice di quella catanzarese, con prevalenza verso l’Argentina e gli Stati Uniti; il Brasile è del tutto ignorato fino al 1885 e anche negli anni successivi non attirerà molti emigrati da questa provincia. Dal 1893, si estende la corrente diretta verso gli Stati Uniti.
Spesso nelle grandi città americane si concentrava un così alto numero di calabresi, talvolta provenienti tutti dallo stesso Comune, che potevano occupare un intero rione, dove facevano rivivere le tradizioni del Paese d’origine, per mitigare la nostalgia della propria terra.
Circa le cause profonde ed essenziali dell’emigrazione calabrese, molto si è detto e scritto[18].
Noi riteniamo che la causa fondamentale dell’emigrazione calabrese e, più in generale meridionale, sia da ricercare nei profondi cambiamenti provocati dall’Unificazione d’Italia[19].
Il passaggio dal regime borbonico al nuovo Stato determinò, infatti, la rottura del vecchio equilibrio economico-sociale (un equilibrio basato su una struttura patriarcale e feudale, ma pur sempre un equilibrio), senza, però, essere sostituito con un nuovo e soddisfacente assetto.
Inoltre, l’estensione, tout court, nelle regioni dell’ex Regno delle due Sicilie, della legislazione vigente nel Regno del Piemonte (in particolare, quella fiscale), realizzata con le cinque leggi Bastogi[20], emanate tra il 1861 e il 1862, aggravò, notevolmente, le condizioni economiche del Meridione e scatenò una vera e propria ostilità nei confronti del nuovo Stato unitario.
La popolazione meridionale non era abituata a questo tipo di pressione fiscale, in quanto i Borboni si erano ispirati, nel sistema di governo, ad una gestione patriarcale di uno Stato sostanzialmente immobilista, in quanto, essendo ridotti al minimo gli oneri pubblici per i servizi, la difesa e l’amministrazione, la mano del fisco non era pesante.
Sebbene l’obiettivo dei Borboni non fosse quello di alleviare le pene dei sudditi, tuttavia, avevano abituato la gente a convivere con la loro povertà e, molto spesso, con la loro miseria senza però, opprimerli anche con un sistema di tassazione estremamente gravoso.
Il Piemonte, invece, poiché si avviava verso la trasformazione e l’ammodernamento, allo scopo di raggiungere una certa posizione di prestigio tra le potenze europee, si vedeva costretto ad esercitare una dura pressione fiscale in tutta Italia[21], ritenuta l’unico mezzo per recuperare il disastroso deficit della finanza pubblica.
La necessità di costruire ponti, strade, ferrovie ed altri grandi infrastrutture, creò momenti drammatici per le pressanti preoccupazioni derivanti dalla critica situazione finanziaria del nuovo Stato.
Bisogna, infatti, tener presente che il nuovo Regno d’Italia dovette accollarsi anche il deficit degli Stati annessi. Le finanze non potevano certo fare affidamento sull’agricoltura, ancora arretrata, né sulle poche e primitive industrie (che pure esistevano nel nord) o sugli scarsi e limitati commerci.
Così, estendendo a tutte le regioni il sistema piemontese, si ebbe un’acutizzazione improvvisa del peso fiscale che rimase inspiegabile per la gran parte dei cittadini.
Si pensi, ad esempio, quanto dovette apparire assurdo ed illogico ai calabresi che, alla morte del proprio genitore, per ereditare la terra o la casa, dovevano pagare una tassa dello 0,55% del valore[22].
Era questa una situazione inaccettabile per la gente delle campagne, in quanto essa non riusciva a comprendere perché si dovessero pagare dei soldi allo Stato, nel momento in cui la “roba” passava dai padri ai figli[23].
Con i dazi, le tasse sul macinato e gli aumenti del prezzo del sale, si aggravò, ulteriormente, la situazione generale, provocando il risentimento delle popolazioni e creando nuove difficoltà alla stessa economia[24].
In questo contesto, le masse popolari assistevano, con grande diffidenza, a questi cambiamenti che, ai loro occhi, si presentavano non solo sotto la forma dell’aggravio fiscale, ma anche quali cause della mancanza di lavoro e dell’acutizzarsi delle loro condizioni di miseria per la staticità di salari, mentre il costo della vita saliva.
Per meglio comprendere, perciò, il grande fenomeno dell’emigrazione, specialmente a partire dall’Unità d’Italia, è necessario avere cognizione, sia pure in modo sommario, della situazione sociale ed economica della Calabria postunitaria che, unitamente alla Basilicata, era ritenuta la regione più arretrata di tutto il Mezzogiorno.
Secondo le relazioni prefettizie delle tre province, la società calabrese continuava, sempre più, a regredire: un sistema sostanzialmente feudale perpetuava il privilegio di pochi, a danno, naturalmente, delle masse rurali.
La vita pubblica della Calabria era caratterizzata da un diffuso analfabetismo, dalla grande arretratezza della classe contadina, da una profonda miseria, dall’odio contadino per i ricchi, dall’orgoglioso distacco di questi ultimi dalle masse rurali, dalla mancanza di capitali da investire nell’agricoltura e dal massiccio fenomeno dell’usura che corrodeva sia i patrimoni dei ricchi assenteisti, sia le magre risorse dei più poveri.
La distribuzione della proprietà calabrese era concentrata nelle mani di poche famiglie, il cui scopo era quello di ingrandire sempre più il loro patrimonio, trascurando, invece di migliorare, le coltivazioni delle terre possedute.
Inoltre, le classi sociali più agiate che, altrove, costituivano la borghesia attiva, nonché una delle maggiori forze della società, in Calabria, invece, si erano trasformate in un “nobilato”, il cui unico desiderio era quello di allontanarsi dalla campagna, in quanto non essendoci più condizioni di vita per loro “sufficienti”, specialmente, dopo la politica fiscale imposta dal Regno d’Italia.
Il latifondo, pertanto, ostacolava lo sviluppo della regione e produceva l’inquietante fenomeno del bracciantato, costretto alla disoccupazione o a subire, per un salario di fame, i soprusi e i ricatti degli addetti al reclutamento della manodopera.
Peraltro, l’elevato spezzettamento della proprietà rendeva estremamente precaria la vita di quanti non riuscivano, nonostante gli sforzi, a ricavare dalla terra nemmeno l’indispensabile per vivere[25].
Così, anche se l’aspirazione del contadino calabrese era sempre stata quella di possedere un pezzo di terra nella quale poter ravvisare «la soluzione del problema del pane quotidiano»[26], in quelle condizioni di miseria e sfruttamento, non era possibile sopravvivere.
Le tecniche agricole diffuse in Calabria erano, infatti, tutt’altro che moderne: mancavano bestiame, idonei mezzi di fertilizzazione del suolo, case rurali ecc..
Il binomio terra-manodopera non era fatta solo di povertà materiale, ma di tutti quei corollari che, solitamente, accompagnano le precarie condizioni di vita di un popolo[27].
Ad aggravare questo stato di cose, durante il periodo 1888-1894, fu la gravissima crisi economica che colpì l’intero Paese, coinvolgendo quasi tutti i settori produttivi, incluso il sistema bancario, e determinando, così, il progressivo deprezzamento dei prodotti della terra e la drastica riduzione della domanda di lavoro in agricoltura.
“La classe lavoratrice, dunque, si aggirava in un dedalo di miserie da cui le era impossibile uscire: non trovava lavoro a giornata perché il proprietario o l’affittuario non avevano più convenienza a far lavorare terreni — soprattutto quelli coltivati a cereali — che rendevano poco o nulla […]. Migliaia di famiglie languivano stremate dalla fame, per cui erano sempre più le popolazioni costrette a trovare altrove, e specialmente all’estero, i mezzi della loro sopravvivenza”[28].
Alcuni prefetti della Calabria, in risposta ad una iniziativa del Ministero dell’Agricoltura dell’epoca[29], finalizzata a meglio conoscere le condizioni di vita dei braccianti e l’indice di produzione delle terre demaniali e dei latifondisti, sottolineavano come la mancanza di capitali da impiegare nella bonifica dei fondi e/o nel perfezionamento delle colture, la quasi inesistenza del credito agrario e fondiario, i gravi balzelli che pesavano sull’agricoltura e le difficili condizioni commerciali riducevano la manodopera, costringendo gli stessi coltivatori dei demani comunali ad abbandonare le terre.
“I contadini emigrano numerosi”, essi sostenevano, “non vogliono accettare il lavoro che troppo scarsamente, ed anche mal retribuito, ad essi offrono i proprietari. Così, la popolazione rurale si dirige all’estero o in cerca di lavoro più equamente retribuito o per trovare migliore fortuna e l’emigrazione assume sempre più estese proporzioni”.
“Non è invero la mancanza di terreno da coltivare che obbliga i nostri contadini ad abbandonare la patria, sono invece, in gran parte, i salari che diminuiscono e la crisi che investe man mano le campagne”[30].
In effetti, si verificava il paradosso che, alla riduzione dei salari, i prezzi dei generi di prima necessità andavano, costantemente, aumentando.
Gli stessi contratti agrari miravano soltanto allo sfruttamento dei contadini i quali, anche a causa dell’aumento notevole della natalità, erano costretti a trovare migliori condizioni di lavoro in altri luoghi.
“A risollevare efficacemente l’agricoltura, se le circostanze presenti del paese lo permettessero”, sostenevano i prefetti nelle loro relazioni, “gioverebbe l’impiego di molti milioni in lavori di bonifica nei non pochi terreni paludosi”[31].
“Opportuno sarebbe eccitare lo spirito di associazione fra proprietari di terreni incolti, dimora perenne di febbri, acché uniti in consorzio, diano mano, in piccole proporzioni, ad opere di bonificazione e di miglioramento, stabilendo all’uopo appositi premi e distinzioni”[32].
“Solo in questo modo si potrebbe porre un argine all’invadente emigrazione, che toglie al paese, colla gioventù più robusta, i più validi braccianti ed agricoltori”[33].
Purtroppo, la classe dirigente postunitaria non comprese o non volle comprendere la diversità del Sud, nei confronti del quale sarebbe stato opportuno varare programmi specifici, diretti a sbloccare una situazione aggravata dalla legislazione in materia fiscale, con interventi settoriali capaci di tenere, nel dovuto conto, l’arretratezza del Meridione.
Invece, l’aggravio fiscale non colpì solo l’economia agricola ma determinò delle profonde ripercussioni negative, anche nel debole tessuto industriale delle regioni meridionali.
Infatti, nel Mezzogiorno e in Calabria, esisteva, prima del 1860, un certo numero di industrie, soprattutto filande seriche e di cotone, modesti stabilimenti per la lavorazione dei prodotti agricoli.
Si trattava, in effetti, di piccole aziende che sfruttavano, come fonte energetica, i corsi d’acqua e, come manodopera, soprattutto le donne, retribuite in ragione del 50% della retribuzione degli uomini.
Erano, quindi, tali piccole industrie, distribuite quasi ovunque, che sopperivano ai consumi del mercato interno, protette con dazi che arrivavano fino all’80%[34].
Purtroppo, la nuova politica economica, varata dopo l’Unità, con il drenaggio di capitali attraverso la vendita dei beni demaniali ed ex ecclesiastici, la concentrazione della spesa pubblica nel Nord (per far fronte alle esigenze di una prevedibile imminente guerra contro l’Austria) e, soprattutto, la politica doganale[35] determinarono il quasi totale fallimento di questo “microsistema di sopravvivenza” che caratterizzava il fragile tessuto economico-produttivo della regione.
Ad esempio, con la legge del 30 giugno del 1860, che abbassava i dazi doganali, si colpì doppiamente il Mezzogiorno: anzitutto, perché l’esportazione dei prodotti agricoli provocò, oltre all’aumento del prezzo del pane e dei generi di prima necessità, una spinta a proseguire nelle colture estensive cerealicole; in secondo luogo, perché l’importazione di prodotti industriali esteri, a basso prezzo, danneggiava, anche se non direttamente, l’industria meridionale abituata, come già detto, alla protezione di dazi fino all’80%.
L’industria del Nord, invece, non ne risentiva, in quanto la sua produzione, oltre ad essere assorbita dalla domanda locale, era proiettata in un mercato diventato molto più ampio dopo l’unificazione[36].
L’industria meridionale, colpita così duramente proprio nel momento in cui doveva lanciarsi sul piano dell’ammodernamento (sostituzione delle ruote mosse ad acqua con le macchina a vapore, abbandono dei borghi e conseguente concentrazione ed espansione verso i grandi centri, applicazione di nuove tecniche), si chiuse in se stessa, continuando, per qualche anno, a sopperire ancora alle esigenze di un mercato chiuso, caratterizzato dall’autoconsumo e cominciando, di conseguenza, a morire[37].
A questa situazione, bisognava aggiungere, oltre all’altissimo livello di analfabetismo (l’87% di tutta la popolazione regionale, nel 1871, era analfabeta)[38], lo stato di generale degrado dei servizi civili, in termini di abitazioni, scuole e acquedotti.
Così riferivano alcuni prefetti:
“Le condizioni civili ed igieniche dei paesi erano inverosimilmente arretrate, mancando, oltre che le scuole e le strade, le fognature e gli acquedotti: il rifornimento di acqua potabile veniva fatto dalle donne con barili ed altri recipienti trasportati sulla testa, o sui fianchi, presso le magre sorgenti distanti dall’abitato talvolta più di un chilometro; la lavatura dei panni era effettuata, sempre dalle donne, che generalmente camminavano scalze, nelle “fiumare” raggiungibili per lunghi ed impervi sentieri”[39].
“Deposito di ogni sorta di immondizie sono le pubbliche strade che dalle amministrazioni comunali nelle circostanze ordinarie non si fanno mai spazzare; anzi si tollera che ogni cittadino faccia dei cumuli di concime presso la soglia della propria casa, stalla o porcile e li lasci lì a fermentare per tempo parecchio”[40].
“Nelle abitazioni erano diffusi la promiscuità umana e con gli animali ed il sovraffollamento più gravi”[41].
“In genere, in una stessa stanza dormivano tutti i membri della famiglia in due grandi letti: in uno i genitori con i figlioletti più piccoli e nell’altro i figli, maschi e femmine, anche se già grandi”[42].
“Poche abitazioni hanno i cessi e lo sbocco dei pochi corsi luridi si apre in vicinanza delle mura, su terreno attiguo e allo scoperto: larga la costumanza generale di scaricare il ventre nelle pubbliche strade. . .” [43].
“Il servizio sanitario da parte dei comuni era completamente trascurato, per cui si diffondeva rapidamente la sifilide; il vaiolo serpeggiava e faceva stragi maggiori in quei paesi dove la vaccinazione era stata trascurata, l’angina difterica per anni affliggeva le popolazioni senza accennare ad esaurirsi, imperversava l’infezione tifosa. Piaga dolente la malaria, che rendeva impraticabili proprio le poche pianure che avrebbero potuto dare i più alti redditi agricoli”[44].
“Scarse, male attrezzate e poco frequentate le scuole elementari. I ragazzi ben raramente frequentano la scuola: prima dell’età di 12 anni vengono addetti alla custodia e guardia degli animali domestici. Dall’età di 12 anni in poi si addicono alla cultura con la zappa. In genere le scuole sono sfornite di cesso, e i ragazzi per soddisfare ai propri bisogni naturali escono con permesso”[45].
Basta solo questo per rendersi conto della gravità della situazione sociale ed economica della Calabria, nel momento della costituzione del Regno d’Italia.
Certo, l’arretratezza e la miseria della Calabria, denunciate tra l’altro, dalle famose inchieste promosse dallo Stato italiano post-unitario e interpretate dai meridionalisti, non erano mali recenti da addebitare, esclusivamente, al malgoverno o allo sfruttamento programmato dai “nordisti”.
Esse, infatti, affondavano le loro radici nel passato e testimoniavano, di conseguenza, il dramma di un popolo da sempre angariato dai potenti e dall’avarizia di una terra peraltro mai “addomesticata” dalla tecnologia e da sostanziosi investimenti di capitali.
Basti ricordare che la rapacità dei funzionari locali, poco o per nulla controllati dalle autorità centrali, e la rigida struttura economica che non consentiva mutamenti di condizione, non lasciavano spazio alla speranza di una congiuntura che favorisse, in qualche modo, il superamento dello stato di estrema povertà in cui, da secoli, la maggior parte della popolazione viveva.
Tutto questo, però, non assolve la classe politica dell’epoca che, di fronte a tali situazioni, si dimostrava quasi indifferente e per nulla interessata a ricercare strategie adeguate, al fine di poter ridurre la gravità dei problemi che assillavano tutte le regioni del Mezzogiorno.
Anzi, la classe politica, per motivazioni sostanzialmente diverse, aggravò il divario tra Nord e Sud.
Infatti, mentre la Destra, per le caratteristiche dei suoi uomini più rappresentativi, tendeva a favorire i grandi proprietari terrieri, la Sinistra, propendeva per l’insediamento di nuovi investimenti industriali senza, però, individuare un vero e coerente pacchetto d’interventi, specialmente a causa della mancanza di risorse finanziarie, visto il grosso indebitamento pubblico del bilancio dello Stato.
Le masse popolari, in particolare quelle calabresi, non avevano alcun mezzo o strumento organizzativo per opporsi a tale stato di cose. La classe dirigente dimostrava un’ostinata insensibilità a tali problemi, anche a livello locale[46], dove gli amministratori comunali, i dirigenti dei Comizi Agrari[47] e gli amministratori provinciali, non solo non promuovevano alcuna iniziativa che potesse alleviare queste gravi condizioni, ma si mostravano sordi e restii a fornire le risposte alle varie inchieste, promosse dai Ministeri.
Questo immobilismo nell’organizzazione sociale e nella capacità di reagire al conservatorismo più assoluto contribuì, in modo determinante, a lasciare il paesaggio agrario calabrese pressoché immutato, fino ai primi decenni del XX secolo, atteso che, tra l’altro, i pochi grandi proprietari, gelosi dei privilegi di cui godevano, non erano per nulla disposti ad operare trasformazioni capaci di promuovere uno sviluppo razionale dell’economia regionale e di creare condizioni di vita migliori per i lavoratori della terra.
La mancanza di tradizioni associative e di lotta di classe delle masse calabresi non permetteva, altresì, di dare soluzione di continuità a questo immobilismo storico; anche le agitazioni contadine verificatesi nella regione, furono la conseguenza di tentativi isolati, caratterizzati da inefficiente organizzazione.
Fino alla vigilia del ’900, infatti, non esistevano organizzazioni politiche o sindacali dei lavoratori[48] ed erano state organizzate solo poche società di Mutuo Soccorso[49].
Solo verso la fine del secolo XIX cominciò ad enuclearsi, faticosamente, qualche primo germoglio di organizzazione.
Ma questo non fu sufficiente per ridurre l’emigrazione dei calabresi, non solo verso le terre transoceaniche, ma anche verso l’Europa (Francia, Germania, Svizzera, Belgio)[50].
Nel periodo compreso tra gli anni 1876-1895 gli emigrati calabresi oltreoceano rappresentavano il 90% dell’intera emigrazione estera.
Fino al 1880, come già sottolineato, il fenomeno non aveva assunto dimensioni di rilievo[51].
Infatti, l’inchiesta Jacini[52] diceva dei calabresi che essi “benché le condizioni dei salari e del vivere, in generale, fossero assai inferiori a quelle della Basilicata, o non si mossero punto o pochissimo….” .[53]
Solo a partire dal 1885, l’emigrazione assunse dimensioni notevoli, crescendo, gradualmente, fino all’imponente fuga che caratterizzò i primi anni del ‘900.
Se, comunque, l’emigrazione, specialmente in Calabria, rappresentò l’unica ancora di salvezza per una classe sociale, giunta ormai al limite della sopportazione, tuttavia, essa ha ridotto l’accrescimento demografico regionale, determinando un processo d’invecchiamento della popolazione, nel tempo, sempre più vistoso[54].
Pertanto, dal primo censimento del 1861 a quello del 2001 la popolazione calabrese è aumentata dell’1,74%, passando da 1.155.000 abitanti a 2.011.466[55],mentre, nello stesso periodo, la popolazione meridionale si è più che raddoppiata, passando da 9.632.000 a 20.515.000[56].
Tale dinamica è stata, dunque, condizionata dalle forti perdite migratorie che ne hanno frenato il ritmo di crescita.
Solo con il blocco dell’emigrazione imposta dal fascismo, la Calabria registrò un incremento demografico, tra il 1922 e il 1942[57], pari al 25,6%[58].
In questo ventennio, infatti, il saldo migratorio con l’estero fu pari a 99.938 emigrati e costituì appena il 23,6% rispetto al decennio 1901/1915, il cui saldo migratorio netto fu pari a 421.694 unità.
Dopo la seconda guerra mondiale, il movimento migratorio verso l’estero cominciò a riprendere in modo consistente, tant’è che, già durante il periodo 1946/1954, il saldo migratorio negativo con l’estero era pari a 165.044 emigrati.
Agli inizi degli anni ’50, poi, il volume dell’emigrazione dalla regione aumenta in modo allarmante, in quanto agli espatri oltreoceano, si aggiungono le “migrazioni interne” extraregionali.
Per quanto riguarda le migrazioni interne, esse cominciano a prendere consistenza, con “poco più di 12 mila cancellazioni anagrafiche in media all’anno”, in termini di saldo migratorio”[59], nel periodo 1955/59.
Anche il saldo migratorio con l’estero, durante questo periodo, subisce un’impennata negativa, con una media di oltre 19.000 unità all’anno.
Nel successivo quinquennio 1960-64, l’emigrazione interna calabrese (e quella meridionale, in generale) continua a crescere in modo allarmante, tant’è che il saldo migratorio della Calabria sfiora le 30.000 unità in media all’anno[60].
A livello di saldo migratorio estero, nelle stesso periodo, la media annua si avvicina alle 18.000 persone, mantenendo lo stesso trend del quinquennio precedente.
In seguito e fino alla crisi petrolifera del 1973, il saldo migratorio interno della Calabria si mantiene ancora elevato, tra le 19.000 e le 20.000 unità in media all’anno[61], mentre quello estero comincia a subire delle flessioni notevoli, con una media annua di circa 8.000 unità che si riducono, ulteriormente, negli anni successivi[62].
Dal 1955 al 1974 si registra un saldo migratorio estero (espatri-rimpatri) pari a 264.000 persone, mentre in termini di emigrazione interna, nello stesso periodo, il saldo è pari a 409.000 persone.
Dopo la crisi petrolifera, durante il periodo 1975/89, il saldo estero è pari a 42.000 emigrati, mentre quello interno e di 106.000 emigrati.
Dal 1990 al 2000, si registra una tendenza discendente molto marcata per il saldo migratorio estero (20.000 persone) e più contenuta per quella interna (99.400).
Dal 2000 al 2005, sia il saldo estero che quello interno, praticamente si dimezzano, passando, il primo a 10.700 unità ed il secondo a 41.900.
Nel complesso, sulla base delle elaborazioni Svimez sui dati Istat[63], si calcola che, dal 1955 al 2005, il saldo migratorio dalla Calabria verso le altre regioni italiane è stato di circa 652.000 persone.
Se, a questa cifra, aggiungiamo il saldo migratorio estero[64], pari a 334.000 unità, abbiamo una emigrazione complessiva, nel periodo 1955/2005, che si aggira intorno ad un milione di emigrati (986.000).
Questi ultimi, sommati a quelli registrati, sempre in termini di saldo migratorio (espatri-rimpatri), durante il periodo 1876/1954, pari a 1.015.397 unità, abbiamo, nell’intero arco degli ultimi 130 anni (1876/2005), un valore complessivo di emigrati calabresi verso gli altri Stati e nelle altre regioni italiane pari a 2.001.397 persone, di cui 1.344.397 verso l’estero.
Se a questi dati aggiungiamo, poi, quelli relativi al periodo 2006/2010, possiamo affermare che l’emigrazione dalla Calabria verso le altre regioni italiane è stata pari a 35.116 unità, con una media annua di oltre 7.000 emigrati[65]; mentre, per il saldo migratorio estero, la tendenza, durante lo stesso periodo si presenta positivo, con una tendenza media di circa 4.000 persone all’anno[66].
In sintesi, possiamo affermare che, dal 1876[67] al 2010, il totale degli emigrati calabresi verso l’estero e verso le altre regioni italiane, è stato di 2.015.000 persone, cifra superiore alla popolazione residente nella regione, nell’ultimo anno di riferimento (2.011.466).
In questo contesto, negli ultimi sessant’anni la popolazione calabrese si è mantenuta praticamente stabile, intorno ai 2 milioni di abitanti, in considerazione del fatto che, fino agli anni ’70, l’alto tasso migratorio compensava l’alto indice di natalità.
Successivamente, sia l’uno che l’altro hanno subito una flessione costante che ha mantenuto l’indice di popolazione praticamente stabile[68], anche se i dati provvisori, relativi al censimento Istat 2011, registrano un calo della popolazione pari al 2,7% (da 2.011.466 a 1.956.830 residenti).
Se approfondiamo l’analisi di alcuni fenomeni inerenti al processo emigratorio calabrese, possiamo constatare che se la popolazione attiva calabrese in agricoltura rappresentava, nel 1951, il 63,9% e nel 1971 il 34,9%, ci si rende conto, immediatamente, dell’enorme numero di braccianti, contadini poveri, disoccupati e sottoccupati che ha abbandonato i campi e la propria regione per andare a lavorare in Svizzera, Germania, Belgio, Olanda o nel triangolo industriale, Genova-Torino-Milano e nel Nord dell’Italia.
I dati Istat confermano la consueta tendenza dei calabresi ad emigrare nel Piemonte, in Lombardia e nel Lazio a cui si sono aggiunte, negli ultimi anni, nuove regioni, quali l’Emilia Romagna e la Toscana.
A questo proposito, occorre sottolineare che, tra il 2000 ed il 2010, sono emigrati dalla Calabria 31.049 giovani, tra i 20 ei 40 anni, il numero più alto tra le regioni italiane, dopo la Sicilia (40.281).
Pertanto, negli ultimi anni si è verificato un importante fenomeno che contrasta, completamente, con la tradizionale immagine dell’emigrato calabrese.
I “nuovi” emigrati calabresi hanno studiato e cercano un lavoro rispondente al titolo di studio conseguito.
Bastano questi dati per affermare, senza timore di essere smentiti, che neanche l’intervento straordinario e la politica regionale sono riusciti a frenare l’emigrazione dei calabresi che, oggi, coinvolge, in particolare, la manodopera intellettuale, senza alcuna prospettiva di trovare lavoro, in una regione con un tessuto produttivo sempre più debole e con un “sistema impresa” quasi inesistente.
Questo significa che l’emigrazione pre-universitaria viene incrementata da quella post-universitaria in cerca di occupazione con due conseguenze negative: trasferimento di risorse dal Sud al Centro Nord per il mantenimento dei figli a scuola, da parte delle famiglie meridionali e svuotamento del sistema territoriale e sociale delle risorse umane giovani e più qualificate.
Una delle cause principali di tutto questo è costituito da un sistema di transizione scuola-lavoro inadeguato e distorto, legato alle responsabilità delle Istituzioni che hanno sottovalutato e non considerato, adeguatamente, l’importanza strategica della complementarità e funzionalità tra formazione e/o specializzazione universitaria e dinamica del contesto produttivo e del sistema sociale.
Basti pensare che, in questi ultimi anni, secondo le indagini Istat, i laureati meridionali, a tre anni dalla laurea, occupati in regioni del Centro Nord, sono aumentati di oltre il 10%.
Una simile situazione sta provocando un invecchiamento sensibile della popolazione regionale
Secondo le statistiche più accreditate, nel 2030, una persona su dieci avrà più di 65 anni ed una su dieci più di 80 anni.
Soltanto un calabrese su tre avrà meno di 40 anni ed i giovani sotto i 17 anni scenderanno al 17%[69].
La figura del vecchio emigrato, analfabeta o quasi, disposto a fare i lavori più umili e faticosi, è completamente sparita, i nuovi emigrati sono in gran numero diplomati e laureati.
La Calabria e il Mezzogiorno perdono, così, le loro forze migliori e le famiglie, dopo aver speso cifre considerevoli in istruzione, sono costrette a vedere i loro figli partire, mentre la regione diventa sempre più povera di vitali energie intellettuali, indispensabili per il suo decollo economico.
“Se storicamente erano gli emigranti , giovani o meno giovani, che inviavano rimesse alle famiglie di appartenenza, oggi sono sempre più le famiglie di appartenenza che sostengono i giovani nella loro esperienza migratoria che è spesso svolta in condizioni di precarietà lavorativa e con redditi insufficienti, anche in considerazione dell’elevato costo della vita, in particolare per l’alloggio”.
“Va aggiunto che la debolezza del tessuto produttivo locale, la mancanza di politiche economiche adeguate, e la scarsissima spesa per le politiche sociali, a livello regionale, rende ancora più difficoltosa la gestione dei nuovi rischi sociali e la tutela di categorie deboli come gli anziani, i bambini ed i giovani, accentuando le difficoltà di formazione della famiglia e la crisi della natalità.
Il declino della popolazione calabrese, da questo punto di vista, dunque, appare allo stato inarrestabile.
Oltre a ciò, la Calabria, al pari del Sud, mostra una scarsissima capacità di attrazione dei flussi immigratori dall’estero, i quali laddove si sono consolidati hanno rappresentato un fattore di innovazione e di stimolo alla crescita economica” [70].
Una Calabria vecchia, quindi, con una economia povera, con risorse insufficienti per gestire un’assistenza sociale di ampia portata e con un sistema produttivo indebolito da una domanda espressa da una popolazione, prevalentemente, non giovane.
Si tratta di un circolo vizioso che confina sempre più la Regione verso una “frontiera di periferia” che rischia di sconvolgere tutte le regole di un sistema civile.
Basta ricordare che, dalla ricostruzione ad oggi, le distorsioni, determinate da un’errata politica economica nazionale e regionale (che ha condizionato anche la programmazione comunitaria), hanno provocato una quasi totale dipendenza del sistema economico-produttivo regionale dalla politica pubblica e che, oggi, contribuisce, per il 75%, alla produzione del reddito regionale.
In questo contesto, sulla base delle analisi e delle previsioni effettuate dai più importanti Istituti nazionali ed internazionali in materia di andamenti congiunturali (Eurostat, Istat, Svimez, Bankitalia, CCIA, Unioncamere, Censis, Enea, Cnel, ecc.), negli ultimi dodici anni, in Calabria si continua a registrare un forte rallentamento della crescita regionale, persino in controtendenza con le regioni del resto dell’Unione Europea, all’interno dell’Obiettivo Convergenza.
L’emigrazione, pertanto, diventerà, come è sempre stato finora, la grande valvola di sfogo di una regione destinata a diventare più povera e più vecchia se le Istituzioni, la Scuola, la Famiglia, l’intera Società Civile e la Chiesa non si stringono insieme in un “patto per la Calabria”, attraverso il quale l’etica, la legalità, le regole ed i valori comuni possano diventare gli strumenti per l’avvio di un processo di discontinuità, rispetto alla situazione attuale, caratterizzata da stagnazione ed immobilismo.
[1] Vincenzo Padula, “Il brigantaggio in Calabria, 1861/1864”, Padula Editore, 1981
[2] Luigi Miceli (Longobardi<CS>, 7 giugno 1924 – Roma, 30 dicembre 1906) fu deputato, senatore e, cinque volte, Ministro del Regno d’Italia. Egli fu tra gli organizzatori della spedizione dei Mille e fece anche parte, in qualità di maggiore dell’esercito, della Commissione, istituita nel dicembre 1861, per redigere l’ elenco dei Mille sbarcati a Marsala, l’11 maggio 1860 (composta quattordici alti militari: tre generali, quattro colonnelli, cinque maggiori e due capitani).
[3]Josè Borjes era nato in
Catalogna, nel 1813. Figlio di un ufficiale che si era distinto nelle guerre
anti-napoleoniche (poi fucilato durante la guerra civile scoppiata nel 1833),
aveva militato come sottufficiale di carriera nelle forze partigiane carliste.
Per la sua valentia, si era procurato il grado di comandante di brigata, nel
1840. Con il ritorno dei legittimisti, era stato costretto ad andare in esilio.
Stabilitosi a Parigi, si era guadagnata la vita facendo il rilegatore. Era
rientrato in Spagna durante le campagne del 1846-48 e nel 1855, per sostenere
la causa di Isabella, con azioni di guerriglia. Nel 1860, si era recato a Roma
per offrire i suoi servigi all’esercito pontificio. Sembra che, nell’inverno
1860-61, egli avesse compiuto azioni di spionaggio a Messina e in Calabria, per
conto dei comitati borbonici di Marsiglia e di Roma.
[4] Legge 15 agosto 1863, n. 1409, “Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle Province infette”.
[5] Liborio Romano (Patù (LE), 27 ottobre 1793 – Patù (LE), 17 luglio 1867) fu, prima, ministro dell’Interno e direttore di polizia sotto il Regno dei Borboni e, poi, deputato del Regno d’Italia dal 1861 al 1865.
[6] Una canna, a seconda delle zone, corrispondeva a due metri o a due metri e mezzo lineari.
[7] Istat, Serie storica Tavola 2.10.1 – anni 1876-2005. Tutti i dati si riferiscono al netto dei rimpatri. La stessa fonte evidenzia 181.411 rimpatri, durante il periodo 1905/1915.
[8] Ibidem
[9] Dino Taruffi – Leonello De Nobili – Cesare Lori –Pasquale Villari (Prefazione), “La questione agraria e l’emigrazione in Calabria”, G. Barbèra Firenze 1908 pp. 755–56. In proposito, anche Giuseppe Scalise, “L’emigrazione della Calabria: Saggio di economia sociale, Fierro – Napoli 1905 p. 28.
[10] Statistiche sul Mezzogiorno d’Italia 1861-1951 (pp. 9-13 e seguenti).
[11] Questo significa che su 100 emigrati oltre oceano, dal 1880 al 1911, ben 77,5 rimasero lontani dalla loro patria, mentre su 100 lavoratori emigrati in Europa, solo 7,9 rimasero fuori dall’Italia.
[12] Il dato è al lordo dei 184.411 rimpatri per motivi di comparazione con le altre regioni. A questo proposito, occorre sottolineare che i rimpatri non sono stati registrati statisticamente, prima del 1905, secondo quanto riportato dall’archivio della statistica italiana (ISTAT) Tavola 2.10.1 (anni 1876-2005). Per quanto riguarda l’emigrazione verso gli Stati Uniti, il 3 agosto del 1882, dopo 18 anni dall’approvazione del Congresso USA di “An Act to encourage immigration” (1864), viene votata un’altra legge che poneva dei limiti all’immigrazione (An act to regulate immigration). Nel 1885 si vota una legge che tende a limitare l’afflusso di manodopera a buon mercato. Da questo momento la vigilanza contro l’immigrazione diventa sempre più stretta, ma si dice che i calabresi “vincessero” ogni resistenza.
[13] Archivio Storico Emigrazione Italiana (ASEI), pp. 133-135.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem.
[16] Ibidem.
[17] Ibidem.
[18] Citiamo, tra gli altri,:
– Grazia Dore, La
democrazia italiana e l’emigrazione in America, Brescia
1964- Cfr.
– Manlio, Angelo
D’Ambrosio, Il Mezzogiorno d’Italia e l’emigrazione negli Stati Uniti
d’America, Roma 1924, pp. 61-97.
– Giuseppe Scalise,
op. cit. , pp. 44-62;
– Dino Taruffi –
Leonello De Nobili –Cesare Lori, op. cit., pp. 754-839.
[19]Pasquale Villari definisce l’emigrazione come una nemesi da scontare per avere sempre disatteso le aspirazioni dei contadini a causa dell’incapacità della democrazia italiana, successiva all’Unificazione, di affrontare e risolvere i problemi delle campagne, la cui prima forma di rivolta fu il brigantaggio. Comunque, noi non ci sentiamo di condividere in tutto la posizione del Villari, in quanto non ci sembra che il brigantaggio si possa interpretare soltanto come reazione al nuovo Stato italiano: manifestazioni di delinquenza comune non erano rare nell’azione dei briganti.
[20] Pietro Bastogi (politico
toscano, finanziere e industriale) fu Ministro delle Finanze del neonato
Regno d’Italia durante il governo di Camillo Cavour e quello di Bettino
Ricasoli. Vedasi, a questo proposito, “ L’emigrazione in Calabria”, G.
Barbèra Firenze 1908 pp. 755–56.
[21] Francesco Saverio Nitti, Scritti sulla questione meridionale, vol. II, Bari 1958, p. 42.
[22] Ibidem, p. 98 e p.434.
[23] Nel Regno delle due Sicilie, ogni successione era esente da imposte e tasse; nel 1862, furono applicate, invece, aliquote oscillanti tra un minimo dello 0, 55% (donazioni e successioni in favore dei figli o degli ascendenti) ed un massimo dell’11% (donazioni e successioni in favore di estranei). Per il trasferimento di immobili a titolo oneroso, l’imposta passò dallo 0, 50 al 4%.
[24]L’insofferenza verso le tasse era molto acuta e non poteva essere diversamente, se si pensa che, in applicazione dell’art. 54, della legge 20.4.1871, per mancato pagamento d’imposte, la Calabria subì, tra il 1885 e il 1887, ben 11.773 espropriazioni di beni immobili. Di conseguenza, in rapporto alla popolazione, fu la regione più “espropriata” d’Italia. Le espropriazioni registrate nello stesso periodo e per lo stesso motivo, in tutto il Centro-Nord, ammontarono a 7.071. La sola Calabria, quindi, subì espropriazioni di gran lunga più numerose di quelle subite dall’Italia centrale e settentrionale messe insieme.
[25] Fracesco Barbagallo: Lavoro ed esodo nel Sud: 1861-1971, edizioni Guida Napoli, 1973.
[26] Raffaele Ciasca: “Il problema della terra”, Milano, 1921
[27] Su questo argomento, il periodico catanzarese “Il Pensiero Contemporaneo”, fondato dall’ intellettuale Antonio Renda, alla fine del 1800, trattò, in modo molto approfondito, la questione agraria calabrese, nel contesto di quella meridionale, anche attraverso un questionario, inviato dal giornale, ai maggiori esponenti della vita nazionale sui problemi del Meridione. I diversi contributi che pervennero da molti esperti ed intellettuali, furono raccolti in un volume curato dallo stesso Renda “La Questione Meridionale. Inchiesta” (Remo Sandron Edizioni, Milano-Palermo 1900), con interventi, tra gli altri, di Cesare Lombroso, Arturo Loria, Gaetano Salvemini, Giovanni Marchesini, Scipio Sighele, Napoleone Colajanni, Vincenzo Giuffrida ed Ettore Cicchotti.
[28] Luigi Izzo, “Agricoltura
e classi rurali in Calabria dall’Unità al fascismo”, Géneve, 1974, p.
68.
[29] Questa iniziativa nacque da un’inchiesta parlamentare “sulle condizioni della classe agricola e principalmente dai lavoratori della terra in Italia”, promossa dal deputato Agostino Bertani, nel 1872, e poi “fusa” nell’“inchiesta agraria sulla condizioni della classe agricola in Italia”, presentata dall’allora Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio Gaspare Finali ed approvata con la legge del 15 marzo 1877. A Stefano Jacini, deputato lombardo, venne dato l’incarico di presiedere una commissione costituita ad hoc, che concluse i suoi lavori il 29 aprile 1885. Questa inchiesta, pur mettendo in evidenza le incredibili condizioni del meridione, non riuscì a sensibilizzare la classe dirigente affinché venisse avviato un processo di riduzione delle forti disparità tra Nord e Sud. Sull’argomento, vedasi anche: Alberto Caracciolo: “L’inchiesta agraria Jacini”, Piccola Biblioteca Einaudi, 1973.
[30] Archivio di Stato di Cosenza (ASCS), Affari Generali di Prefettura, cat. 13, b. 2. 157: “Corrispondenza per l’inchiesta Bertani”.
[31] Ibidem
[32] Ibidem
[33] Ibidem
[34] Massimo Petrocchi: “Le industrie del Regno di Napoli”, Napoli, Pironti, 1955
[35] Rosario Villari, Il Sud nella storia d’Italia, Laterza, 1963, pp. 341-48.
[36] Carlo Rodanò, Mezzogiorno e sviluppo economico, Bari 1954, pp. 79-102.
[37] Ibidem.
[38] Censimento del 1871, “Statistiche sul Mezzogiorno d’Italia 1861-1951” (SMI); Roma 1954, p. 769.
[39] ASCS, Affari Generali di Prefettura, cat. 15, b. 1188. Inchiesta igienico-sanitaria, 1885.
[40]ASCS, Affari Generali di Prefettura, cat.13, b. 2. 157, Corrispondenza per l’inchiesta Bertani.
[41] ASCS, Affari Generali di Prefettura, cat. 13, b. 2. 157, Corrispondenza per l’inchiesta Bertani.
[42] ASCS, Affari Generali di Prefettura, cat. 13, b. 2. 157, Corrispondenza per l’inchiesta Bertani.
[43]ASCS, Affari Generali di Prefettura, cat. 13, b. 2. 157, Corrispondenza per l’inchiesta Bertani.
[44] ASCS, Affari Generali di Prefettura, cat. 13, b. 2. 157, Corrispondenza per l’inchiesta Bertani.
[45] ASCS, Affari Generali di Prefettura, cat. 13, b. 2. 157, Corrispondenza per l’inchiesta Bertani.
[46] Lo stesso tragico problema delle alluvioni, delle frane e delle inondazioni era accettato, quasi, con rassegnazione e fatalismo da parte della gente; gli amministratori comunali, solo nei casi più gravi, sollecitavano qualche misura straordinaria o lanciavano qualche “appello alla carità”.
[47] I Comizi Agrari, istituiti con Regio Decreto n. 3452 del 23 dicembre 1866, avevano l’obiettivo di sostenere l’agricoltura, attraverso la diffusione di tecniche innovative.
[48] ASCS, Affari Generali di Prefettura, cat. 13, b. 2. 159. Lettera del Prefetto di Cosenza De Felice al Ministro dell’Agricoltura (2 agosto 1883), con cui informa che in provincia di Cosenza non esistono corporazioni di arti e mestieri.
[49] ASCS, Affari Generali di Prefettura, cat. 13, b. 2. 158. Lettera del Prefetto al Ministro dell’Agricoltura (7 gennaio 1879) con cui s’informa dell’esistenza di 8 società di Mutuo Soccorso; una a Paola, una a Rossano, presieduta da Domenico Palopoli, una a Corigliano, presieduta da Luigi Lettieri, una a Castrovillari, presieduta da V. Cappelli, una a Spezzano Albanese, presieduta da Pasquale Longo e due a Cosenza: la prima denominata Società degli artisti e l’altra, per soli muratori, presieduta da L. Valentini; infine, una a Cassano, presieduta da Antonio Castropini.
[50] Paolo Cinanni, “Emigrazione e imperialismo”, Roma, Editori Riuniti 1968, pp. 62-65.
[51] Secondo i dati Istat, durante il quinquennio 1876/80 erano emigrati oltreoceano 11.040 persone. In proposito, vedasi, anche, Commissariato dell’Emigrazione, «Annuario statistico dell’emigrazione italiana dal 1876 al 1925» (ASEI, Roma 1926 p. 26).
[52] Stefano Jacini, “I risultati dell’inchiesta agraria”, Piccola Biblioteca Einaudi, 1976; e Alberto Caracciolo, “L’inchiesta agraria Jacini”, Einaudi, 1973.
[53] «Atti della Giunta per l’inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola», vol. IX, fasc. I, pp. 121-122. Cfr.; in proposito, anche Gaetano Cingari, “Storia della Calabria dall’Unità ad oggi”, Roma-Bari, 1982, p. 104.
[54]La Calabria, dall’Unità ad oggi, ha avuto ritmi di accrescimento demografico inferiori a quelli del Mezzogiorno.
[55] Dal 2001 al 2010, la popolazione rimane, praticamente, stabile se si considera che, al 2010 essa è di 2.011.395 residenti. Il “massimo storico” viene raggiunto nel 1991, con 2.070.203 residenti.
[56] Svimez:”Primo rapporto sull’economia e la società in Calabria”, 2009, pag. 44.
[57] L’Istat non riporta i dati statistici relativi al triennio 1943/45.
[58] Essa passa da 1.627.117 del 1921 al 2.044.287 al 1951.
[59] Svimez:”Primo rapporto sull’economia e la società in Calabria”, 2009, pag. 42
[60] Ibidem, pag. 42
[61] Ibidem, pag. 39 e seguenti.
[62] Ad esempio, nel quindicennio successivo 1975/1989, la media scende a 354 unità per anno.
[63] Ibidem, pag 43.
[64] Fonte: ISTAT – Serie Storiche – tavola 2.10.1 –“Espatri e rimpatri per regionale e ripartizione geografica – anni 1976/2005”.
[65] Fonte: ISTAT.
[66] Fonte: “tuttitalia”- elaborazione dati Istat (tuttitalia.it).
[67] Data dalla quale si hanno informazioni statistiche certe.
[68] Negli ultimi anni, si sta verificando un altissimo tasso di pendolarismo, in particolare, al di fuori del territorio regionale (studenti, lavoratori, professionisti, ecc.), che, pur mantenendo la propria residenza in Calabria, vivono, praticamente fuori regione, con rientri temporanei.
[69] Svimez:”Primo rapporto sull’economia e la società in Calabria”, 2009, pag. 39 e seguenti.
[70]Svimez:”Primo rapporto sull’economia e la società in Calabria”, 2009, pag. 39 ; in proposito anche Enrico Pugliese, “L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne”, Collana “Universale Paperbachs il Mulino”, 2006.
Vincenzo Falcone
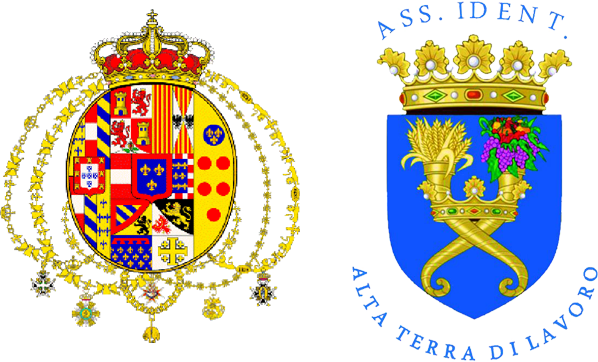


 invio in corso...
invio in corso...



