ANGIOLO DE WITT -… ARRIVATI A PONTELANDOLFO…

CAPITOLO II
Un mazzo di sigari a Milazzo
Avevo per mia ordinanza certo Santomena di Basilicata; era un affezionato attendente, che rare volte trasgrediva ai miei ordini, ma che molto doveva ancora imparare in fatto di convenienza.
Non erami stato possibile d’indurlo a darmi del lei come esigeva il regolamento di disciplina.
Spesso cominciava coll’appellativo in terza persona, ma alla lunga finiva col tu; ed in questo sistema di trattare avea molti che lo assomigliavano fra i suoi commilitoni, i quali principiavano con Eccellenza e terminavano col te ancora quando rispondevano al generale d’ispezione durante la rassegna annuale.
Non avevano in fondo tutti i torti, che noi mortali usiamo dare il tu a Dio quando lo invochiamo, ed a nostro riguardo esigiamo gli appellativi più sonori ed aristocratici.
I Romani invece, quando erano grandi, non ammettevano distinzione di titoli, e dicevano a Cesare tu Coesar; ma vi era, fra me e Santomena, la spada di Damocle del regolamento di disciplina che non transigeva su tale proposito.
La mattina veniente Santomena venne a svegliarmi avanti l’alba, e poiché aveva la smania di tutto dirmi quanto in compagnia si buccinava riguardo al servizio, questa volta volle accertarmi che quasi tutti gli sbandati si erano pentiti di avere commesso quell’atto di insubordinazione a cui accenna il capitolo precedente, e che
ognuno di loro deplorava le lesioni del caporale Squillace, il quale, a seconda di quanto asseriva Santomena, era universalmente beneaffetto.
Gli domandai il perchè costui era beneaffetto a tutti i suoi compagni, ed ei cosi mi rispose.
— Isso è uno figlio di galantuomo e tiene lo sistema de fa lo bene a gnuno.
Ed in che consiste — gli chiesi io — questo gran bene che Squillace dispensa ?
Allora Santomena mi raccontò più e diversi fatti che stavano a dimostrare come quel caporale fosse fornito di un animo assai gentile: più di ogni altro aneddoto a lui riguardante e raccontatomi alla meglio della mia ordinanza, mi colpì il seguente episodio che voglio qui riferire.
Avanti di passare caporale, Squillace era al campo di San Maurizio insieme a tutti gli altri sbandati.
Una certa notte montava di guardia alla polveriera di quell’accampamento; ciascun soldato doveva fare due ore di sentinella, e Michele al suo turno le aveva già fatte dalle 10 alla mezzanotte; cosicché fino all’indomani mattina sarebbe stato libero di riposarsi, meno casi imprevisti.
Era una notte burrascosa come sono quelle che sopraggiungono improvvisamente nella estate, ed appunto in quell’anno 1861 i mesi più caldi furono tramezzati da
freddi improvvisi, da tempeste e da cicloni.
Codesta notte qualche fulmine si era andato a scaricare nel pozzo dei pali elettrici ; e lo scroscio della pioggia a vento aveva invaso la parte dischiusa della garetta.
E tuoni e lampi e torrenti di pioggia accompagnati dal cigolio dei venti che rassomigliava un incessante gemito d’innumerevoli anime espiatrici, formavano il tetro quadro di quella notturna tempesta, in mezzo alla quale l’Airone, messaggiero della procella, batteva i larghi vanni sui turbinosi vortici dell’atmosfera.
Erano le due di notte ed il turno di fazione spettava ad uno sbandato d’aspetto malaticcio, il quale durante la campagna del 1860, nella pianura sottostante a Gioja, aveva preso le febbri miasmatiche, che per non essersi mai a sufficienza curato, spesso gli ritornavano.
Questo sventurato appunto allora era affetto da febbre, ed accusava questo suo malore, affinchè il sergente capoposto lo sostituisse con altro, chiedendo la di lui muta di guardia.
Il sergente però si mostrava incredulo al male, e si opponeva a che quel disgraziato potesse ottenere la richiesta surroga; era un vecchio bassoufficiale piemontese poco nulla tenero di cuore, e che invece di soccorso dava di plandrone (Plandrone, in dialetto piemontese significa poltrone) a quel disgraziato.
Il povero soldato barcollava pel tremito febbrile che gli aveva invaso le membra, e sempre più si raccomandava al capoposto di non volerlo mandare in quello stato e con quel tempo indiavolato a fare la sentinella; diceva.
_ Se vado così come mi sento a montare in fazione, quando verrete a darmi la muta mi troverete morto.
Ma il sergente ostinato nella sua inumanità gli rispose in tono secco:
— montare la sentinella o andare alla prigione per insubordinazione. —
Il meschinello militare era dubbioso nello abbracciare l’uno dei due mali, che gli venivano offerti da uno spietato superiore; gli rincresceva tanto il morire, quanto lo andare a Fenestrelle.
Poveretto! Egli ancora aveva i suoi affetti che lo legavano ad una esistenza di appena 25 ann, ed in pari tempo gli era caro vivere onorato.
— Che aggio a fa — diceva con voce tremola e piagnolenta.
Squillace allora destatosi, fortunatamente per quel soldato, capì di che cosa si trattava, e fece presto a farsi una chiara idea della cantonata presa dal capoposto, onde, convinto siccome era, che quel soldato fosse realmente ammalato, volle risolvere la vertenza offrendosi egli in luogo del febbricitante compagno per fare le due ore di sentinella.
Il sergente brontolando acconsenti, il caro Squillace se ne andò nella garetta della S. Barbera a contemplare ancora gli orrori della natura irata, ed il povero ammalato si ributtò sul pancaccio, dove peggiorò in guisa che l’indomani poco mancò che una perniciosa lo mandasse all’altro mondo.
È facile il giudicare, che fatti di tanta filantropia bastassero da sé soli perchè tutti i camerati di Squillace gli fossero affezionati e lo ritenessero per un essere a loro superiore.
Volere o non volere, in quella circostanza aveva salvato la vita ad un suo compagno, e tolto il crudele capoposto da una grave responsabilità.
Udito con sentimento d’ammirazione il racconto di questo episodio, convenni ancora io con Santomena che il caporale Squillace doveva essere stato sempre un eccellente militare, e un uomo di cuore.
A tali parole la mia ordinanza mi soggiunse avergli detto lo stesso Squillace che nel 1860 in Sicilia egli aveva confabulato con me, cosa che avrebbe voluto più volte rammentarmi ma che fino ad allora non si era mai arrischiato di fare.
Io andai ripensando dove avrebbe potuto trattare con me colui, che in Sicilia faceva parte delle schiere nemiche, e per quanto andassi rovistando nella mente per quel giorno non mi riuscì raccapezzarmi.
Alle ore 5 del mattino del 23 luglio da Solopaca ci ponemmo in cammino per Campobasso, designando il paese di Morcone come luogo di grand’alto; e siccome il capitano Dimier si era proposto di fare ivi una sosta di almeno due ore, fu stabilito che appena fossimo giunti a Morcone avremmo fatto fare il rancio per la truppa.
Questo nostro itinerario era subordinato alla condizione (poco, punto difficile) di non trovare il paese invaso dai briganti, che se questo caso non nuovo si fosse dato, bisognava prima fare sloggiare quei malandrini, eppoi pensare alla necessaria refezione.
Tali erano allora le condizioni politiche di quella provincia; gli opposti partiti, liberale e borbonico, disputavansi il dominio della situazione, e malgrado la tollerata monarchia del Re Vittorio, da un momento all’altro briganti e popolazioni facevano causa comune fra loro, allo scopo di restaurare il soppresso trono di Francesco II.
In tale circostanza guai ai liberali ed ai soldati italiani che si fossero trovati ivi presenti; non se ne sarebbe salvato uno solo, gli avrebbero accoppati tutti.
Ciò nonostante in parlamento si gridava la croce addosso al governo italiano per le misure di rigore adottate nelle provincie meridionali, e non erano sempre i deputati clericali quelli che protestavano contro; qualche volta erano invece gli uomini politici della cosi detta sinistra storica.
Ci ponemmo in cammino nello stesso ordine del giorno avanti con la variante che allora marciavamo avendo la sinistra in testa.
In quella seconda tappa l’onore della avanguardia toccò alla compagnia da me comandata e che disposi come il regolamento prescrive.
Io marciavo al mio posto, cioè al centro del nucleo con la mano sinistra appoggiata sul calcio del revolver e con la destra tenevo i miei canocchiali da campagna per meglio esplorare i dintorni, e tutto quanto precedeva la mia sorveglianza ; intanto per rompere la monotonia di quelle ore lunghe di cammino, feci chiamare presso di me il caporale Squillace (divenuto oggimai protagonista del mio racconto) col quale ebbi il seguente dialogo.
— Dunque voi — gli dissi mi avete conosciuto in Sicilia nell’anno 1860 ?
— Sissignore — rispose — e mi ricordo benissimo che ebbi da lei regalato un mazzo di sigari.
Allora lo squadrai meglio e mi accorsi in confuso che una simile fisonomia l’avevo riveduta in un’epoca lontana, ma erano ormai passati due anni e non era facile il ricordarmi dei particolari di quella conoscenza di pochi istanti.
Squillace allora, vedendomi lontano dal rammentarmi distintamente di lui, mi ritornò alla memoria la resa del forte di Milazzo, ed un mazzo di sigari, che io regalai ad un soldato borbonico, mediante una funicella che questi mi aveva calata dagli spalti del forte.
Mi fu facile allora il sovvenirmi completamente di lui.
Infatti nel 1860, allorché feci tutta la campagna delle Due Sicilie, mi trovai alla capitolazione del forte di Milazzo.
In quella brillante guerra fatta da Italiani già liberi contro Italiani mistificati da un potere autocratico, io tenni per qualche tempo il comando dell’ottava compagnia del primo reggimento Cosenza, sebbene fossi semplice sottotenente.
All’alba del giorno in cui avvenne la sanguinosa battaglia di Milazzo, il mio reggimento era a Cefalù, e quella stessa mattina era dietro ad imbarcarsi su tante paranze (Paranze così si chiamano alcune grosse barche a vela ed a remi. ) per poi far vela verso la rada milazzese.
Ed infatti, navigando pel piccolo mare che precede la lunga costiera sud dell’istimo di Milazzo, alle 2 pomeridiane si avverti in lontananza una rumorosa eco di forti detonazioni, che giungeva fino a noi sulle ali di un maestrale che allora appunto aveva incominciato a spirare.
— Senza dubbio — dissero i più di noi — avviene adesso un qualche fatto d’armi fra le milizie regie e la divisione Medici che per la via di terra ci aveva di qualche giorno preceduti nella partenza, —
pag. 30 […]
CAP: II da pag.43 quarto capoverso a 49
— Questo vostro romanzo mi interessa assaissimo, e voglio che me lo raccontiate per filo e per segno e nelle sue più minute circostanze durante il resto della marcia
che dovremo fare insieme.
In questo frattempo essendo arrivati a Pontelandolfo dove avevo ordine di fare un piccolo salto, feci serrare le righe, richiamai i fiancheggiatori, e Squillace tornò al suo posto, cioè in serrafile del primo plotone.
Sì, eravamo a Pontelandolfo, in quel piccolo paese di circa tremila anime, dove poco tempo prima erano rimasti vittime dei briganti un ufficiale e quaranta soldati del nostro reggimento.
Quei bravi militi, sorpresi da una banda di circa 200 briganti, mentre erano in perlustrazione sulla via di Morcone, opposero una accanita resistenza, e mantenendo un efficace fuoco di ritirata, si diressero a Pontelandolfo, sperando che colà giunti la guardia nazionale sarebbe accorsa in loro ajuto.
Ivi ripiegatisi, trovarono invece quel popolaccio in completa reazione, e furono presi a colpi di sasso dalla inferocita plebaglia, che al grido di viva Francesco secondo aveva lì per li sposato la causa dei briganti.
Ritiratisi quei militi in una collinetta molto vicina al paese, formarono un gruppo di difesa, e tennero per molte ore a rispettosa distanza quella canaglia di alleati, proseguendo un continuo fuoco di fila e facendo di tanto in tanto delle scariche di riga contro di loro, ma quando ebbero finito i sei pacchi di cartuccie che ogni soldato teneva presso di sé, sopraffatti dal numero e diradati nelle file dai spessi projettili dei briganti, furono tutti, uno dopo l’altro, miseramente trucidati.
Quella mezza compagnia di eroi era comandata dal valoroso luogotenente Bracci di Livorno,- che mori al suo posto con la spada in pugno.
Due giorni dopo questo atroce misfatto della reazione brigantesca, sopraggiunse in quella terra di ribaldi un battaglione di bersaglieri, comandato dal maggiore Bossi
che era un esperto e valente ufficiale superiore.
Per la stessa via da noi percorsa, ivi arrivata in fretta ed in furia la vindice schiera, trovò, che i briganti si erano già di molte miglia allontanati, ed il paese deserto.
Le porte e le finestre delle case erano ermeticamente chiuse, e non una sola persona s’aggirava per le silenziose contrade.
Due sole finestre si spalancarono e furono quelle dell’unica casa appartenente ad una famiglia liberale, la quale, durante l’invasione dei briganti aveva subito molti dispetti, e corso serio pericolo della vita.
Quei signori avevano dovuto barricarsi entro la propria abitazione, nelle di cui pareti esterne avevano fatto praticare diverse feritoje, dalle quali facevano un micidiale fuoco addosso a chiunque dei rivoltosi avesse osato avvicinarsi alla porta d’ingresso.
Muniti di eccellenti carabine, che caricavano a pallottole spezzate in quattro quadrelloni, si erano messi ciascuno di essi dietro una feritoja, e così con i più fidi famigli erano in dodici i difensori di quella casa, il di cui incendio era stato indarno tentato dai reazionari.
Penetrarono alfine nell’interno del paese i bersaglieri italiani, tanto sospirati dai pochi liberali, ed il popolaccio che aveva unito la sua sorte a quella dei nemici della patria, ormai da assediante era divenuto assediato; questa volta toccò a lui l’intanarsi nei suoi luridi tuguri.
I due fratelli Lo Russo che erano i ricchi proprietari della casa fatta segno all’ira antiliberale di quella popolazione, si sentirono sollevare nell’ avvertire il suono delle trombe che annunziavano prossime le tanto desiderate milizie, e dai spiragli delle feritoie, dietro le quali notte e giorno erano rimasti vigili sentinelle, scorsero con gioia agitarsi all’aura i mobili pennacchi dei bersaglieri italiani.
Infelici, chi avesse mai detto loro, che il suono di quelle belliche trombe sarebbe stato per essi il lugubre preludio che doveva precorrere il loro immeritato eccidio?
Si fecero entrambi quei sventurati a spalancare le finestre onde acclamare le truppe liberatrici.
Vedi crudele fatalità ? !
I bersaglieri prendendoli per reazionari, che avessero in animo di far fuoco contro di essi, con dei bene aggiustati colpi di carabina gli uccisero tutti e due, e cosi quegli infelici martiri della patria da chi speravano salvezza ebbero morte.
A tanto marcata maledizione che colpiva quelle vittime ed a tale jattura, le spose, le sorelle, e la vecchia madre di quelli, con le chiome sparse sugli omeri, scesero nella via, ed inginocchiatesi avanti il maggiore, con voce interrotta dal pianto gli fecero palese il tremendo equivoco.
Quelle infelici donne, rese furibonde dal più acerbo ed improvviso dolore per tanta perdita = Noi siamo colla nazione — gridavano = non ci uccidete ancora i nostri piccirilliy che noi siamo stati sempre con voi = Ed in cosi dire pianto dirotto e riso convulso misto allo strapparsi di capelli.
Era purtroppo vero che quella patriottica famiglia aveva sempre parteggiato per la buona causa italiana.
II maggiore Bossi, accertatosi di ciò e penetrato del fatale inganno, si fece con bel modo a consolare le derelitte, e ricondottele in casa, avanti i cadaveri dei due
sventurati fratelli, ordinò ai suoi sottoposti l’incendio e lo sterminio dell’intero paese.
Allora fu fiera rappresaglia di sangue che si posò con tutti i suoi orrori su quella colpevole popolazione.
I diversi manipoli di bersaglieri fecero a forza snidare dalle case gl’impauriti reazionari dell’ieri, e quando dei mucchi di quei cafoni erano costretti dalle baionette di scendere per la via, ivi giunti, vi trovavano delle mezze squadre di soldati che facevano una scarica a bruciapelo su di loro.
Molti mordevano il terreno, altri rimasero incolumi, i feriti rimanevano ivi abbandonati alla ventura, ed i superstiti erano obbligati di prendere ogni spece di strame per incendiare con quello le loro stesse catapecchie.
Questa scena di terrore guerresco durò una intiera giornata; il gastigo fu tremendo ma fu più tremenda la colpa.
Facemmo una piccola sosta sopra un altipiano che si trova dirimpetto a Pontelandolfo, questa volta però molta gente venne ad incontrarci, e mi fu dato osservare che le più erano donne tuttavia vestite in lutto; a quella vista pensai, che le nere vesti di quelle femmine orbate di spose di fratelli formavano un tetro accozzo con le
pareti delle case ancora affummicate pel consumato incendio.
Da Pontelandolfo a Morcone giungemmo in poche ore, ed erano appena le undici del mattino, quando ci venne incontro il maresciallo dei carabinieri, per avvertirci che poco nulla potevamo fidarci di quella popolazione, la quale ei ci asserì essere invasa da manifesto spirito reazionario; di più ci raccomandò di non fare avvicinare i soldati a quei popolani se non volevano avere delle diserzioni dei fatti di sangue isolati a carico di qualche milite sorpreso alla spicciolata.
Questo salutare avviso della benemerita arma indusse il capitano a far bivaccare la truppa in una piazza che si trova prima di entrare in paese, ed a mettere una buona guardia all’uscita di Morcone con la consegna di non far da quella sortire borghesi né entrare soldati durante il tempo del nostro grande alto.
Fra i brontolii del sindaco e di altri della borghesia morconese, che erano venuti a pregarci di entrare pure liberamente, cosi fu irrevocabilmente stabilito, ed ottenuti i viveri per fare il rancio, dopo due ore di allegro bivacco, ci rimettemmo in cammino alla volta di Campobasso.
Gli sbandati avevano fatto un cambiamento in meglio da sbalordire; nessuno di loro esternò più il minimo segno di scontentezza e marciavano baldi come vecchi legionari romani.
Durante queste ultime ore della nostra marcia Squillace mi raccontò tutti i più minuti particolari della sua vita romanzesca, mi informò circostanziatamente e delle peripezie sofferte, e dei momenti di gaudio, che aveva a lui procurato una tale passione.
Mi citò circostanze e nomi, che mi fecero restare sbalordito, e mi mostrò alcune lettere ed altri pegni d’amore scoloriti dal tempo e consumati dai baci.
Se dovessi qui ripetere alla lettera tutto quanto mi narrò in dieci ore di marcia l’appassionato Squillace, dovrei fare costare il mio lavoro di almeno mille pagine.
Furono dei lunghi e particolareggiati racconti dettati da una mente innamorata alla follia, furono bizzarri episodi di un’esistenza battuta dai fati.
Io nel riconoscere in quel’umile caporale un carattere fermo e nobile ed un’anima espansiva, penetrante e sensibile, nonché una vasta coltura letteraria, lo esortai a
calmarsi nella sua passione amorosa, e dedicarsi piuttosto alla carriera militare, ove ero certo che avrebbe fatto una splendida riuscita.
A tale esortazione egli cosi mi rispose:
— Signor mio, nell’armata borbonica io fui più volte retrocesso dal grado, o per troppa vivacità, o per avere esternato sentimenti di patriottismo — brutto difetto in quei tempi — e posso dire che se non fossi stato ritenuto per un cospiratore ed avessi potuto fingere o mascherare le mie convinzioni politiche, a quest’ora sarei stato un vecchio ufficiale ; ma cosa importano a me i gradi, cosa l’avere una brillante posizione in società, se non mi è dato ottenere il solo oggetto dei miei desideri!
Io non ho alcuna ambizione — soggiunse Squillace — all’infuori di quella, che mi assicuri di essere in silenzio riamato da lei, e tale è tutto il bene che Iddio può con- cedermi in questa vita, al di là di questo, ogni altra cosa è nulla per me !
Poi riprese:
Veda, signore, io non mi sono ancora ucciso perchè non voglio abbandonare questa terra finché ella vi respira, ma posso assicurarla che nessuna lusinga mi offrono le
seducenti attrattive della più brillante posizione.
D’altronde io era agiato e non lo sono più; ero felice ed ora sono immerso negli affanni, ero riamato e vidi possedere da altri colei che mi amò, a quale scopo adunque dovrei andare in traccia di lustro e di agiatezza?
Sì, sono sventurato : ma ancora la sventura — soggiunse Squillace — ha la sua voluttà, ed il pianto dell’abbandono in amore, vale la gioja del trionfo quando una segreta voce ne assicura che l’anima di colei che si è amata è tuttora nostra.
Checcosa è mai il possesso materiale di un essere, che volga ad altri l’irrefrenabile pensiero?
Checcosa è mai un amore, quando è subordinato alla condizione o di titoli o di ricchezza, e di ibrida venustà
di forme?
L’affetto vero è nato avanti di noi, ed a noi deve necessariamente sopravvivere !
E se si ammettesse che l’amore di un mortale verso di un altro, dovesse avere la sola origine, o dalla perfezione dei lineamenti, o dalle lusinghe dei gradi e della
ricchezza, in questo caso egli sarebbe posto all’incanto, nel quale rimarrebbe sempre’aggiudicato a quell’offerente, che fosse meglio fornito di tali requisiti.
Ma questo tema produceva nell’animo di Squillace una certa eccitazione che gli si dipingeva sul volto, onde è che dopo essere rimasto qualche minuto pensoso ed a capo basso, con energici accenti cosi riprese:
— Si, vivaddio, sì !
Rimarrò povero per tutta la mia esistenza, e quando avrò finito la mia ferma di servizio, ritornerò in patria a lavorare.
Se ella mi ha veramente amato — mi disse Squillace con convinzione — ritenga pure che non mi dimenticherà per essere io divenuto misero, seppoi ha sempre finto
un’affezione, allora tornassi pure come sovrano, sarei tuttavia mistificato dal cuore di una donna più mobile e leggera che non lo sia una piuma.
E se cosi fosse? — risposi io.
Se così fosse!? — riprese Squillace, guardandomi in modo come se avesse voluto rimproverarmi la spietata ipotesi — quando ciò fosse io saprei renunziare all’idea di essere riamato, ma non potrei adattarmi a non amarla più ed affezionarmi ad un’altra.
Povero caporale Michele mi faceva compassione, era un’ anima ardente, gentile, e disinteressata, che aveva tutto sacrificato ad una donna cui unicamente amò del più casto affetto per tutta la vita.
Ma era un angelo o un’erinni questa signora ?
Lo vedremo nei venienti capitoli, intanto sappiamo, che da due o tre giorni la speranza si era in Squillace rinverdita col di lui arrivo a Napoli.
Cammina, cammina eravamo presso al termine della seconda ed ultima tappa, e Campobasso, luogo della nostra nuova destinazione, si preannunziava a noi coi suoi vigneti e con i radi casini di campagna, che ci appari, vano e sparivano con tarda vicenda.
Avvertimmo in lontananza un attruppamento di persone che ci veniva incontro, le vedette mi mandarono a dire per mezzo di un soldato, che venne a noi a passo di corsa, essere alle viste un distaccamento di truppa regolare, io supposi che cosa poteva essere, e fatto fare alto all’avanguardia, mandai un altro soldato al capitano
per informarlo dell’incontro; infatti il grosso del battaglione in pochi minuti ci raggiunse per formare con noi una sola colonna su quattro righe.
Dopo brevi istanti giunse al nostro orecchio il suono di una fanfara militare che si partiva da quel drappello, il quale pervenuto ad incontrarsi con noi riconoscemmo
essere un mezzo battaglione del 36^ nostro reggimento in testa al quale erano lo stesso colonnello e molti ufficiali.
In mezzo degli evviva all’Italia ed al Re fu fatto delle due colonne una schiera sola, ed al suono della bella gi gu gi entrammo in Campobasso alle ore 7 di sera.
[…]
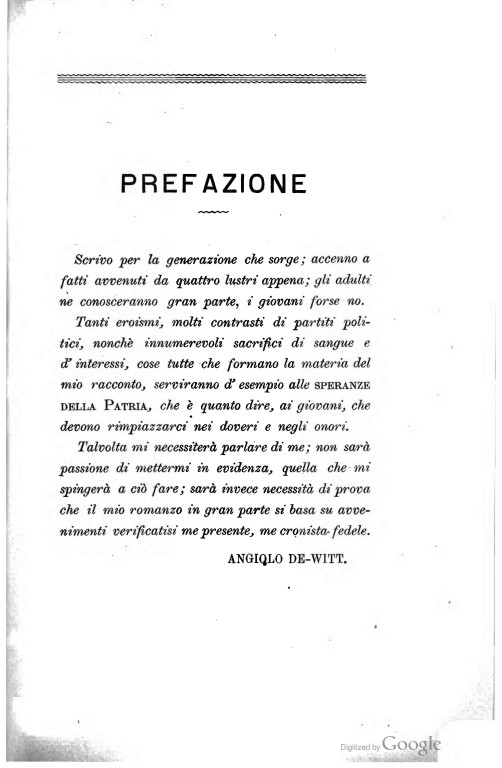
Ricerca e elaborazione testi del Prof.Renato Rinaldi Da: “Storia Politico-Militare del Brigantaggio nelle Provincie Meridionali d’Italia”Firenze 1884
CAP. II Pagg. 25 a 30
. II Pagg. 43-49 arrivati a
Pontelandolfo…..



 invio in corso...
invio in corso...



