Assassinii e desolazione ad Itri nella seconda metà del Settecento di Alfredo Saccoccio
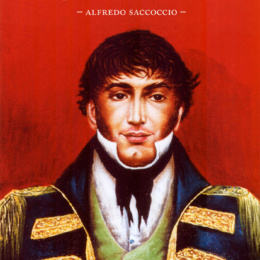
Michele Pezza, detto “Fra’ Diavolo”, con la sua gente armata, non si stancava di tormentare, con aspra guerriglia, la retroguardia dell’esercito francese correndo da Portella, ai confini dello Stato Romano, fino al fiume Volturno.
Stanchi degli agguati, dei fatti d’armi e della sommossa di Itri, i transalpini, il 16 gennaio 1799, misero a sacco e a fuoco il paese del guerrigliero. La devastazione fu grande. Furono profanate le chiese, sparse a terra le ostie sacre e abbattute molte case nella contrada dello Straccio, che bruciò per cinque giorni come un fiore di fuoco. Gli abitanti, rifugiatisi sui monti vicini, ebbero sotto gli occhi lo spettacolo desolante, raccapricciante, delle fiamme divoratrici, che avviluppavano l’infelie cittadina, illuminata dal riverbero sinistro degli incendi.
In cielo, lenzuoli di fumo; lingue di fuoco dalle finestre; schianto di tetti; morti e moribondi tra le macerie, urlanti di disperazione; colpi di archibugio; tonfi di portoni sfondati; mandrie di poveri cristi, rossi di sangue; povere donne nude, in balìa dei “leopardi, sospinte per le vie a calci e a bastonate da soldati gonfi di vino ed affamati d’oro e di carne di donna. Queste ultime, inorridite, urlavano, nel sangue, come le Erinni sanguicrinite di Von Stuck. Le lacrime sgorgavano copiose dagli occhi inondando loro il volto e il seno palpitante.
Non vi fu scampo per nessuno, siano essi uomini che donne. Niente fece da scudo, né l’età , né il sesso, né il nome, in una sorta di furia iconoclastica.
Queste lascivie, queste ribalderie, queste iniquità e ferinità degli ultramontani, che cantavano la “Marsigliese” e certe canzoncine da lupanare, interrotte da scoppi di risa, richiederebbero molte pagine di cronaca.
Eppure questi francesi erano entrati nel reame di Napoli come angeli di libertà! Fallace fiducia nello straniero! Bene lo aveva compreso Michele Pezza, che non volle ammettere, nella sua bell’anima, le pestifere massime di quei tempi, portate sulla punta delle baionette dell’esercito napoleonico.
I vecchi e gli invalidi, venuti fuori al sole delle case come formiche o api brulicanti e ronzanti, che non potettero mettersi in salvo, ed erano “dei migliori del paese”, vennero immolati barbaramente al furore nemico, come, tra l’altro, è documentato da una dolorosa ed eloquente pagina che l’arciprete del tempo, D. Nicola Agresti, trascrisse su di un libro parrocchiale, sfuggito all’incendio dato alla propria casa. Se non fosse intervenuto l’Agresti, che parlava così bene il francese, tanto che il comandante dei soldati franco-polacchi ne rimase ammirato, cedendo alle sue preghiere, le chiese di S. Michele Arcangelo e di S. Maria Maggiore sarebbero state incendiate, dopo quella del ricco convento dei Padri Francescani, trecentesco, la cui campana fu da essi fusa a Napoli per farne cannoni.
Il sacerdote Agresti, francesizzante in modo spinto, tanto da meritare dal sovrano di Napoli, Joseph Bonaparte, il titolo di “Cavaliere”, possedeva un’erudizione per dottrine e lingue. Lo si poteva qualificare un poliglotta. Era canonico della cattedrale di Gaeta, canonico onorario di Fondi. Egli fece arruolare due nipoti, Alessandro e Franescantonio, nell’esercito francese sotto l’imperatore Napoleone, nella speranza di averli generali di Armata. Entrambi ebbero il grado di capitano.
Le truppe francesi uccisero 60 persone. I soldati del generale Dombrowski depredarono ori, argento e si scatenarono ferocemente sugli abitanti , sia che fossero vecchi ed invalidi sia che fossero giovani. Tra gli altri, le truppe degli invasori uccisero il sessantenne Domenico Porcellati, mendico, sordomuto dalla nascita e quasi cieco, il quale doveva almeno essere rispettato per la sua infermità. I transalpini avevano sfogato sulla popolazione itrana l’odio che nutrivano verso “Fra’ Diavolo”, un Antagonista molto ostico per loro.
A sette itrani, legati da una fune, recisero il capo con la scimitarra.
Le monache benedettine di S. Martino, appena seppero dell’arrivo dei Francesi a Terracina, il 26 dicembre, avuto il permesso dal vescovo diocesano, Riccardo Capece Minutolo, lasciarono il monastero, sotto una pioggia battente, rifugiandosi a Gaeta. La badessa Calamita ed altre più animose che erano restate, all’incendio e alla strage del paese, cercarono di mettersi in salvo, ma, proprio quando stavano per uscire dal sacro luogo, entrarono nel parlatorio impetuosamente quattro militi francesi, che chiesero, con tono minatorio, danaro e viveri. La Superiora del monastero offrì dolci e alcune monete. All’improvviso, uno dei francesi sparò un colpo di pistola. Spinte dal terrore, le suore fuggirono nella vicina casa della donna di servizio, Maria Antonia Masella. La casa religiosa fu lasciata all’arbitrio dei francesi, i quali, più tardi, sfasciarono, a colpi di ascia, la porta dove si erano rifugiate le spose di Cristo uccidendo una religiosa, Girolama Donnarunna di Napoli, inabile, che fu poi trovata con il crocifisso in mano, e l’inserviente,, le vesti intrise di sangue. Le altre suore, nascoste sopra il soffitto, riuscirono a scamparla finché, il 18ottobre 1799, con la restaurazionr borbonica, rientrarono, tutte, nel convento, come si evince dal “Libro di Memorie del Monastero .d’Itri”.
Tra gli uccisi di Itri, il sessantasettenne Francesco Pezza, il padre di Michele Pezza, restato in casa con due suoi “garzoni”. Uno di essi fu preso a sciabolate dai dragoni, mentre l’altro, ferito leggermente, corse a portare la nefasta notizia ai figli del padrone, messisi al sicuro nel podere di Santo Stefano. Il Pezza fu percosso a morte da un ufficiale francese e da due militi, perché questi volevano dal vecchio infermo un alloggio a loro piacimento e di tutto punto e soddisfazione della loro libidine sulle sue oneste figlie. A casa Pezza, i francesi bevettero tutto il vino che potettero, sfondando dispettosamente le botti di vino e rompendo alcuni ziri e damigiane pieni di olio. Si persero migliaia di litri di vino e d’olio.
Azioni, queste, dettate dalla voglia di colpire, nel genitore, l’aborrito figlio, non rispettando la sua veneranda età, non indietreggiando dinanzi alle sue povere pupille quasi cieche, dinanzi alle sue mani tremanti e rinsecchite, dinanzi alla sua persona curva e lenta.
Quando i figli entrarono in Itri, il genitore, che era boccheggiante per molte ferite (alla testa, sul braccio destro, nella coscia sinistra, nel corpo, per colpi di baionetta ), fu portato nella vicina casa di Casimiro Mancini, l’amico di “Fra’ Diavolo”, dove dimorava anche un ufficiale francese.
Francesco era in un grande letto di noce, dai pomi di ottone. Michele, al capezzale del padre, gli asciugava il volto con delle pezzuole di lino, ruvide e leggere (ricordavano le tele dei sudarii), che si conservavano negli alti canterani proprio per queste circostanze. Il viso del vecchio, magro, sofferente, la barba fitta e bianca sul mento, le gote enfiate, preannunciava l’imminente trapasso. Il morituro riceveva gli estremi conforti della religione cattolica, assolto in “articulo mortis”.
Michele guardava, malinconico, i rami di un gelso che sorgeva dietro casa sua. Nella luce delle lampade le mosche e le vespe dell’orto turbinavano in un laborioso carosello. Francesco soffiava dal mantice del suo immenso torace e ogni tanto strabuzzava le pupille. Già qualcuno trinciava segni di croce. Difatti, dopo pochi minuti, il ferito reclinò il capo e si acquietò, con gli occhi aperti e vitrei. Nonostante le cure sollecite ed amorevoli, Francesco chiuse i suoi giorni terreni.
Nel giardino, immerso, a metà, nelle tenebre, sulle foglie del gelso, un verdone, appena posato, volò via al grido straziante dei figli e della moglie di Francesco, che rientrava nella stanza, in vestaglia, appena discinta, gli occhi gonfi di pianto.
Michele rivestì il padre di un saio francescano (era molto devoto a S. Francesco d’Assisi), cucito dalla moglie Giacinta Pennacchia, con cui si era risposato, dopo la morte di Arcangela Matrullo. Dalle mani incrociate ed ormai ghiacciate gli pendeva un rosario di madreperla.Michele aveva amato il genitore con devozione, che gli insegnava, in campagna, a trovare e .a distinguere nel cielo le due Otse, quella Maggiore e quella Minore. Quando il cielo della sua infanzia si oscurava, c’era lui, Francesco
……continua
Alfredo Saccoccio



 invio in corso...
invio in corso...



