“Ernesto il disingannato” (romanzo del 1874) a cura di Gianandrea de Antonellis (VII)
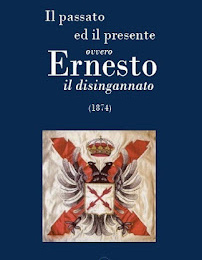
Capitolo VI. Due Amori
Erminia, la quale aveva dato una posta ad Ernesto sotto pretesto di dovergli comunicare cose importanti che riguardavano gli affari della rivoluzione, si era invece preparata a riceverlo per tutt’altro scopo; e siccome gli aveva alla medesima indicata l’ora del ritrovo, così contava per così dire i minuti, perché l’ora stabilita giungesse; ed apparecchiatasi al ricevimento immaginato, si era abbigliata nel modo più seducente e provocante che immaginare si possa, stabilendosi in un gabinetto apparecchiato a bella posta ed addobbato con tutta ricercatezza, atto a ridestare gli spiriti bollenti di un giovinotto del quale ella ad ogni costo voleva fare la conquista.
Finissime cortine di bianca mussola ricamate, sormontate da altre di seta color scarlatto, moderavano la troppa luce della stanza, rendendola precisamente adattata alle riunioni di natura di quella che si desiderava dalla signora; morbidi sofà ed una quantità di fiori, collocati in bianchi vasi d’alabastro e di porcellana, facevano coi loro fragranti profumi l’effetto di eccitanti pei sensi di chi colà era destinato a soggiornare; quadri, se non osceni, almeno tali da appagar troppo la vista, solleticanti gli occhi e gli appetiti più schivi… insomma tutto era colà preparato per sedurre, annientare, strascinare al male coloro che vi entravano una sola volta.
Giunta l’ora e battuta questa ad un pendolo della vicina galleria, Erminia smaniosa aspettava, non credendo che ai suoi cenni si fosse potuto resistere solo un momento ed anelando a quegl’istanti deliziosi che credeva fermamente dover passare presso del bello ed avvenente commesso.
Ma Ernesto, sebbene avesse divisato di non mancare e recarsi presso la bella donnina, pure non aveva quella premura che dessa per certo addimostrava, sia perché non acceso dalla medesima impura fiamma che lei, sia perché avendo ricevuto, nello scendere dalla casa di don Bartolomeo, alcune disposizioni da don Antonio, le quali essendo secondo lui più importanti, si era affrettato a disbrigarle prima di recarsi dalla Contessa.
Finalmente, dopo mille smanie provate dalla bella, un colpo del campanello di strada l’avverti, che forse l’ora desiata era giunta; corse dunque a sdraiarsi mollemente su di un sofà, aspettando che la sua vittima fosse introdotta da una cameriera, la quale, avendo studiato alla medesima scuola della sua signora, era divenuta come lei esperta e forse anche più brava nelle astuzie e negli espedienti della depravazione.
La porta del gabinetto dopo pochi momenti venne aperta e fu annunciato il signor Ernesto.
– Finalmente! – esclamò la bella Contessa vedendolo entrare – Finalmente vi siete degnato di comparire! Mi pare che non vi stiano a cuore gli interessi della causa che propugnate, se, invece di affrettarvi e correre a ricevere gli ordini necessari che io debbo trasmettervi, avete perduto molto tempo. Il vostro novello impiego va distinto per bravura, intelligenza e sollecitudine: non si può essere un buon agente segreto se non si posseggono in sommo grado queste tre prerogative.
– Perdonate, signora: ma ordini pressanti ed importantissimi, comunicatimi dal signor don Antonio, mi hanno trattenuto, ed è perciò che ho creduto occuparmi prima di quelli e poscia sono volato a riceverne degli altri da voi che, prometto, saranno anche sbrigati con la massima attenzione e sollecitudine.
– E chi vi ha detto che quello che debbo dirvi io non sia importante della stessa maniera e forse di più di ciò che vi ha comunicato don Antonio? Basta, io non sono una tigre o una pantera che voglio sbranarvi per ciò: sono donna, e perciò facile a perdonare. Sedete al mio fianco ed attentamente ascoltate quello che debbo dirvi.
Il giovane, che non era certamente privo di sangue nelle vene e che nell’entrare in quella profumata atmosfera di già si trovava sotto la sensuale influenza di tanto profumo e solleticato da quella a bella posta preparata mezza luce, si trovava in una certa disposizione di anima e di corpo che non si può descrivere, ma che certamente la maggior parte dei nostri lettori avranno qualche volta provata, e tale da favorire i progetti della Contessa. I sensi eccitati, come dicemmo, dai vapori squisiti che si sviluppavano in quella stanza; la vista deliziata da tanto gaio apparecchio; la mente esaltata, vedendosi in compagnia di una donna a cui non si sbagliava per certo dandole il predicato di bella; e soprattutto la vita che a venticinque o ventisei anni scorreva rigogliosa nelle vene di Ernesto, il quale, quantunque maltrattato fino a due giorni prima dalla fortuna e bersagliato da tutte le privazioni, pure aveva avuto il tempo di rimettersi, mercé buoni cibi e bevande preziose; e tutto ciò nell’età in cui basta un tantino di benessere per ridonare completamente la forza, la vita, la salute e la floridezza.
Sedutosi quindi vicino ad Erminia e semplicemente guardandola s’intese salire le fiamme al volto ed un calore insolito gli percorse tutto il corpo, non perché sentisse sorgere per lei nel cuore una fiamma di amore, perché in esso aveva sede e regno Emilia, ma perché essendo [egli] uomo [ed] Erminia dotata di tutti i pregi per sedurre, aveva di già cominciato a fare effetto.
La Contessa, da accorta conoscitrice, vide tutto quello che aveva potuto già fare e si consolò entro se stessa, prevedendo che non si sarebbe fatto molto aspettare il desiderato trionfo, e gettando sul giovinotto una prima occhiata, nella quale si racchiudeva tutto un programma di lascivia, finse di cominciare a palesargli ciò che doveva per affari della rivoluzione, ed in effetti gli disse qualche cosa che a questa rapportava; ma in un istante, spezzato un tale discorso, bruscamente gli domandò se egli amava alcuna donna o pur no. Ernesto ripose:
– Una buona fanciulla, una compagna d’infanzia.
– E che pensate farne di essa?
– Quello che ogni uomo onesto pensa di fare di colei che ama davvero: la mia sposa.
– Di che età è dessa?
– Oltre i diciotto.
– È bella?
– Modesta ed avvenente quanto possa essersi.
– Può paragonarsi, senza superbia, a me?
Ernesto restò stupefatto a questa domanda, ma considerando che era necessario dare una risposta alla domanda della signora, disse:
– Perdonatemi, Contessa; ma il paragone da voi proposto non regge. La mia innamorata è fornita di grazie e di vezzi, ma è sempre una giovinetta nascosta alla società, destinata a far l’ornamento di una modesta e civil famiglia, priva perciò di tutto quello che può servire ad abbellire o coltivare lo spirito, a raffinarne le grazie, come voi [che], slanciata in mezzo alla primaria società, avete tutto ciò che è necessario per rendervi gradita, amata e venerata da tutti [coloro] che vi attorniano e vi conoscono. Nel suo sguardo c’è una vereconda dolcezza, nel suo modo di esprimersi si appalesa l’innocenza; ma reggere al vostro paragone sarebbe superbia sperarlo, sarebbe improntitudine pretenderlo, sarebbe un voler rimanere schiacciata, un combattere ad armi ineguali, ma molto, molto ineguali.
– Dunque io sono più bella di lei?
– Ma sicuramente.
– E tu l’ami?
– E perché non dovrei amarla?
– Perché potresti invece amare me.
– Voi!
– Che, dal primo momento che ti vidi, restai abbagliata dalla tua cara fisionomia, dal tuo nobile portamento, e che t’amo, t’amo quanto non puoi immaginare!
Sulle prime Ernesto diventò tutto di fuoco; lo parole della Contessa ed il modo col quale erano state pronunciate erano talmente eccitanti e terribili, che anche un eremita della Tebaide avrebbe ceduto ad esse. Ernesto, però, coprendosi dell’egida della sua modestia e dell’amore che portava a sua madre e ad Emilia, cominciò col resistere, ma di quella resistenza fiacca, che è poco meno che cedere, ed a misura che gli eccitamenti posti in campo dalla bella donnina, la quale a misura che si avanzava la conversazione, più si sentiva presa dal demonio della lussuria e raddoppiava con forti colpi gli assalti al cuore ed ai sensi di Ernesto, e finalmente a simiglianza della egiziana moglie di Putifarre, afferrato il moderno, non molto casto Giuseppe, riuscì a legarlo al suo carro, facendo che egli, per poco obliando la pura Emilia e la idea della liberazione della cara patria, si fosse immerso nell’amore dell’impudica e lasciva cospiratrice, che invece di seguitare a parlargli del risorgimento d’Italia e delle sue glorie passate e future, lo trattenne fino a notte avanzata discorrendogli di lei, del suo amore e dei piaceri presenti, che le erano a cuore più di tutte le utopie di cui si vantava propugnatrice.
Avanzatasi la notte, finito il classico colloquio e ricevuti dalla Contessa gli ordini e le disposizioni le più importanti che si sono accennate, Ernesto andò via da quella casa, ancora sotto l’impero di una eccitazione sensuale da non potersi descrivere; giunto però sulla via il fresco della notte, il moto che faceva ed i pensieri del novello stato che aveva abbracciato fecero per poco calmare la tempesta che aveva nell’anima ed egli a poco a poco si calmò, cominciò a riflettere sulla stranezza dell’avventura occorsagli e quasi quasi non poteva persuadersi di quello che era accaduto.
Rifletteva a come era stato possibile che una signora di tanto alto bordo come la Contessa avesse potuto innamorarsi di lui, ma di ciò non poteva dubitare punto, poiché i fatti succeduti erano di tanta chiarezza e certezza storica, che inutilmente potevano negarsi o distruggersi. In secondo luogo interrogava se stesso, dicendo se era possibile che egli, cresciuto ed educato nei più sani e santi principi di religione e di morale, avesse potuto commettere un errore pari a quello dal quale or ora veniva d’aver commesso. Però, in questo punto, si fermava e diceva esser perdonabile il suo fallo, stanteché è permesso al savio di peccare sette volte al giorno[1], e perciò esser egli degno di perdono di aver fallito una sola volta; ma quando cercava di scendere nel più profondo dell’anima sua e cercava di scorgervi quale delle due immagini delle donne ci si trovasse scolpita, vi trovava sempre quella della bella, pura e modesta vergine Emilia, mentre quella della Contessa, sebbene più gaia e più lusinghiera, più gradita forse pel momento, non ve la trovava che disegnata leggermente e la mirava volare come un’ombra vagante, di maniera che si persuadeva essere stato quello un semplice episodio della sua vita, episodio che non avrebbe potuto portare delle conseguenze; e per rinfocolarsi vieppiù in questo pensiero e scacciare totalmente la memoria di colei che lo aveva affascinato, pensò di affrettare il passo, di correre a casa, stringere prima al suo seno la genitrice e poi rivolgersi ad Emilia, alla quale in quella sera rivolse le più care premure e tenerezze, che consolarono la povera fanciulla, cui formalmente aveva deciso volere al più presto sposare, pensando in se stesso essere anzi quello un mezzo onde così sottrarsi alle strette di quella biscia innamorata che lo avrebbe altrimenti schiacciato, stringendolo fortemente nelle sue spire.
Povero Ernesto! Si apponeva al vero, e ciò lo vedremo.
Capitolo VII. Il 1859
Le cose stavano su questo piede e pel momento bisogna sospendere la narrazione dei fatti che appartengono particolarmente al seguito di questo racconto, e guardare un poco più largamente gli avvenimenti dell’anno susseguente a quello nel quale abbiamo fatto principiare questa storia, anno che per i fatti che si svolsero fu il precursore dello scoppio della rivoluzione con tutta arte preparata, fu il sostrato di tutta quella rovina nella quale disgraziatamente siamo piombati a nome della libertà e della rigenerazione.
Tre grandi avvenimenti che si legano perfettamente con la nostra storia successero in quell’anno: il primo fu il matrimonio dell’infelice figliuolo della Santa[2] Maria Cristina, matrimonio che fu il segnale di tutti i guai piovuti addosso alla dinastia dei Borboni di Napoli, mentre doveva essere l’avvenimento che rafforzar doveva di più la loro potenza e la gloriosa loro storia; il secondo fatto, che produsse l’intero sviluppo della rivoluzione, fu l’esito disgraziato per le armi austriache della guerra combattuta in Lombardia contro i franco-piemontesi; e l’ultimo la procurata malattia a cui segui la morte di Ferdinando ii, che fu spinto nella tomba dalla perfidia e dal tradimento, essendo stata ben colta l’occasione per ciò fare e con tutta la finezza portata innanzi la scelleraggine di cui vi fu bisogno per levare di mezzo quella gran figura, ostacolo dei rivoluzionari, che aveva fino allora saputo strozzare l’Idra dalle cento teste e l’avrebbe sempre seguitata a ricacciare in inferno, se non fosse stata troncata la sua vita immaturamente e proditoriamente.
Il matrimonio dei giovani Principi ed il viaggio fatto dalla intera Corte aveva provocato in quasi tutte le province una eccitazione nei popoli, l’amore dei quali verso i loro legittimi Sovrani era conosciuto e proverbiale; per tutti i luoghi per dove i Reali di Napoli transitavano, le prove di affetto candido e spontaneo erano immense; si acclamavano, si ammiravano, si veneravano i Sovrani; mille feste e buoni auguri si preparavano per le nozze auspicate e benedette; il cuore veramente parlava ed in tutto quello che appariva esternamente non v’era nulla di procurato, di effimero, di ufficiale. Però i rivoluzionari non stavano con le mani alla cintola ed in quello che[3] i popoli plaudivano ai loro padroni, giubilando e festeggiandoli con tutta la possibile cordialità ed ingenuità della gioia, essi ardivano mischiare a quell’entusiasmo il veleno, facendo sussurrare da mille bocche, da mille insinuatori, esser quelle nozze più che un bene, un immenso danno per l’Italia tutta, restringendo di più i vincoli della tirannia, la quale dall’unione delle due case Austriaca e Napolitana sarebbe venuta più di potenza a quest’ultima, che col forte appoggio dell’altra, avrebbe sempre di più schiacciato il capo dei popoli sotto un governo esoso, perfido, traditore che, come lo aveva chiamato un furbo statista inglese[4] si ripeteva da pappagalli ammodernatori, essere il governo della Negazione di Dio.
A queste inique insinuazioni si aggiungevano le manovre della setta la quale cercava spargere nel volgo ignorante delle perfide menzogne circa la coppia augusta dei novelli sposi. Ritornato il Re in Caserta, dove la sua malattia progredì e poscia per conseguenza successe la morte di quel grande Sovrano, la setta alzò maggiormente la testa e, resasi vieppiù baldanzosa, lavorava dì e notte per far cadere in discredito della popolazione la coppia reale novella.
La guerra intanto seguitava e, principiata con buoni auspici per l’Austria nel mentre combatteva solamente con i Piemontesi, travolse in rovina non appena si verificò il precipitoso arrivo dell’esercito francese con i primi alleati, il quale in molti scontri e battaglie riuscì a superare gli eroici sforzi dei soldati di Asburgo e dopo le due micidiali battaglie di Magenta e Solferino[5], che tolsero di conseguenza al Tedesco la speranza di più potersi sostenere e dopo la pace di Villafranca[6] – mercé la quale la Francia acquistò la Lombardia che poi mercanteggiò vendendola al Piemonte mercé la cessione vergognosa di Nizza e di Savoia – la potenza di questo piccolo regno si accrebbe in modo, che immediatamente si diede mano all’altre rivoluzioni dei singoli Stati della Penisola e con arti subdole e con inganni e sotterfugi indegni della gran causa tanto strombettata successe l’adesione, o per dir meglio la usurpazione, dei Ducati di Parma e di Modena e quella più originale e perfidamente ottenuta della Toscana, che tutte unite al già proclamato Regno d’Italia, ingrandirono sempre più quella potenza che doveva tutto travolgere, tutto annientare delle antiche singole istituzioni e legislazioni preesistenti, per supplire le con altre più insulse, vessatorie, immorali e tali da distruggere il benessere e far troppo tardi comprendere anche agli uomini di partito, ma forniti di buon senso, il male che avevano fatto prestando la loro mano ad un’opera di usurpazione e spoliazione.
L’osso più duro a rosicchiarsi era il Regno delle Due Sicilie, il quale però era anch’esso minato, e fortemente minato, come abbiamo di già veduto in altro luogo; la propaganda rivoluzionaria aveva molto lavorato e tuttavia lavorava con assiduità per giungere allo scopo di far tradire la regnante Dinastia e far che il nostro povero Paese fosse andato anche a formar parte del così detto Regno d’Italia e fosse anch’esso ridotto allo stremo come tutto il resto, che altro non ha raccolto da questa aberrazione delle menti che miseria, debiti, obbrobrio e, invece di libertà, oppressione ed immoralità.
Re Ferdinando nel maggio 1859 andò a sedersi fra i beati del Paradiso, tale essendo il posto che gli spettava, perché pio, religioso, onesto, giusto e fornito di somma ed infinita carità cristiana. Francesco ii era salito al trono, e non appena lo era, si cominciarono a vedere i progressi che la rivoluzione otteneva ed il dissolvimento del governo. I Consiglieri della Corona, vinti o dall’oro della propaganda o dai vezzi delle Aspasie – alla cui testa era la famigerata Contessa – o da ambiziose future mire, erano diventati tutti traditori e non si arrestavano mai dal consigliare sempre il male al giovine Principe.
Di tradimento in tradimento, il breve Regno di Francesco ii, quantunque gloriosissimo, camminando oltrepassò il 1859 e giunta l’alba funesta del susseguente 1860, la rivoluzione di già prima bellamente preparata in modo da non poter mancare, cominciò a suscitarsi in Sicilia; da prima quasi domata, rinfocolata poscia dal famigerato sbarco del generale Garibaldi, che tutti hanno voluto strombazzare come eroico e portentoso, mentre in sostanza non fu che un colpo di scena da dramma d’arena, ben preparato dai commediografi ed eseguito dai commedianti subalpini; esso però produsse in tutta la Trinacria uno scoppio violentissimo che non potette essere ostacolato perché di già la lue venefica del tradimento aveva preso piede in tutti gli ordini dei preposti al governo di quell’isola e specialmente dei comandanti l’esercito, in modo che fecero sacrificare le fedeli milizie, che dettero sempre saggio di buon volere, di coraggio e di valentia, ma che abbandonate da chi le guidava e tradite barbaramente, dovettero soccombere e cedere una vittoria a della gente, che se per poco si fosse da tutti fatto da vero, non avrebbe potuto resistere alla loro presenza nemmeno un istante.
La conquista della Sicilia fu fatta; si buccinava[7] di volersi intraprendere quella del continente e si preparava di già uno sbarco in Calabria. Gl’inesperti e di buona fede giuravano esser quella un impresa avventata del Garibaldi e che in Calabria si sarebbero spuntate le sue armi dandosi da se stesso la zappa su i piedi, credendo che tutto ciò che era succeduto in Sicilia fosse stato vero, mentre che come si è detto non era altro che l’opera di sfacciati e spudorati traditori. Le truppe ritirate nel continente offrivano ancora un corpo di esercito rispettabile e tale da ben poter resistere non solo, ma vincere e distruggere le orde garibaldine; ma il veleno serpeggiava ed esso rodeva le viscere di tutti ed anche nel continente produsse i medesimi effetti che aveva prodotto nell’isola, lo sfasciamento cioè di ogni ordine militare, la defezione dei capi, l’annientamento di una forza bastante ancora a sostenere il governo e la gloriosa dinastia dei Borboni, facendo perdere la più bella di tutte le cause e di uno dei più floridi e potenti reami che in quel tempo in Europa fra i secondari si trovava.
A chi ne fu la causa, il rimorso; a chi volle coprirsi col mantello del traditore, mentre avrebbe potuto essere un Eroe, tutta la responsabilità dei mali.
Noi proseguiamo la nostra narrazione.
Garibaldi avanzava a grandi passi, il Regno era quasi conquistato, con l’aiuto dello straniero; Francesco ii però era in trono, sempre malamente consigliato ed abbindolato da chi aveva in quei giorni la somma delle cose e che, mettendo innanzi un malinteso amore del natio loco, consigliò la celebre dipartita per Capua e Gaeta, l’allontanamento di tutte le forze dalla Capitale, colla folle speranza di un pronto ritorno glorioso, per quanto poteva aver figura di vile fuga la partenza.
La costituzione nel mese di giugno era data; tutto camminava, perché una rappresentanza nazionale avesse dato mano ad una novella legislazione; ma gli avvenimenti su espressi rovesciarono tutte le preconcette speranze dei buoni ed il 7 settembre finalmente arrivò, nel quale giorno perpetratosi il più orribile delitto di spoliazione che possa immaginarsi e la perdizione di tutta l’Italia; ed il novello Gedeone, al suono delle sue trombe, vide cadere le mura della novella Gerico ed il palazzo Doria accolse il generale Garibaldi.
Tutto ciò che abbiamo di volo accennato appartiene alla parte che storica, quello però in questi fatti ebbero ad operare i personaggi da noi posti finora in scena, lo diremo man mano e nei capitoli seguenti.
[1] «Se il giusto cade sette volte, egli si rialza». Proverbi 24,16.
[2] Così veniva chiamata dal popolo Maria Cristina (1812-1836), Regina di Napoli, ufficialmente beatificata il 25 gennaio 2014 (ricorrenza 31 gennaio).
[3] In quello che: mentre.
[4] Lord Gladstone (1809-1898), futuro Primo Ministro inglese, nel 1851 pubblicò due pretese lettere a Lord Aberdeen (allora Primo Ministro in carica), esprimendo giudizi estremamente negativi sul governo dei Borbone, definito come la «negazione di Dio in terra eretta a sistema di governo». Le affermazioni furono in seguito ritirate, ma l’infamante giudizio continuò a circolare – e tuttora circola – per l’intera Europa.
[5] Combattute rispettivamente il 4 e il 24 giugno 1859.
[6] Stipulata tra Napoleone iii e Francesco Giuseppe l’11 luglio 1859.
[7] Si strombazzava (la bùccina è un antico tipo di tromba).



 invio in corso...
invio in corso...



