“Ernesto il disingannato” (romanzo del 1874) a cura di Gianandrea de Antonellis (XI)
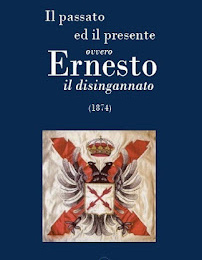
Capitolo XIII. I Prefetti
Allontanatasi dalla casa al vico Longo, Erminia, spumante di rabbia e meditando le più atroci e terribili infamie, attraversò diverse vie come una forsennata; i suoi occhi quasi non vedevano tutto quello che succedeva, la sua mente vacillava, e la rabbia la spingeva in tal maniera nel camminare, che diverse volte dovette soffrirsi gl’insulti ed i maltrattamenti di chi, credendola folle o avvinazzata, la maltrattava lungo la via che giva percorrendo.
Giunta alla marina, corse ad una barchetta e postasi in quella, disse al barcaiolo:
– A Portici.
Perché prese la via del mare e non quella di terra?
Perché si fece recare colà?
Scelse la via di mare sperando nella brezza marina e nel lieve venticello che spirava un refrigerio all’immenso calore che la tormentava, al fuoco che le rodeva le viscere ed il cervello; e per essere meno osservata nel tragitto che far doveva.
Si fece condurre in Portici, perché colà abitava una certa persona a cui ella voleva rivolgersi, onde dar principio ad un nero progetto del quale strada facendo aveva formato il nefando disegno.
Arrivata in Portici e discesa dalla barca che l’aveva guidata[1], s’inoltrò in una piccola strada che nella sinistra di quella consolare si ritrovava, e quindi girate diverse altre piccole vie. uscita sulla campagna, si trovò di faccia alla porta di un piccolo chiassuolo[2] nel quale inoltratasi, entrò in una oscura stamberga nella quale non si vedeva quasi traccia[3] [di vita] umana; appena però ella emise due volte un piccolo grido[4], da una scaletta che guidava sotto terra uscì una figura che pochissimo aveva dell’umano e che, comprendendo il suono che aveva emesso la Contessa, disse:
– Chi è che mi appella?
– Io.
– Chi siete voi?
– La Contessa.
– Voi, Eccellenza! Ed a che siete venuta fin qui?
– Ho bisogno di te.
– Forza di Dio! Una signora vostra può aver bisogno del più infelice essere di questa terra?…
– Purtuttavia il fatto è vero, ho bisogno di te.
– Comandate.
E ciò dicendo l’essere misterioso che aveva fin allora parlato salì e si mostrò alla Contessa. Egli era un uomo che dai pochi peli bianchi che aveva sul cocuzzolo e dall’incurvatura a cui forzava la sua alta statura lo avresti giudicato per lo meno giunto al suo diciottesimo lustro; ma egli non contava che un anno al di là dei sessanta e si trovava in quello stato mercé la pravissima vita menata in gioventù, poiché egli si era dato completamente a tutti i vizi che la scelleraggine e l’abbrutimento umano possono produrre nel cuore dell’uomo.
Quell’uomo si chiamava Bernardo.
– Comandate. – replicò non appena fu tutto fuori dal sotterraneo dal quale usciva.
– Una vendetta mi è necessaria.
– Breve, o lenta?
– Lenta, ma terribile.
– E chiedete?
– Una di quelle tue boccettine che tu ben sai.
– Un altro amante non gradito da uccidere?
– No; ma un essere molto più delicato di un uomo: una giovinetta ventiquattrenne.
– Ho capito: una rivale?
– Precisamente così.
– Volete dunque?
– Ti ripeto: una boccettina.
– È bella e preparata.
Immediatamente quell’uomo ritornò nel bugigattolo d’onde era uscito ed indi ne venne fuori recando una piccola fialetta che consegnò alla Contessa, riscuotendone il prezzo di sei scudi.
– Per quanto tempo avete bisogno dell’effetto di questo mio liquore?
– Per almeno un tre mesi.
– Non più che tre gocce ogni giorno in una qualunque siasi bevanda.
– L’effetto?
– È sicuro, lo avete esperimentato col vostro tiranno, il Militare che avete ultimamente ucciso, dopo di averlo reso un traditore della sua patria.
– Silenzio su di ciò, ed addio.
– Che il cielo vi feliciti.
La Contessa partì, Bernardo ritornò nel suo sotterraneo e tutto allora rimase sepolto in un profondo oblio.
***
Il matrimonio di Ernesto camminava tranquillamente: Emilia lo rendeva veramente felice ed egli, illuso ancora dalle sue idee emancipatrici, stava nella ferma credenza di aver definitivamente giovato alla sua patria, mentre l’aveva indegnamente tradita. Occupato un impiego principale, Ernesto credeva che le cose dovessero camminare veramente secondo la giustizia e l’equità; ma a poco a poco si accorse che non era più quella la guida delle azioni dei così detti rappresentanti della libertà.
I liberali, divenuti alla loro volta più tiranni degli stessi tiranni, angariavano, malmenavano, uccidevano, tormentavano i popoli e soprattutto pensavano – sempre per il bene loro! – a spogliarli, togliendogli fin l’ultimo quattrino che aver potessero.
Tasse inique, balzelli rovinosi, imposte incredibili or da questo or da quell’altro ministro si proponevano; ed un parlamento evirato e servile non cessare mai di approvarle, perché i contribuenti morissero di fame e le diverse casse, non dello Stato, ma degli usurai e degli speculatori, antichi martiri e benemeriti, si arricchissero e raccogliessero tutto quello che si poteva di più. Fra gli altri benefizi arrecatici dai moderni Soloni e Licurghi vi fu quello del corso forzoso[5], crittogama[6] del commercio, peste della vita sociale, invenzione diabolica che ha finito di succhiare quel poco di sangue che ancora esisteva nelle nostre vene.
Erano passati due mesi dall’ultima scena succeduta tra Erminia ed Ernesto nel giorno del fatale plebiscito ed uno e mezzo dal matrimonio di costui con Emilia, quando nel giorno in cui era partita pel suo paese una fanticella[7], che i novelli sposi avevano di già presa al loro servizio, fu presentata in casa loro, da uno dei così detti pubblici sensali, una donnetta di nome Giovanna, oltre i cinquant’anni, pulita in aspetto, ma mesta e quasi canuta, addimostrando nei suoi modi e nel suo favellare essere piuttosto di buona nascita che dell’ultima classe del popolo. La signora Martina ed Emilia, a cui fu presentata per essere presa a servire appo loro, innamorate dai modi gentili e commosse da una storia dolorosa da essa narrata, colla quale diceva di essere stata spinta nella estrema miseria mercé una quantità di vicende disgraziate, e ricordandosi dei tempi trascorsi, quando per loro era avvenuto lo stesso, s’invogliarono a prenderla in casa e, convenuto su tutto ciò che era necessario, fin da quel medesimo giorno ella entrò a servire nella famiglia di Ernesto.
Nei primi giorni si mostrò attenta ed assidua alle sue cure, gentile con tutti e massimamente diede segni di ottima ed intemerata morale, cosa che tanto ad Ernesto – quantunque appartenesse a coloro che di morale poco facevano sfoggio, stante le idee nuove predominanti – e tanto alla signora Martina, donna tagliata all’antica ed educata con severissimi e sani principi, persuadeva molto e perciò a poco a poco ottenne l’intera confidenza dei suoi padroni.
Nulla in quella casa si faceva, senza l’approvazione ed il parere di Giovanna: tutto passava per le sue mani ed essa non era capace di defraudare i suoi padroni di un semplice soldo; insomma in quella casa si era ritrovata la vera Araba Fenice, e sotto le spoglie di una serva, che la faceva diventare davvero molto più rara dello stesso uccello immaginario.
Chi però avesse guardato in viso Giovanna, nei momenti che la famiglia era riunita ed i due giovani sposi fra di loro conversavano, dandosi vicendevolmente delle tenere prove d’affetto e specialmente quando la sera essi si ritiravano nella loro stanza od uscivano qualche volta insieme, avrebbe veduto negli occhi di Giovanna un certo fulgore sinistro che indicava quasi rabbia e dispetto, nonché dolore e sofferenza commiste insieme; e se l’avesse potuto seguire allorché restava sola per poco o nella sua stanzetta o in altri luoghi ed in tutti i momenti che poteva rimanervi, avrebbe intesi uscire dal profondo del suo cuore certi sospiri che per certo l’avrebbero fatto giudicare esser quella donna condannata dalla sorte a soffrire gravissime pene; e se poi si fosse dato cura di seguirla in tutte le sue azioni, avrebbe potuto verificare che non sempre le sue parole spiravano mansuetudine ed abnegazione, ma molte volte indicavano rabbia e dolore; e che nei momenti che preparava e serviva il pranzo era presa da certi brividi, specialmente allorché apprestava delle bevande alla giovine sposa, tutta fiduciosa in lei ed amica sua strettissima.
Ernesto un giorno fu chiamato da una lettera del suo antico protettore don Antonio presso il signor Bartolomeo, il celebre cassiere, che già tutti conoscono. Recatosi colà, assistette ad una strana conversazione e gli fu fatta una proposizione che lo fece inorridire e fremere nel medesimo tempo e lo fece raccapricciare.
– Buongiorno, mio caro Ernesto – principiò don Antonio – come va la salute e gli affari?
– Per riguardo alla prima, benissimo, per gli altri vi dirò francamente che l’andamento delle cose come di presente camminano non mi piace ed io, che occupo un impiego piuttosto cospicuo, posso attestarlo. La giustizia non è la base delle nostre leggi e gli amministrati, più che lodarsi dei loro amministratori, hanno a dolersene fortemente.
– Giustizia!… Mi meraviglio di te!… Ma come, ormai è molto tempo che sei in un posto eminente e non hai ancora compreso che questa, nel presente stato di cose, è una parola vuota di senso?
– Come!?…
– Così è. Egoismo, ecco il dogma principale dei moderni legislatori: benessere personale! I popoli sono un pretesto: essi non devono far altro che guardare il nostro bene individuale, pagare, lasciarsi scorticare e versare il loro sangue per far arricchire dei pochi nullatenenti che hanno un tantino più di giudizio degli altri. Una magnifica operazione è necessaria farsi adesso, e tutti e tre diventeremo al di là di tre Cresi.
– Possibile! Ma in qual modo?
– Tu conservi delle carte di somma importanza per l’azienda finanziaria del Regno.
– È verissimo. Il mio impiego mi mette a disposizione carte tali che se si sperdessero o si involassero, moltissimi denari potrebbero essere trafugati con somma facilità.
– Ed appunto di queste dobbiamo parlarti: tu devi far sparire quella carte.
– Ma in tal modo io commetto un furto al governo!
– Scioccone! Ed il governo con la tante tasse, non commette un furto ai contribuenti, obbligandoli a sborsare quello che non possono? Sii buono, ed immediatamente la somma rilevante di trecentomila lire sarà divisa fra noi tre e poscia ognuno, prendendo una via per l’estero, andrà a godersi il bel bottino, senza più incaricarsi di questa baraonda che ogni giorno succede senza benefizio di nessuno.
– V’ingannate: io non commetto di simili azioni! E poi mi meraviglio di voi, un tempo ferventi di amor di patria, che avete fatto tanto per riscattarla dal servaggio ed ora cercate di commettere un simile delitto e depredarla!
– Amor di patria! E tu veramente credevi a questo amor di patria? Va là, che sei pure un gran novizio[8]! Tutte quelle belle parole erano l’esca che portar doveva gli uccelli alla pania; ma il vero amore che muoveva noialtri non era che il nostro; tu ti sei trovato unito a noi per combinazione: profittane anche tu, e felicissima notte!
– Non commetterò giammai un furto!
– Furto? Ma non è tale.
– È un furto, e la mia morale, la mia probità, l’onor mio non mi permettono di acconsentire a ciò che voi mi proponete; io parto, e pensate che se un’altra volta mi si farà una simile proposizione, io sarò capace di palesare il tutto e rovinarvi. Addio, signori, addio.
Dette queste parole, andò via più che indignato da quella casa e con la mente preoccupata da tali pensieri dispiacevoli, che non si può immaginare. Si levava dinanzi ai suoi occhi una benda fatale, un mistero gli si palesava che lo faceva fremere e tutto il sublime del già fatto fino allora spariva innanzi ad una realtà spaventevole e schifosa.
Povero Ernesto, non aveva ancora compreso quali erano gli uomini coi quali fin’allora aveva trattato, qual era lo scopo da essi avuto; l’averlo compreso gli costò un terribile fatto, peggiore di molto a quello che lo minacciava quando era quasi prossimo a gettarsi giù dal ponte della Sanità.
Capitolo XIV. Le Vendette
È ora di far comprendere al lettore tutto ciò che avveniva in casa di Ernesto dal momento che Giovanna era colà entrata a servire e tutto quello che dopo il colloquio avuto con don Bartolomeo e don Antonio succedette al nostro protagonista.
Fin dal primo giorno che la nuova donna di servizio prese a praticare nella casa dei suoi padroni, il roseo dalle guance della giovine sposa incominciò a sparire: un languore insoffribile, una spossatezza irreparabile si erano impadroniti completamente di lei e per quanto le cure del marito, della suocera e dell’arte medica avessero potuto fare, non si aveva potuto in verun modo riparare; da principio fu giudicata questa incipiente malsania come un effetto del cambiamento che ordinariamente si produce nelle donne nel principio del fenomeno naturale che le porta ad essere madri; ma poscia fu giudicato il contrario, quando si vide che da tutt’altra causa la malsania proveniva. Ernesto si affaticava a rassicurare la sua sposa, la quale, caduta in tetra melanconia, piangeva giorno e notte; la buona Martina, mentre deplorava il male di sua nuora, pure si persuadeva che in fin dei conti non si fosse trattato che di cose molto lievi e confortava la giovinetta dicendole che il suo male sarebbe al più presto possibile espulso; la stessa Giovanna cercava con dolci parole e con atti amorevoli allontanare le paure da che era assalita la soffrente; ma tutto era inutile e per quanto si fosse praticato sia dall’arte salutare, sia dall’amorevolezza degl’individui di famiglia, la calma non ritornava nel cuore di Emilia, né la salute nel suo corpo.
Ernesto si affliggeva e più di prima circondava di amore e di affezione la sua giovine sposa, la copriva di baci, la stringeva al seno e secolei s’intratteneva le intere ore, tutte quelle infine, che poteva involare alle sue occupazioni, all’impiego che occupava.
Le cose erano su questo piede, allorché un bel giorno l’infelice marito, nel ritirarsi in casa, trovò talmente prostrata di forze la sua compagna, che ne rimase spaventato; la madre e Giovanna che l’assistevano assicurarono il disgraziato che ormai la faccenda era grave e che i frequenti deliqui e deliri da cui la povera ammalata era colpita facevano molto dubitare della sua salute e della sua vita. Ora, mentre il disgraziato Ernesto cercava di procurare dei rimedi al male così avanzato di colei che adorava, un ordine pressantissimo ed imprevisto lo chiamò presso i suoi superiori e la ricerca di quelle tali carte, che già gli si era proposto di far sparire, arrivò come un colpo di fulmine pel miserello.
Volle egli mostrare quelle carte, che dopo il fatto del colloquio avuto aveva gelosamente serbate portando con sé sempre la chiave di un tavolo dove le aveva nascoste, ma non fu possibile rinvenirle, quantunque niun segno di violenza fosse comparso nel ripostiglio dov’egli le aveva di già serrate.
Cercò giustificarsi l’infelice; ma le sue parole non furono ascoltate; prima di denunciare l’avvenuta conversazione con don Antonio e don Bartolomeo, si recò presso costoro ad interpellarli circa quello che era avvenuto, essendo egli più che sicuro che essi avessero perpetrato il furto; ma trovò in loro due statue di marmo: negarono tutto e gettarono anzi su di lui tutto il delitto, dicendo che essi in sostanza non avevano fatto che una proposta al fine di scandagliare il suo cuore e la sua morale, e che egli, vestendosi dei panni di entusiasta e spacciandola da Catone, aveva poi definitivamente eseguito per suo conto quello che in apparenza gli era stato proposto per conto di altri.
Furono vane le querele, vane le dimostrazioni: i due barbassori[9], essendo due conosciutissimi liberaloni e Padri della Patria erano immuni da ogni sospetto, mentre che Ernesto, meno di loro conosciuto e più esposto alle calunnie ed alle offese, raccolse tutta l’odiosità del delitto commesso.
La carte erano distrutte, le trecentomila lire sparite, il vuoto[10] esisteva, via di salvamento non c’era alcuna. Ernesto fu arrestato e condotto alle prigioni. E ciò nel mentre la malattia lenta ed indefinibile di Emilia faceva rapidi passi.
La costernazione era grandissima, sia col disgraziato giovine, sia nella desolata famiglia che in un momento si vedeva di nuovo piombata nella miseria, non avendo Ernesto vissuto fin’allora che con il suo semplice stipendio, né avendo potuto o saputo accumulare denaro, come avevano fatto molti o quasi tutti i rappresentanti dell’Unità italiana.
Un abile avvocato, mercé l’aiuto della legge e di quel poco che poté ricavarsi dalla vendita di molti oggetti di casa di Ernesto, riuscì ad ottenere per lui, con molto stento, una libertà provvisoria e giunse questa in tempo, ché le notizie della malattia di Emilia giunte fino al carcere erano tali che quasi quasi facevano dubitare che suo marito non avesse potuto nemmeno più vederla.
Emilia, povera disgraziata, non più a lunghi periodi, non più a giornate, ma ad ore e a minuti languiva: si vedeva mancare in lei l’elemento vitale ed i suoi giorni oramai erano contati.
Ernesto, posto appena il piede fuori del carcere, corse alla sua magione e, rivedendo in quell’orribile stato la disgraziata consorte, proruppe in lagrime ed avrebbe voluto dar quanto gli restava di vita per salvare quella della sua cara, ma le ore passavano, i giorni si succedevano e l’ultimo soffio dell’esistenza di quella povera donna si estingueva a colpo d’occhio.
Erano passati otto soli giorni da che Ernesto era uscito di prigione mercé la libertà provvisoria ed Emilia, peggiorando sempre si estingueva come lume cui manca l’alimento; ed arrivati a quel giorno, sul sorgere dell’alba, un fievole suo lamento fece accorrere tutti presso al suo letto e mentre il marito, sostenendola fra le sue braccia, la sorreggeva amorevolmente e Giovanna le porgeva un cordiale per darle un poco di forza, la misera Martina, mal sapendo reggere ai dolori della povera sofferente, vestitasi in fretta, corse in traccia di un medico e di un prete perché si apprestassero gli ultimi conforti della religione all’ammalata.
– Ernesto… – con fioca e quasi spenta voce disse Emilia – Ernesto… io ti lascio, la mia vita è estinta, pochi altri momenti di vita mi restano… deh!, prima ch’io muoia dammi almeno un ultimo bacio e sappi che io veramente portavo il seno già carco di crescente prole… ma Iddio, che mi diede tanta forza per amarti, ora mi toglie quella per poter essere felice con te… Non obliarmi giammai e nei momenti che penserai a me quando sarai solo, rammentati del puro e sincero mio affetto e promettimi che di colei… di quella donna che un tempo tentò strapparmi il tuo cuore… non ti rammenterai più, che scaccerai sempre dal tuo cuore la sua immagine… poiché dessa, oh!, dessa è la sola origine di questo mio lento malore… dessa ha prodotto la mia completa distruzione e forse attende con ansia il punto in cui tu, rimasto di nuovo libero, ti rivolga di nuovo a lei, per abbindolarti di nuovo e farti servire ai suoi turpi desideri, alle sue infami azioni…
– Non nominarmi colei! – rispose Ernesto – Io la esecro, l’abborro, la disprezzo! Tu sola, tu sola, dichiaro che sei sempre stata l’anima mia, tu sola che m’hai fatto felice con la tua ingenua grazia, colla tua innocenza, col vivo, puro ed immenso affetto col quale m’hai amato!
A queste parole un rivolo di lagrime fu visto scorgere sul pallido volto di Giovanna, che da Ernesto furono interpretate per lagrime di dolore alla vista delle sofferenze della povera giovinetta che si vedeva mancare da momento in momento; ma mentre si accostava di più alla soffrente introducendole con un cucchiaio poche gocce del cordiale che già le veniva somministrando, la guardava con occhio di fuoco e significativo.
Martina non ancora era tornata; poco oltre un quarto d’ora era passato da che Emilia aveva mandato il primo gemito, quando un secondo e molto più fievole dell’altro annunziò che l’ora era squillata e che appena pochi altri secondi restavano da vivere a quella macchina oramai consunta.
– Emilia! Emilia! – gridò Ernesto – Emilia mia!
E si accostò di più per darle un casto bacio nelle smorte labbra, ma non potette far altro che baciare un corpo di già completamente inalgidito[11]: Emilia era cadavere.
– È morta! esclamò il meschino ! È morta!
– Morta? – gridò Giovanna, con grido pari a quello della iena, e slanciandosi sul corpo inanimato, lo tastò tutto, si assicurò che nemmeno un soffio solo di vita le restava e poscia con un secondo grido, più feroce del primo:
– È morta! – replicò.
– Giovanna!… – esclamò meravigliato Ernesto, colpito dal tono inesplicabile col quale Giovanna emetteva quelle parole.
– No, che io non sono Giovanna, traditore! No che io non sono la serva! Ma ravvisami, sono la tradita Erminia, colei che essendosi completamente sacrificata a te, si è veduta negletta, oppressa, avvilita e discacciata; ma ricordati quel giorno del Plebiscito: tu mi lasciasti così barbaramente ed io giurai vendetta. Ora quella vendetta è compita: colei è discesa nella tomba, spintavi da me, da me lentamente avvelenata.
– Avvelenata!…
– Sì, ed è questa la prima mia vendetta. Fra breve la più terribile scenderà ancora sul tuo capo e di già ne hai veduto il principio: tu sarai condannato come ladro e l’onor tuo, come il tuo amore, saranno distrutti nel medesimo momento.
– Infame!
– Non chiamarmi infame, perché tu, tu solo mi hai spinto a commettere una così lunga sequela di delitti. Ora, che Iddio ti punisca; ti disprezzo e calpesto col piede le belle sembianze della mia rivale.
Dette queste parole unì l’atto brutale al detto ed alzando un piede percosse il bello e casto viso dell’estinta Emilia, con modo così feroce, che lo sventurato Ernesto, quantunque esasperato dallo sdegno, non ebbe la forza di scagliarsi su quella tigre, che fuggì con tutta la possibile rapidità, mentre egli, sentendosi mancare le forze, cadde come corpo morto, vicino al cadavere della sua diletta.
Al ritorno della signora Martina col medico e col prete, trovò quel triste spettacolo e gelando di spavento, si diede tosto a soccorrere l’infelice figliolo, che immediatamente fu assalito da fortissima febbre che per diversi giorni lo fece stare in forse della vita, mentre il cadavere della estinta Emilia in quelle ore pomeridiane fu trasporto al cimitero in mezzo al pianto universale.
Dopo circa venti giorni la forza della febbre cedette ed Ernesto ritornò sano; ma il suo cuore era ferito, la sua mente troppo persuasa degli errori commessi e mentre sperava di rimettersi e calmarsi, cercando di ritirarsi in qualche piccolo paesetto insieme a sua madre, la giustizia lo reclamò di nuovo e la discussione della causa del furto commesso lo ricondusse in carcere; ma però, mercé la difesa di uno dei migliori uomini del nostro foro e le niune prove del delitto a suo carico, egli ne uscì con piccola condanna di pochi mesi, computato anche il tempo già espletato prima del giudizio, di modo che pochissimo fu il tempo della sua pena e subitamente ritornò nel grembo di sua madre, che anche perché di grave età ed affranta da molti dolori ed acciacchi, discese nella tomba nel brevissimo tempo di pochi mesi.
[1] Portata.
[2] Vicolo particolarmente stretto.
[3] Nel testo: «orma».
[4] Frase leggermente adattata.
[5] Il corso forzoso o sistema a carta moneta inconvertibile (imposto con il Regio decreto 2873 del 1º maggio 1866) prevede – tuttora – la non convertibilità tra la moneta (carta stampata) e l’equivalente in metallo prezioso (oro e argento).
[6] Parassita.
[7] Cameriera.
[8] Novellino.
[9] Che si danno molte arie; saccentoni.
[10] L’ammanco.
[11] Freddo.



 invio in corso...
invio in corso...



