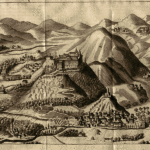Eroi e Briganti di FRANCESCO SAVERIO NITTI

L’Italia è la terra degli Eroi
Molte volte negli anni della adolescenza io ho copiato questo aforisma nei quaderni di calligrafia. E pure nella preoccupazione del rotondo e del gotico, dei profili e dei chiaroscuri, la mia mente inesperta si chiedeva: e perché dunque l’Italia è la terra degli eroi? La storia che ci è stata insegnata nelle scuole medie, quando non è un’arida successione di nomi e di date, è una successione di matrimoni, di congiure e di morti. Ogni tanto, in questa storia che è d’ordinario molto noiosa, appare l’eroe: l’uomo che personifica tutta un’epoca, l’uomo il quale fa ciò che tutti gli altri uomini dovrebbero fare.
Nei piccoli trattati, dalla storia di Grecia e di Roma alla rivoluzione francese e ai moti per la liberazione d’Italia è breve il passo: e nella mente rimane tutta una confusione. Il popolo giace sotto la tirannia di un solo, cui nessuno osa ribellarsi: l’eroe liberatore interviene a tempo. Un colpo di pugnale e una congiura vittoriosa fanno ciò che la folla non sa fare. Qualche volta è un paese intero che soggiace allo straniero, e n’è liberato per l’opera eroica di un solo. E poiché i matrimoni, le date, le genealogie de’ regnanti non c’interessano, noi ricordiamo soltanto i nomi e le azioni degli eroi; essi personificano per noi tutti un tempo: e la mente inesperta mette insieme gli eroi di Salamina e di Maratona, gli Orazii (o infidi!), i Fabii, Cesare, Bruto, gli eroi della rivoluzione francese, Garibaldi e i nostri.
La concezione di Carlyle, in realtà, non è che la concezione dei fanciulli delle nostre scuole: l’umanità che progredisce, che si emancipa per mezzo degli eroi.
“Secondo io la intendo (ha scritto Carlyle) la storia universale, la storia di quanto l’uomo ha compiuto sulla terra, è, in fondo, la storia dei grandi uomini, che quaggiù lavorarono. Quei grandi furono gli informatori, i modelli e, in largo senso, i creatori di quanto la massa generale degli uomini riesci a compiere e a raggiungere; tutte le cose che vediamo compiute nel mondo sono propriamente l’esteriore materiale resultato, la pratica attuazione e incarnazione di pensieri, che albergarono nei grandi quaggiù inviati: la loro storia potrebbe giustamente considerarsi come l’anima della storia di tutto il mondo”.
Non vi è niente di meno vero.
Quegli uomini i quali a noi pare che abbiano guidato il mondo, sono stati essi medesimi l’espressione di bisogni, di società e di popoli determinati. Gli stessi uomini che ci sembrano più fuori e al di sopra del loro tempo, ne sono stati quasi sempre il prodotto. Noi non possiamo concepire Garibaldi nelle circostanze attuali: farebbe egli l’ostruzionismo? sarebbe egli contro? quali idee avrebbe sul regime doganale? Si occuperebbe di che cosa? Se Napoleone fosse nato in India o in Cina che cosa sarebbe stato? Nulla forse. Quella vita che è stata uno dei più grandi fatti storici, sarebbe rimasta un piccolo fatto biologico, la nascita e la morte di un individuo tra le migliaia di milioni di uomini passati da allora per il mondo. Gli uomini più insigni, i più forti e i più grandi non sono dunque qualche cosa al di fuori degli altri esseri: ma essi sono coloro i quali riescono a rappresentare l’anima collettiva, o il bisogno di una minoranza più audace e più forte.
La storia eroica quale noi insegnano e quale noi abbiamo imparata, rassomiglia, in certo modo, a una geografia che si occupi solo della descrizione delle montagne. La più grande parte della superficie terrestre è occupata da grandi pianure, da colline ondulate: le immense montagne rappresentano una minima parte, e ancora sono per la vita degli uomini meno importanti. Le alpi nevose rimangono nei nostri occhi più dell’infinita pianura: pure è quest’ultima che costituisce grandissima parte della superficie in cui viviamo.
“Così i dettagli della storia ci sfuggono. L’umanità, nel suo lungo viaggio, non ha conservato che il ricordo di alcuni precipizi, dimenticando la continuità monotona delle pianure felici che ha traversato. Noi non siamo una folla immemore o ingrata; più sensibile ai sogni che ai successi, così nel passato come nel presente. Il successo, perché la folla lo noti e lo ricordi, deve essere accompagnato da un cataclisma”.
Ma la storia vera, quella che val più la pena di penetrare, è la storia collettiva, la storia delle grandi masse umane, dei grandi aggregati di cui noi indaghiamo solo alcune espressioni e non sempre le più felici. È una specie di pigrizia di mente quella per cui noi vogliamo spiegarci la storia mediante le opere di alcuni uomini: quand’anche furono grandissimi non poterono esser tali che per contingenze particolari, e perché interpretarono bisogni collettivi o sentimenti in formazione.
L’eroe silenzioso, come dice Carlyle, l’eroe che vive di se stesso e dalla sua anima ricava tutto, non è mai esistito né esisterà mai. Ma l’ammetterlo dà a noi una debolezza: poiché ci fa rassegnare a una specie di fatalismo buddista. Tante volte noi diciamo in un momento difficile: manca l’uomo. E attendiamo l’uomo provvidenziale. Anche adesso, nelle difficoltà dell’Italia presente, che sono prova del suo sviluppo, anche adesso noi ci domandiamo se tutto non finirebbe se avessimo un uomo. E bene: l’uomo è in noi stessi: è in ognuno di noi, e quando vorremo trovarlo noi lo ritroveremo.
Se non esistono uomini che vivano fuori e sopra il loro tempo è – noto che colui il quale ha trovato l’espressione di superuomo, Federico Nietzsche, ha finito, povero ueber mensch, in un manicomio – vi sono però uomini i quali riescono a compiere opere straordinarie e a fare ciò che la folla non riesce né meno a concepire.
In questo senso vi sono gli eroi. Quando un paese è soggetto a dominazione e la folla si rassegna, vi è un uomo che si ribella solo o con pochi; se egli non ha quasi speranza di vincere, se egli fa ciò che la moltitudine crede folle, egli è veramente un eroe. E allora o che il suo sangue sia lievito di rivolgimenti futuri, o ch’egli stesso vinca, nell’un caso e nell’altro è sempre un eroe. Ma l’eroe in questo senso non è che la espressione di un male: cioè della bassezza collettiva. I popoli che hanno nella civiltà moderna maggior numero di eroi, sono quelli che hanno una più grande depressione.
L’eroe è colui il quale osa da solo ciò che moltissimi altri dovrebbero fare. Se la folla si rassegna vi è chi si immola. Egli è dunque l’eroe, cioè la espressione altissima di un bisogno ideale di un paese depresso. Più la massa è depressa, più la coscienza collettiva è bassa, più il sentimento del dovere individuale è debole, più grande è il numero degli eroi e spesso più grande è il loro eroismo. Quanti eroi nella Grecia, quanti nella rivoluzione nostra, quanti nella Turchia odierna! Quanti sono che tentano nel silenzio e nel dolore, quanti per un solo che vince o vincerà soggiacciono! Ma un paese ove l’educazione popolare è elevata, un paese ove la coscienza collettiva si è formata, dove tutti fanno il loro dovere, non ha eroi.
Gl’Italiani si rassegnavano alla servitù e tanti eroi si sacrificarono per destarli dal sonno. Vi fu chi andò a morire in una impresa disperata, come Pisacane; chi come Garibaldi tentò un’impresa fortunata e arditissima. Felici o infelici per il risultato, la loro anima era sempre immensa. Ma in un paese ove la educazione delle masse si è formata, ove ognuno ha il sentimento della responsabilità sua, l’eroe non è possibile.
Nelson è stato un grande marino e Moltke un tattico grandissimo. Ma il vincitore di Trafalgar che vedeva e prevedeva, che aveva ai suoi ordini marinai fieri, devoti, era egli un eroe? Ed è stato forse un eroe Moltke? Il sommo condottiero dei tedeschi era uno scienziato. La sua faccia scarna e seria di “chimico matematico” corrispondeva ad un uomo che guadagnava le battaglie in fondo al suo studio con l’algebra. Il paese ove tutti fanno il loro dovere, il paese ove la solidarietà è grande, non ha eroi: può avere grandi tecnici, grandi condottieri, politici avveduti, uomini insigni per scienza: non ha eroi.
L’eroe è come la montagna che non sorge dalla scorza terrestre, se non avendo intorno valli profonde: i paesi di montagna sono pieni di valli fonde: vi è l’estrema altezza e vi è l’abisso. I paesi che più contano eroi non hanno raggiunto che un debole grado di sviluppo e di solidarietà.
L’Italia, nel tempo della sua depressione, ha avuto grandissimo numero di eroi: appunto perché il valore sociale della folla era scarso. Ora noi valiamo di più e può darsi che manchino alcune cime, poiché mancano pure gli abissi. E i tentativi più eroici sono partiti sempre dall’Italia meridionale, dove appunto la coscienza collettiva era meno alta e dove la natura del paese permetteva concepire piani audacissimi e sperare nella riuscita di essi.
La leggenda dei quaranta normanni, che sbarcati in Salerno conquistarono il reame di Napoli in pochi giorni, non è così inverosimile se a tanti secoli di distanza furono possibili tentativi come quelli di Ruffo o di Garibaldi. Garibaldi che con pochi uomini sbarca in Sicilia e traversa quasi senza colpo ferire, fino al Volturno, un regno che aveva centomila soldati, pare quasi una leggenda; una leggenda cui non crederemmo se non ne avessimo conosciuti gli attori. Ebbene, il fenomeno della spedizione dei mille va studiato in rapporto a tutta la storia del passato. Spedizioni come quella dei mille per la libertà o per la reazione, per la unità o la difesa del vecchio regime, tante se ne son tentate! In 61 anni, cioè, dal 1799 al 1860, dal cardinal Ruffo a Garibaldi gli eroi i quali hanno con pochissimi audaci tentato nel Mezzogiorno imprese cui la ragione si ribella, sono stati tanti! Noi non ammiriamo che i vincitori: anzi noi non vediamo che il successo finale. Se Pisacane fosse riuscito qualche anno prima e non avesse lasciato la vita ai piedi del colle di Sanza, noi lo glorificheremmo ora sì come Garibaldi. Se i due fratelli Bandiera nel tentativo quasi folle per sublime eroismo, non fossero stati trattenuti nella triste terra di Calabria, poco dopo lo sbarco, i loro nomi sarebbero passati alla storia circondati di ben altra aureola che quella del martirio infelice. Dal tentativo che un cardinale di Santa Chiesa, Fabrizio Ruffo, fece con successo completo di ridare al suo re tutto un regno da cui era fuggito, e di ridarglielo scendendo in lotta con pochi uomini, fino al tentativo di Garibaldi è una serie di tentativi eroici: di cui assai lungo sarebbe il dire, se non bastasse ricordare le sedizioni di Morelli e Silvati, e le spedizioni dei Bandiera e di Pisacane.
In fondo, l’itinerario di Ruffo è stato la guida per i tentativi posteriori. Nel 1799 il re Ferdinando I era dovuto fuggire in Sicilia (la fuga fu poi per la sua famiglia quasi una istituzione) e lasciare Napoli al piccolo esercito francese. La repubblica partenopea era stata proclamata e il re, perduto lo Stato continentale, si era ricoverato nella Sicilia. Ora, il tentativo di riprendere con le armi regie le province insorte, pareva quasi disperato. Se non che un cardinale di curia che parea più esperto nel gioco che nell’arte militare, concepì un piano arditissimo. Un piano così ardito, che pare quasi temerario, se si pensi soprattutto che chi lo tentava non era uomo d’armi. Il cardinale Fabrizio Ruffo, dunque, decise di partire dalla Sicilia e senza nessun esercito riconquistare al re il regno. Partì con pochi fedeli, sbarcò a Bagnara ch’era suo feudo; pochi contadini furono il primo nucleo del suo esercito.
Il suo piano era semplice. Egli sapeva che nel Mezzogiorno grande era l’odio fra le classi medie e le plebi rurali, e volea smuovere queste ultime a favore della monarchia e del re. Voleva smuoverle eccitandole contro la borghesia; i giacobini appartenevano alle classi medie, il popolo non avrebbe tardato a trasformare ogni proprietario in giacobino. Era la guerra sociale in favore del legittimismo o della reazione. Il cardinale Ruffo è stato descritto come un ribaldo. Egli era migliore del suo re e della sua riputazione; egli fu sotto tutti gli aspetti un eroe. Che cosa si deve pensare di chi non essendo che ecclesiastico e non avendo, come abbiamo detto, pratica d’armi, si decide quasi solo a riconquistare a un re profugo un intero regno? Noi giudichiamo gli uomini di parte nostra in un modo, e gli uomini di parte avversa in un altro. Se Ruffo avesse compiuto la stessa impresa per scacciare i Borboni, piuttosto che per restaurarli, se avesse l’eroica e crudele impresa compiuto in servizio della libertà, egli parrebbe quasi un uomo divino. Il cardinale Ruffo non aveva soldati: riunì gli uomini che poteva riunire, contadini che desideravano vendicarsi, poveri che desideravano predare e perfino briganti. Potea fare altrimenti? potea egli, che non avea quasi nessuno seco, contare su altri? Sbarcato sul lido di Calabria in febbraio del 1799 il cardinale, che avea con sé pochi familiari e qualche prete, giunse ai primi di giugno sotto le mura di Napoli. In cinque mesi egli riconquistò a Ferdinando I un regno. Il suo viaggio fu presso a poco quello che per causa opposta sessant’anni dopo compì Garibaldi.
Tranne che il cardinale Ruffo, per conquistare anche le Puglie descrisse nel suo viaggio un grande arco di cerchio prima di giungere a Napoli. Fu accolto, dice il Colletta, con pazza gioia dalla plebe.
E perché fu accolto? Dovea egli anche nel male avere l’eroismo che trascina. Coloro che lo seguivano erano spesso predoni di campagna e ladroni crudeli. Ma chi, mettendosi a compiere un’impresa quasi disperata, può scegliere i compagni? Furono crudeli? e non furono a Sansevero e a Gragnano crudeli anche i francesi? Il generale Vatrin non fu egli peggiore? Se l’espressione “lotta di classe” va usata a proposito una volta, è nell’avventura dei cardinale Ruffo: egli si servì veramente dell’odio fra le plebi rurali e la borghesia, per riconquistare il trono al re; egli calcolò appunto su quel dissidio per riuscire.
Poche cose sono più straordinarie di vedere un chierico con poche turbe raccogliticce fare ciò che un esercito intero non aveva saputo. Che importa se egli operò per una causa che non è la nostra? che importa se egli rese possibile la reazione più crudele? Egli fu un eroe, perché compì atto di straordinaria audacia, avventura quasi inverosimile per la causa in cui credeva.
Dall’avventura di Ruffo, che fu il trionfo della reazione, alla riescita della spedizione dei mille di Garibaldi, che fu il trionfo più grande per la unità, intercedono 61 anni. In questo breve tempo, quante volte la spedizione di Ruffo esaltò le menti dei liberali! Perché ciò che un prete aveva fatto per la causa dei Borboni non si potea ripetere contro di essi? Perché diffuse le file di una cospirazione non bastavano pochi uomini audaci a rovesciare il trono borbonico? Le menti degli esuli nelle veglie ardenti quante volte sognarono di seguire il piano di Ruffo per una causa opposta! Qualche volta, come nel 1820, non fu nemmeno necessario uno sbarco; furono pochi ufficiali che tentarono una rivolta e che produssero, sia pure per breve tempo, mutamenti negli ordini costituzionali. Ma la spedizione di Ruffo rimase la mèta e il sogno. Poterla ripetere per la causa liberale! potere arditamente rifare per la libertà il viaggio trionfale del prelato reazionario! L’Italia meridionale è stata e sarà sempre la zona più adatta ai rivolgimenti improvvisi. Nel nostro secolo, se le guerre con lo straniero sono state combattute nella valle del Po, tutti i tentativi rivoluzionari o quasi tutti sono cominciati nell’Italia meridionale. Questa terra, che ha più coste litoranee di tutto il resto d’Italia, che misura una lunghezza assai grande e non permette concentramenti facili, rende possibili i colpi di mano improvvisi. La Calabria lanciata nel mare è traversata in tutta la sua lunghezza da una catena di monti. Abitanti di paesi messi solo a 15 o 20 chilometri di distanza, in versanti opposti, non hanno spesso nessun commercio, non si conoscono nemmeno. Ora vi sono grandi linee ferroviarie in senso longitudinale; vi sono strade numerose. Ma quando le comunicazioni eran difficili, come prima del 1860, uno sbarco di pochi audaci in Sicilia o in Calabria, o sulla costa del Cilento potea avere conseguenze grandissime. Garibaldi trionfò, ma prima di lui quante giovani vite furono recise! quanti prodi morirono vittime del miraggio ingannatore! Erano eroi veri; poiché si attribuivano un compito immenso nella indifferenza di tutti; alcuni fallirono per troppa audacia, altri per incoscienza giovanile, altri perché non misurarono le loro forze e non conobbero tutte le difficoltà. Di tutte le spedizioni che precedettero l’impresa eroica di Garibaldi, le due più interessanti furono quella dei fratelli Bandiera e quella di Carlo Pisacane; l’una per l’eroica ingenuità con cui i due giovani s’immolarono nella speranza, più che della vittoria, del martirio che avrebbe ridestato gli spiriti; la seconda per l’uomo che la concepì. Attilio ed Emilio Bandiera erano figlioli di un contrammiraglio della marina austriaca, di cui essi stessi facevano parte, l’uno come alfiere di vascello e l’altro come alfiere di fregata. Non volendo servire l’Austria, dopo aver preso parte ad alcuni moti rivoluzionari, essi si erano ricoverati a Corfù. E in quel contatto con altri esuli in terra straniera; in quel comunicarsi continuo di aspirazioni e di speranze, più rincresceva loro l’inedia che l’esilio. Ond’è che decisero una spedizione arditissima, quasi folle per ardimento. Insieme a Ricciotti, a Moro e a pochi audacissimi, pensarono di compiere uno sbarco sulle coste di Calabria. Ivi avrebbero cercato di far rivoltare le popolazioni calabresi e, se fossero riesciti, di mettere in fiamme tutto il regno di Napoli.
Nel 1844, nella notte dal 12 al 13 giugno, i due fratelli Bandiera partirono per la spiaggia calabrese. Era in essi presentimento di morte. Quasi al momento di partire Nicola Ricciotti ed Emilio Bandiera così scrivevano a Garibaldi: “Se soccomberemo, dite ai nostri concittadini che imitino l’esempio, poiché la vita ci venne data per utilmente impiegarla; e la causa per la quale avremo combattuto e saremo morti, è la più pura, la più santa che mai abbia scaldato i petti degli uomini; essa è quella della libertà, della eguaglianza, della umanità, dell’indipendenza, dell’unità d’Italia”.
Erano buoni e sinceri: aveano soprattutto la giovanile ingenuità senza di che non è possibile compiere né tentare imprese come quella cui essi si avventuravano. La sera del 16 giugno il piccolo drappello sbarcò sulla costa calabrese, alla foce dei fiume Nebo. Il luogo dello sbarco era tristissimo: ma la terra d’Italia parve a essi sacra e la baciarono all’arrivo. Il piccolo drappello, mal guidato, inesperto dei luoghi, aveva anche nel suo seno chi dovea tradirlo. Gli esuli speravano di trovare al loro arrivo popolazioni desiderose di rivolte: e trovarono l’ostilità e la indifferenza. Nella valle di San Giovanni in Fiore – paese già sacro alla leggenda religiosa – circuiti da soldati del re, dopo disperata lotta in cui parecchi morirono, dovettero arrendersi. Un mese dopo, i due fratelli Bandiera furono fucilati, il 25 luglio, in quella stessa terra da cui avevano sperato partisse il segnale della rivolta.
Mai nessuna morte fu più compianta della loro. Erano giovani, ricchi, di alto casato: avevano rinunziato con serenità superumana a tutte le gioie della vita. Aveano tutte le qualità per destare negli animi il compianto, e la loro morte fu una delle cose che più nocquero a Ferdinando II. Ma non fu vana morte; Alessandro Poerio canta: Bevve la terra italica Del vostro sangue l’onda, E piova più feconda Giammai non penetrò.
La loro tomba sarebbe diventata luogo di pellegrinaggio, se parecchi anni dopo un generale crudelissimo non avesse fatto con scellerata e sacrilega idea profanare il nobile sepolcro, e non ne avesse fatto confondere le ossa dei due martiri con quelle dei malfattori comuni. Che importa! Vi è qualche cosa che non si uccide, vi è qualche cosa che non può essere profanata da alcuno; che non ha da temere di nulla; ed è il ricordo della bontà eroica, della grandezza infelice. Quello dei Bandiera era un tentativo che non potea riescire: poiché si basava sopra cose che non erano. Pure nessun tentativo è circondato di tanta poesia come questo: per il fatto stesso ch’era irrealizzabile, per la ingenuità con cui fu compiuto.
Ma nessuna iniziativa fra tutte quelle compiute prima delle spedizioni di Garibaldi fu più interessante di quella di Pisacane; meno per il tentativo rivoluzionario che per l’uomo che n’era a capo: meno per ciò che fece che per ciò che si proponeva di fare. Carlo Pisacane, napoletano, era stato in situazione autorevole e importante nello stato maggiore delle due Sicilie; era di nobile famiglia; era sopra tutto un’anima inquieta, desiderosa di novità. Avea combattuto in Africa contro gli arabi; a Roma a Porta San Pancrazio; era esule a Genova nel 1857. Basandosi su relazioni inesatte, contando sopra movimenti patriottici delle popolazioni meridionali, concepì l’idea audace di sbarcare sulla costa salernitana nel Cilento, di sollevare le popolazioni, di congiungersi ad altri ribelli di Basilicata e di giungere in Napoli a capo di un esercito numeroso e ribelle.
L’idea di Ruffo, che dovea più tardi presiedere alla spedizione di Garibaldi, era anche nella mente di Pisacane. Solo egli abbreviava le distanze, e sperava giungere come per sorpresa sulla capitale. Carlo Pisacane era un anarchico. Egli non adoperava questa parola che allora non era in uso, benché Proudhon l’avesse già introdotta. Ma nella sua dottrina contenuta nel libro Saggio sulla rivoluzione si manifesta sinceramente anarchico.
Che cosa è l’anarchia? È la conseguenza estrema del liberalismo, e si basa soprattutto su due concetti: sulla credenza che gli uomini abbiano una tendenza naturale a lavorare, a produrre, ad associarsi, e sull’altra credenza che gli uomini siano guastati dalle leggi. Queste, in certa guisa, rappresentano un male, poiché sono la violenza contro l’ordine naturale delle cose. Come tutte le dottrine estreme, anche l’anarchia si basa sull’ottimismo; ma appunto per questo ha un fascino di attrazione sulle anime semplici e sugli spiriti indocili. Essa trascina gl’ingenui e i violenti. Quello che è stato chiamato più tardi il materialismo storico, la concezione marxistica della storia è chiaramente tracciata nell’opera di Pisacane, il quale riattaccava i fatti politici ai fenomeni della produzione. Alcuni brani della sua opera sembrano scritti ora, tanta è la modernità che l’ispira.
“Tutte le leggi, tutte le riforme, eziandio quelle in apparenza popolari, favoriscono solamente la classe ricca e culta, imperocché le istituzioni sociali, per la loro natura, volgono tutte in suo vantaggio. Voi plebe, allorché crederete avvicinarvi alla mèta, ne andrete invece più lontano. Voi lavorate, gli oziosi gioiscono; voi producete, gli oziosi dissipano; voi combattete ed essi godono la libertà. Il suffragio universale è un inganno. Come il vostro voto può esser libero, se la vostra esistenza dipende dal salario del padrone, dalle concessioni del proprietario? Voi indubbiamente voterete costretti dal bisogno come quelli vorranno. Come il vostro voto può esser giusto, se la miseria vi condanna perpetua ignoranza e vi toglie ogni abilità per giudicare degli uomini e dei loro concetti?”.
Se la rivoluzione fosse riescita vincitrice, Pisacane avea un piano per abolire la proprietà privata, e trasformarla in proprietà comune; abolire lo Stato e andare incontro a una specie di comunismo della produzione. Poi che era fuori della realtà, non vedeva e non sentiva tutte le difficoltà che la natura delle cose opponeva a tutti i suoi piani; come ogni anarchico egli vedeva il male non già nella natura e nelle difficoltà limitatrici inerenti all’anima umana, ma nella volontà degli uomini: uno sforzo di una minoranza audace parea a lui dovesse bastare a tutto. Pure come l’errore ha il fascino e l’illusione ha le dita di rose, alcune pagine di Pisacane non si rileggono né meno adesso senza commozione.
Quando s’imbarcò per Sapri egli avea già quarant’anni; avea molto combattuto, molto visto.
Nella sua vita irregolare in ogni senso irregolare avea perduto le illusioni giovanili, che contrassegnano la spedizione dei Bandiera; egli era in ogni senso un uomo maturo. La sua spedizione, avvenuta nel 1857, fu fatta dunque con piena coscienza delle difficoltà, anzi con la quasi certezza della morte.
E prima di partire da Genova il 24 giugno 1857 egli volle dettare il suo testamento politico: poche pagine che neppure quelle si possono leggere senza emozione profonda. Dopo aver affermato la sua fede socialista e aver notato che solo da una rivoluzione sociale potrà venir bene all’umanità, Pisacane dichiarava la sua antipatia per i movimenti costituzionali: “… per me non farei il minimo sacrificio per cangiare un ministro, per ottenere una costituzione; non meno per cacciare gli austriaci dalla Lombardia ed accrescere il regno Sardo; per me dominio di casa Savoia e dominio di casa d’Austria è precisamente lo stesso. Credo eziandio che il reggimento costituzionale dei Piemonte sia più dannoso all’Italia che la tirannide di Ferdinando II. Credo fermamente che se il Piemonte fosse stato retto nella guisa medesima degli altri Stati italiani, la rivoluzione sarebbe fatta. Questo mio convincimento emerge dall’altro, che la propaganda dell’idea è una chimera, che l’educazione del popolo è un assurdo. Le idee risultano dai fatti, non questi da quelle ed il popolo non sarà libero quando sarà educato, ma sarà educato quando sarà libero”.
La rivoluzione doveva risultare da sforzi individuali. “Alcuni dicono che la rivoluzione deve farla il paese; ciò è incontestabile. Ma il paese è composto di individui, e poniamo il caso che tutti aspettassero questo giorno senza congiurare, la rivoluzione non scoppierebbe mai; invece se tutti dicessero: la rivoluzione deve farla il paese di cui io sono una particella infinitesimale, epperò ho anche la mia parte infinitesimale da compiere, e la compio, la rivoluzione sarebbe immediatamente gigante”.
Dopo aver detto che egli si recava a Sapri nel principato Citeriore e aver dichiarato lo scopo della impresa, Pisacane affermava: “Non ho che i miei affetti o la mia vita da sacrificare a questo scopo, e non dubito a farlo. Sono persuaso che se l’impresa riesce avrò il plauso universale; se fallisce il biasimo di tutti; mi diranno stolto, ambizioso, turbolento, e molti che mai nulla fanno e passano la vita consumando gli altri, esamineranno minutamente la cosa, porranno a nudo i miei errori; mi daranno la colpa di non esser riuscito per difetto di mente, di cuore, di energia… ma costoro sappiano che io li credo non solo incapaci di fare quello che io ho tentato, ma incapaci di pensarlo”.
Dopo aver parlato di altre imprese e opere audaci, che avevano incontrato diffidenza e avversione, Pisacane continuava: “Non voglio paragonare la mia impresa a quelle, ma essa ha un lato comune con esse: la disapprovazione universale prima di riescire e dopo il disastro, e l’ammirazione dopo un felice risultamento. Se Napoleone prima di partire dall’Elba per isbarcare a Fréjus con 50 granatieri, avesse chiesto consiglio altrui, tutti avrebbero disapprovato una tale idea.
Napoleone avea il prestigio del suo nome; io porto sulla bandiera quanti affetti e quante speranze ha con sé la rivoluzione italiana; combattono a mio favore tutti i dolori e tutte le miserie della nazione italiana.
“Riassumo: se non riesco, disprezzo profondamente l’ignobile volgo che mi condanna, ed apprezzo poco il suo plauso in caso di riuscita. Tutta la mia ambizione, tutto il mio premio lo trovo nel fondo della mia coscienza e nel cuore di quei cari e generosi amici che hanno cooperato e diviso i miei palpiti e le mie speranze; e se mai nessun bene frutterà all’Italia il nostro sacrifizio, sarà sempre una gloria trovar gente che volenteroso s’immola al suo avvenire”.
La sincerità del sentimento, la certezza del sacrifizio che Pisacane andava a compiere, vengono fuori da ogni parola. Pisacane era in certa guisa l’anarchico che per una contraddizione sentimentale andava a compiere un movimento politico unitario; era l’anarchico, il quale però non discuteva dei mezzi, e, perché alle forme politiche non credeva, tutto avrebbe tentato. I suoi compagni non eran tutti degnissimi, ed egli avrebbe vuotato volentieri le carceri per prendere chiunque potesse aiutarlo, appartenesse pure al ritiro della società. Non involgeva egli in una stessa avversione i difensori del sistema politico e i difensori del sistema economico? Le fasi della spedizione è inutile raccontarle qui, né dire com’essa fu ideata e con quali mezzi.
Pisacane insieme con 22 compagni, fondando su promesse in gran parte incerte e contando sull’incontro di forti nuclei che Rosolino Pilo dovea condurre dalla Sicilia, la sera del 25 giugno 1857 si imbarcò a Genova insieme a soli 22 compagni su un piroscafo della compagnia Rubattino.
L’incontro con Pilo non avvenne; ma Pisacane con mezzi così scarsi volle nondimeno tentare la fortuna e, consenziente il capitano della nave, fece uno sbarco temerario a Ponza, liberò molti relegati politici e riunì in tutto 323 uomini. Contava altri uomini trovare al momento dello sbarco a Sapri, e tentativi di rivolta nelle province.
La sera del 29 giugno, quando il “Cagliari” operò lo sbarco a Sapri, non trovò quasi nulla.
Lo sbarco avvenne in quella dolce costa di Sapri, dov’è tanto cielo e tanto mare, in cui gli aranci sono boschi ed è come una primavera eterna. Dopo aver dichiarato decaduto il Governo di Ferdinando II, Pisacane e i suoi compagni cercavano smuovere le popolazioni. Ma non trovarono che indifferenza. Chi erano costoro? donde venivano? che cosa volevano? Il cardinal Ruffo era uomo di Chiesa, e avea il prestigio della rossa porpora e della croce d’oro e parlava il linguaggio della passione e della violenza ed eccitava gli odii locali e metteva il popolo contro la borghesia. Ma che cosa volevano coloro che sbarcavano a Sapri? Il drappello procedette nella indifferente avversione popolare. Dopo Sapri il paesaggio diventa montuoso. Sono monti petrosi, piccole pianure piene di sterpi, alberi nani. La spedizione sbarcata cosi giocondamente nelle vie di Sapri, dovè provare un presentimento di morte traversando quel paesaggio di malinconia.
L’avviso era stato dato in tempo, e i soldati e i gendarmi erano in moto. La piccola spedizione non si era accresciuta che di pochi uomini, quando sulla collina detta Morge dei Piesco, incontrò le forze regie. Dopo accanito combattimento in cui era per vincere, l’arrivo di truppe reali del settimo cacciatori costrinse la spedizione a ritirarsi, lasciando sul terreno cinquantasei morti, oltre trenta feriti e circa duecento prigionieri. Nella ritirata Pisacane contava internarsi nei boschi e andare a far insorgere il Cilento. Ma a poca distanza gli uomini della spedizione, giunti sotto il passo di Sanza, così triste con le sue case nere, furono assaliti da una turba di contadini e in gran parte uccisi, o feriti, o presi. Pisacane stesso fu ucciso: ed egli che avea sognato il trionfo o una morte eroica, combattendo in pieno sole, giacque ucciso dai contadini in una campagna triste. Era per essi uno straniero? era un nemico? Ma la spedizione di Pisacane fu il prodromo di fatto ben più grande: della spedizione di Garibaldi. Solo due anni dopo, la spedizione di Garibaldi partiva dallo scoglio di Quarto, diretta verso la Sicilia e portava la rivolta nel Mezzogiorno, in cui già per la incapacità del capo il governo era in dissoluzione. Altri ha parlato della spedizione di Marsala: e non v’è alcuno che ne ignori la quasi leggendaria fortuna. Per uno strano caso Garibaldi, sbarcato con piccola resistenza in Sicilia, la traversava trionfalmente; sbarcava sul continente ed entrava in Napoli da trionfatore. Che cosa un tentativo sì eroico rese possibile? E perché poté esso riescire? Sembra quasi inverosimile che un regno in cui erano centomila soldati sia caduto rapidamente nelle mani di pochi uomini, che avevano cosi deboli mezzi.
Ebbene, o signori, nel senso opposto che cosa era stata 61 anni prima la spedizione di Ruffo? Un tentativo eroico legittimista avea anche allora riconquistato al re un paese che era nelle mani dei francesi e dei liberali. E si può dire che la spedizione di Ruffo non sia stata la preparazione di tutte le seguenti fatte nel senso contrario? Io ho parlato dell’Italia meridionale poiché essa è stata il paese ove le spedizioni più temerarie sono avvenute, vincitrici o perditrici, in breve volgere di anni. Ma in tutta Italia quanti atti di eroismo dimenticati, quanti uomini morti nel silenzio e nel dolore, quanti periti in quella primavera dei sentimento che fu il movimento per l’unità. Benedetti i forti, i buoni, gli audaci, coloro che hanno lottato e sofferto; benedetti più ancora quelli che noi non ricordiamo e che nessuno ricorderà più! L’Italia è stata e sarà la terra degli eroi.
Se l’eroe è colui il quale compie da solo cose straordinarie, o tenta di compierle, e per esse muore, l’Italia è stata la terra sacra degli eroi. Pure da questo fatto che dimostra l’intima virtù della nostra gente, noi dobbiamo trarre ragione di intima tristezza.
Perché l’Italia è stata la terra degli eroi? Perché in essa era debole il sentimento della responsabilità individuale; perché la cultura individuale era bassa; perché mancava quello spirito di solidarietà, di disciplina, che hanno avuto altri paesi più educati, o più fortunati. Da noi è accaduto spesso che un solo ha cercato di compiere quelle grandi opere che dovevano venir fuori dalla coscienza collettiva. Ond’è rimasto a noi un senso di faziosità, di superbia, una violenza individuale, una sfiducia nella democrazia dei nostri ordini. Poiché gli uomini non si misurano e la tradizione passata impera, noi siamo rimasti il paese sacro alle rivolte. Se l’azione di pochi uomini può tutto; se un uomo solo può arrogarsi di fare ciò che dovrebbe un popolo; se non vi sono necessità che s’impongano; la faziosità che è già nell’istinto entra anche nella coscienza. In Italia noi scontiamo ancora le antiche illusioni.
Pure nelle scuole continuiamo a dire che l’Italia è la terra degli eroi; pure continuiamo a lodare la violenza individuale; a riconoscere i tentativi violenti di sommosse del passato non già come episodi finiti, ma come qualche cosa di grande e d’imitabile. Siamo giunti perfino a lodare il regicidio, ad ammirarlo, a descriverne i benefizi; quasi che fosse lecito uccidere per una ragione o per un’altra. E poi ci meravigliamo che la nostra democrazia nuova invece di avere quelle qualità di ordine, di metodo, di disciplina, senza di cui nessuna democrazia è durevole, sia di sua natura faziosa. Abbiamo lodato il regicidio e deploriamo la violenza individuale; riempiamo le teste giovanili di ricordi, di cospirazioni, di sette, di rivolte, e pretendiamo la disciplina e la solidarietà; insegnammo una storia eroica, cioè una storia di rivolte individuali e ogni rivolta individuale ci sorprende.
Il popolo non ama le distinzioni; né sa persuadersi che, se il fine è buono, sopprimere un re assoluto sia bene e sopprimere un re costituzionale sia male. L’anima popolare ama ciò che è semplice, ciò che è chiaro, ciò che è evidente. Quello che è più meraviglioso non è che l’unità italiana si sia fatta, ma che si sia mantenuta. Ora al popolo noi dobbiamo parlare un diverso linguaggio. Ogni atto di creazione non si compie se non con una violenza. Anche il pulcino che esce dall’uovo fa, come dicono i naturalisti, una piccola rivoluzione. Ma quando n’è uscito, il suo sviluppo lento non è che un fatto continuativo, senza violenze biologiche. Non dobbiamo considerare la nostra formazione come una necessità, ma come un metodo. Dobbiamo dire che l’Italia è stata la terra degli eroi non perché valesse molto, ma perché valeva poco. Gli eroi, cioè gli audacissimi, nella debolezza e nella indifferenza del grande numero, hanno fatto ciò che tutti dovevano. Ma le loro opere non possono essere conservate e accresciute e migliorate se non con una educazione progressiva. Ogni atto di creazione è un atto di violenza, ma è una fase, traversata la quale bisogna che lo sviluppo sia lento e continuo.
Noi dobbiamo cessare di attendere in ogni occasione l’uomo provvidenziale: ci dobbiamo convincere che quest’uomo provvidenziale è in tutti, e dobbiamo considerare gli altri uomini non già come il mezzo, ma come lo scopo. L’uomo provvidenziale non esiste: e se a un uomo è dato di far più che agli altri, non bisogna nemmeno esagerare ciò che un uomo può. Quei grandi politici o finanzieri che noi invidiamo spesso agli altri, se si potessero trasportare da noi non farebbero se non ciò che i nostri fanno: infatti essi sono grandi perché imperniano movimenti che in realtà esistono. Questa contemplazione buddistica, per cui in ogni partito ci asteniamo da ogni opera attiva di bene e aspettiamo che venga l’uomo forte, l’uomo provvidenziale, è quanto di più dissolvente si possa immaginare, ed è il risultato della nostra concezione eroica della storia.
Le società umane in tanto valgono in quanto valgono non alcuni uomini, ma tutti gli uomini che le compongono. I popoli che prevalgono durevolmente sono quelli di cui la educazione intellettuale e materiale delle masse è più alta e dove la solidarietà è più grande. Dove l’anima collettiva vibra di più, dove più grande è l’unione, ivi la forza è maggiore. Pensate invece quale effetto debba avere sopra menti incolte, in cui fermentano l’odio e la superstizione, l’insegnamento che noi diamo. Noi siamo gli eredi dei meriti e delle colpe dei nostri padri, e noi già scriviamo con le opere nostre la storia dei nostri figliuoli. Facciamo che questa storia sia meno faziosa; insegnano che il lavoro umano è sacro; che la violenza comunque adoperata è male; infondiamo quel rispetto della libertà umana da cui purtroppo ci allontaniamo; evitiamo anche di ripetere, ciò che non è vero, che il passato è più grande del presente.
Da tre secoli a questa parte mai l’Italia è stata ciò che è ora: in quarant’anni di unità, di questa unità che con le sue ingiustizie è sempre il nostro più grande bene, in quarant’anni di unità, noi abbiamo realizzato progressi immensi. Noi non eravamo nulla e noi siamo molto più ricchi, molto più colti, molto migliori dei nostri padri. Siamo anche più scontenti e ciò è anche bene, poiché la rassegnazione supina è dei deboli. Spogliamoci ora anche dei pregiudizi antichi e diciamo tutta la verità: l’Italia è stata la terra degli eroi, perché valea poco. Quando tutti avranno il sentimento del loro dovere, il senso della loro responsabilità, quando sopra tutto avremo combattuto i germi morbidi della miseria e i fermenti della ignoranza, allora non avremo più bisogno di eroi: potremmo avere grandi statisti, grandi tecnici, se occorrerà grandi strateghi, non mai eroi nel senso in cui ne abbiamo avuto finora.
Ricordate l’episodio che gli storici hanno tante volte ricordato, che il romanziere potente ha divulgato. Nella notte che precedette la battaglia più decisiva della guerra franco-prussiana, l’esercito tedesco e l’esercito francese non erano a grande distanza, e nel campo francese in cui già le prime disfatte aveano gittato una profonda tristezza, si seguivano le mosse del nemico con ansia indicibile. Ora, nella veglia tragica giunse come di lontano una immensa voce. Nella notte fredda e solenne tutti i soldati tedeschi pregavano insieme e cantavano insieme il corale di Lutero.
Era un canto eguale, solenne, quasi l’affermazione della speranza comune e della vittoria immancabile. Quegli stessi soldati di Francia che si erano mostrati arditi anche nella disfatta sentirono scendere nell’anima come una nube di dolore e, più che il rombo del cannone, li atterrì quel canto; sentirono che non lottavano già contro un esercito, ma contro tutto un popolo, che avea un’anima sola.
Troveremo anche noi questa grande parola di unione? Sapremo noi abbandonare i nostri errori e i nostri pregiudizi?
(1898)
L’anno scorso, in luglio, io ero a Strasburgo, nella solenne città dei Nibelunghi, sacra pur nella leggenda al dissidio e alla guerra. E, nella gentile ospitalità della famiglia di uno scienziato tedesco, si discuteva, la sera, della Germania e dell’Italia, dello stato sociale dei due paesi e di scienza e d’arte. Per quella strana curiosità che i paesi del sole svegliano sempre nelle genti del Nord, le fanciulle sopra tutto non mi chiedevano che del Mezzodì.
“Che nome ha la terra in cui siete nato?”, mi domandò una vecchia signora che, nei suoi giovani anni (una giovinezza che cominciava già a declinare alla caduta del potere temporale dei papi), era stata nel Mezzogiorno d’Italia.
“Sono di Napoli”, risposi.
“Proprio di Napoli?”.
“No, di una terra ancora più meridionale, della Basilicata”.
La mia provincia, sopra tutto da quando ha il nome attuale, ha una storia di assai mediocre interesse per la civiltà. Mi accorsi che il nome riusciva nuovo e volli precisare.
“È una terra”, io dissi, “molto grande, grande la terza parte del Belgio, grande più del Montenegro: non ha città fiorenti, né industrie. La campagna è triste e gli abitanti sono poveri. È bagnata da due mari e l’uno e l’altro hanno costiere assai malinconiche; dintorno ha le Puglie, i Principati e le Calabrie”.
E allora fu dintorno un movimento di curiosità viva: come sono? li avete conosciuti? vestono ancora come nelle vecchie stampe? Le domande mi piovevano d’ogni parte e la figliuola gentile del mio ospite, che così bionda e bella e solenne parea Elsa, insisteva più delle altre: “Raccontate, raccontate le storie del vostro paese”.
Io rimasi come interdetto: che cosa dovevo dire? Vi era tanta ingenua e tanta simpatica curiosità, che non avevo ragione di offendermi. Protestai timidamente: dissi che i briganti sono ormai nella leggenda, come i cappelli a punta e i fucili a tromba. Credettero che io non avessi voluto dire per pregiudizio o per prudenza; e gli occhi continuarono a fissarmi con curiosità incredula. Io non prevedevo che sarei venuto, dopo meno di un anno, dinanzi a voi a parlare non dirò delle storie, ma di uno dei lati più interessanti della storia dei mio paese. E questa volta posso parlarne senza rancore, senza vergogna; poiché a voi posso dire di più, e voi potrete intender meglio. Noi ci conosciamo così poco in Italia, che di ciò che è la parte fondamentale della storia dei nostro paese abbiamo nozioni e criteri spesso contrari alla realtà.
Il brigantaggio meridionale, ancora per il maggior numero degli italiani è circondato di leggende e di misteri paurosi. Sarò molto fortunato se mi sarà dato esaminare senza prevenzioni un fenomeno che attende ancora il suo storico, e intorno a cui si sono accumulati gli errori più strani e le credenze più assurde. Ogni parte d’Italia, oserei dire ogni parte di Europa, ha avuto banditi e malviventi, che in periodi di guerra o di sventura hanno dominata la campagna e si son messi fuori della legge. Si può dire anzi che, in alcuni paesi dell’Europa centrale, il brigantaggio sia stato per secoli una vera istituzione; e i banditi della Germania, che i romantici hanno troppo spesso idealizzato, in brutalità e in ferocia hanno segnato pagine assai più sanguinose delle nostre.
I masnadieri tedeschi, che l’individualismo romantico e il favore della leggenda circondarono di simpatia, erano spesso veri malviventi; molti dei briganti meridionali, che ebbero nella loro condotta un lato cavalleresco, o per lo meno non furono rozzi delinquenti, non trovarono invece poeti o romanzieri che avessero saputo appropriarsi il lato ideale della leggenda. Né gli storici e gli statistici penetrarono spesso le cause di tanto male. Ma vi è stato un paese in Europa in cui il brigantaggio è esistito si può dire sempre e non è finito se non ai giorni nostri; un paese dove il brigantaggio per molti secoli si può rassomigliare a un immenso fiume di sangue e di odi, cui sono affluiti tutti i rivoli dei dolore, della ingiustizia, e della delinquenza; vi è stato un paese in cui per secoli una monarchia si è basata sul brigantaggio, che è diventato come un agente storico di grande importanza: questo paese è l’Italia del Mezzodì.
Ancora adesso percorrendo le terre ove più il malandrinaggio e il brigantaggio hanno celebrato i loro fasti, ci accorgiamo subito che non solo la leggenda è viva, ma che non sono morti i sentimenti che generarono il male. Per le plebi meridionali il brigante fu assai spesso i vendicatore e il benefattore: qualche volta fu la giustizia stessa. Le rivolte dei briganti, coscienti o incoscienti, nel maggior numero dei casi ebbero il carattere di vere e selvagge rivolte proletarie.
Ciò spiega quello che ad altri e a me e accaduto tante volte di constatare; il popolo delle campagne meridionali non conosce assai spesso nemmeno i nomi dei fondatori dell’unità italiana, ma ricorda con ammirazione i nomi dell’abate Cesare e di Angelo Duca e dei loro più recenti imitatori.
Non ho mai visto in mano a un contadino un libro popolare sull’unità italiana: ho visto spesso, insieme ai Reali di Francia, la rapsodia dell’abate Cesare e la bellissima istoria di Angiolillo, e tuttavia il dramma di Peppe Mastrilli appassiona ed esalta le menti. Ancora adesso, nelle lunghe sere d’inverno, nelle notti vegliate, nelle soste del lavoro, trasformate e ingigantite dalla leggenda si ripetono con compiacenza le storie dei briganti. É tutto questo un male? lo non vorrei dire e non saprei. Le cause che hanno prodotto per tanti secoli il brigantaggio non sono ancora del tutto rimosse e il male è che esistano, non che esistendo operino e, scomparso il brigantaggio, producano effetti di altra natura, ma sempre egualmente dolorosi.
Si può dire che, durante tutto il vicereame spagnuolo e il regno dei Borboni, il brigantaggio sia stato una della parti più interessanti, se non la più interessante della storia meridionale. Era il più delle volte un vero malandrinaggio: contadini affamati, o perseguitati dalla così detta giustizia baronale, si riunivano in bande, sceglievano un capo più intelligente o più feroce, e si davano, come si diceva allora, alla campagna: per rubare e per uccidere. Se i capi erano il più delle volte persone nate a delinquere, i gregari, gli oscuri erano sofferenti, che avean torti da vendicare, o contadini ridotti a una vita quasi bestiale, e che desideravano, per qualche anno almeno, saziare la fame e vendicare le offese.
E tutto incitava al brigantaggio. Ancora adesso in Basilicata o in Calabria, in Abruzzo o nel Cilento, percorrendo la campagna tristissima, ove alcune croci sorgono a ricordare ai passanti antichi misfatti, la natura dei luoghi ci spiega in gran parte ciò che è accaduto. I paesi sono messi in alto sui monti al riparo dalla malaria e dai malviventi. I torrenti non arginati, le boscaglie nane e piene di sterpi, la mancanza quasi assoluta di case non possono essere che condizioni predisponenti al male. Se pensate a ciò che è stata la feudalità nell’Italia meridionale, come vi si sia radicata per secoli, e come, mutate le forme, in qualche provincia duri tuttavia, vi spiegherete lo svolgersi e l’espandersi del brigantaggio. Ma nulla vi contribuì di più della immoralità profonda della dominazione spagnuola, durata per sì lungo volgere di tempo.
I baroni prepotenti erano attorniati da tal gente ed esercitavano giustizia in tal modo, che dovevano eccitare alla rivolta anche gli spiriti più miti. Essere inquisito, cioè aver commesso dei reati, essere ciò che noi diremmo un criminale, era un requisito quasi indispensabile per essere ammesso al servizio di un barone. Mancava ogni fede pubblica e privata; le università che con grandi sforzi riescivano a riscattarsi erano rivendute dagli stessi sovrani che davano l’esempio della disonestà. In alcuni casi e non rari i baroni stessi partecipavano al brigantaggio e lo proteggevano, sia per misura di difesa, sia per desiderio di guadagno. Or le classi povere, che non avevano nessuna fede nella giustizia, che in alcuni luoghi doveano sostenere una lotta impari contro la perfidia della natura da una parte e i cattivi ordinamenti sociali dall’altra, non doveano né poteano avere verso i banditi, cioè verso coloro che si mettevano in lotta aperta con la società, alcun sentimento di avversione.
Come accade in tutti i periodi di violenza, in tutti i periodi di disordine, gli elementi peggiori prevalevano e dominavano; in una società in cui la violenza e la ferocia eran mezzi di lotta, le nature più perverse s’imponevano. Così in epoca più vicina a noi Fra Diavolo e Mammone, Parafante e Taccone, mostri di crudeltà prevalgono sugli altri; ma non tutti coloro che li seguivano erano crudeli e feroci allo stesso grado, né tutti erano usciti dal consorzio civile per causa di misfatti e di violenze. Quando un contadino vedeva un suo pari mettersi contro le leggi e quindi non soffrire più la fame e salire qualche volta in potenza e trattare coi grandi della terra e averne onori, dovea ben sentire qualche invidia. Che importa il pericolo? Il pericolo ha anch’esso le sue attrattive, e un anno di vita vissuta bene, vale agli occhi delle nature più impazienti e più vive assai più di una lunga vita vissuta male.
Durante la dominazione spagnuola, nel 1559, è stato possibile a un bandito famoso, a Re Marcone, andare realmente a prender possesso della città di Crotone e battere le truppe regolari.
Alla fine del secolo decimosesto Benedetto Mangone, Marco Sciarra e Battinello erano i veri arbitri di alcune province. E non poche volte si videro i briganti spingersi in gran numero fin sotto le mura di Napoli, bloccare la capitale e mettere in pericolo la sicurezza del governo. Anche prima i banditi erano stati molte volte una forza politica di cui i sovrani si erano serviti contro i baroni e i baroni contro i sovrani. Ma, durante la dominazione spagnuola, cioè per più di due secoli, non vi è stata guerra combattuta con le forze interne del Regno, in cui una delle parti nemiche non abbia adoperato i banditi. Province intere, per secoli, furono al di fuori di ogni legge, sotto la dominazione diretta o indiretta dei banditi, sotto la persecuzione di un ordine feudale, che era tanto più esigente in quanto i baroni solevano vivere in città.
Il brigantaggio era una gran forza da usare negli estremi perigli; i Borboni che con Carlo III aveano cercato fiaccarlo se ne valsero più tardi per riconquistare il reame e per tenere a freno, per sessant’anni, le classi ricche e colte. La storia dei Borboni, dopo Carlo III, è anzi strettamente legata a quella del brigantaggio. Furono i briganti che a Ferdinando IV riconquistarono il reame nel 1799; furono essi che tentarono, durante la dominazione francese, di riconquistarlo una seconda volta e che più tardi furono adoperati, e non in una sola occasione, contro la borghesia aspirante a riforme politiche, o malcontenta. Per la prima volta forse nel mondo civile, passando sopra ogni legge morale, i Borboni osarono scegliere come cooperatori i banditi più infami: alcune belve crudelissime ebbero grado di colonnello o di generale, titolo di marchese o di duca e laute pensioni, come se fossero vecchi e gloriosi generali; ebbero l’amicizia del sovrano e attestati di pubblica stima. È una non interrotta serie di fatti di tale natura, che va dai mostri della reazione del 1799 a Giosafat Talarico e ancora più tardi ai tentativi di reazione posteriori al 1860.
Io non credo che la lotta di classe sia base della vita sociale dei popoli; non credo che sia metodo di trasformazione; non credo che dal bandire e dal propagare questa lotta potrà uscire la pace. Ma se un governo si è mai basato sul dissidio delle classi, è stato il governo dei Borboni di Napoli. L’aristocrazia e la borghesia liberale, entrambe scontente, hanno avuto per un secolo sospesa sul capo la minaccia di rivolte proletarie a servizio della monarchia. Né fu tutta colpa loro, ma delle circostanze storiche; poiché non bisogna mai dimenticare che i Borboni vennero a Napoli animati da spirito di riforme e che essi e i loro ministri, per sessanta anni almeno, non fecero che inimicarsi l’aristocrazia e il clero, poiché ne limitarono la potenza. La rivoluzione del 1799 appare appunto composta degli elementi più vari: ed erano in essa numerosi ecclesiastici e moltissimi nobili, che alla monarchia centralizzata preferivano qualsiasi altro regime. In Italia la feudalità non ha avuto forse mai salde radici; solo a Napoli e in Sicilia è stata potente, e le sue tradizioni sono tuttora vive. Trapiantata dai Normanni in tutto il suo vigore, ha trovato, per espandersi e per durare, tutte le condizioni favorevoli. La tenue densità della popolazione, una larga superficie malarica che impediva e impedisce la popolazione sparsa e l’accumula solo in alcuni luoghi, il debole sviluppo degli scambi determinavano l’esistenza e la potenza della feudalità.
D’altra parte faceva riscontro una borghesia, nata non già dal traffico e dalla industria, ma da tre funzioni che la rendevano ugualmente odiosa al popolo: l’intermediarismo agrario, il piccolo commercio del danaro, le professioni liberali e sopra tutto l’avvocatura. L’intermediario della terra non era un coltivatore, ma aveva il più delle volte una funzione puramente parassitaria; agente del barone o del signore, che viveva in città, cercava di arricchire sui fitti brevi e più aveva bisogno di vivere (non dirò di arricchire) più incrudiva sui coltivatori. Il piccolo commercio del danaro, che dava all’usura agricola forme forse non più viste altrove, dura tuttavia ed è stato origine assai frequente di arricchimenti. Infine l’avvocatura, sempre disposta a dimostrare le ragioni del più forte, sempre difenditrice delle usurpazioni delle terre popolari, abilissima nei sotterfugi, toglieva alla classe intermedia, ogni fiducia. Il Colletta chiamò l’avvocatura peste del reame di Napoli; e lo storico illustre delle finanze napoletane, Ludovico Bianchini, riconosce che per secoli essa in ogni occasione si mostrò sempre pronta a sostenere la cattiva disciplina di governo.
Rappresentava e rappresenta forse tuttavia la parte più attiva, più intraprendente, più audace: ma era ed è senza dubbio causa di dissoluzione e di corruzione, rendendo più difficili i rapporti sociali e corrompendo in ogni guisa tutte le magistrature. Il parlamentarismo anzi, piuttosto che mitigare il male l’ha esacerbato, annullando ogni dignità della magistratura e creando il tipo infame dell’avvocato politico, che in passato non esisteva e non poteva esistere. Uno degli studi più interessanti sarebbe quello della distribuzione territoriale del brigantaggio. Senza dubbio le condizioni geografiche agivano sopra tutto; ma dopo di esse in prima linea le condizioni economiche. Le province che hanno più sofferto il brigantaggio sono state la Basilicata e il Principato Citra, nella parte sua più povera; vengono dopo alcune zone dell’Abruzzo e della Calabria, nella parte ove il concentramento della proprietà era maggiore. Ma dovunque le ragioni sono identiche.
Le cause predisponenti del brigantaggio erano numerose: alcune sono scomparse, qualcuna ancora permane. La prima, la vera, la grande causa era la miseria. Alla vigilia della rivoluzione francese, nel 1786, il reame di Napoli aveva appena 4.800.000 abitanti. Ora il reddito del reame, in una epoca in cui le industrie erano scarse e pochi i commerci, era tenue: era un reddito quasi esclusivamente agrario, quale potea venire da un paese a cultura estensiva e in gran parte pastorale. L’intero reddito dei feudi era calcolato a oltre 4 milioni di ducati, esenti da tributi, e i feudatari aveano innumerevoli diritti, l’uno più gravoso dell’altro per i cittadini. Di oltre 2000 comuni appena 384 erano demaniali, cioè dipendevano direttamente dal Re. Il numero dei famigli e dei dipendenti dei baroni, che applicavano i diritti feudali senza scrupoli, era eccessivo, eccessivo più ancora il numero delle pretese. Circa 10 milioni di ducati prendevano sotto ogni titolo gli ecclesiastici, e il loro numero sommava a oltre centomila, cioè vi era un ecclesiastico per meno di ogni 50 abitanti. Popolazione enorme e improduttiva, non forse però più enorme di quello che sarà fra breve il numero dei professionisti usciti dalle università, dei diplomati delle scuole secondarie, spostati desiderosi di impieghi e quindi bisognosi di mutazioni.
Quale poteva essere la vita del popolo? Una vita grama e stentata; una vita di miserie e più ancora di depressione morale. In alcuni feudi i baroni erano implacabili nel pretendere che il molino fosse un loro monopolio; e il pane si cuoceva sotto la cenere ed era negato ai contadini ciò che hanno anche le popolazioni più misere e meno progredite.
“Il brigantaggio – conchiudeva tristemente l’on. Massari – diventa in tal guisa la protesta selvaggia e brutale della miseria contro antiche e secolari ingiustizie”. Le genti dell’Italia meridionale, risultato delle mistioni di razze sì varie, hanno forse da tanti incroci, forse più ancora dalla rapidità loro nell’ideare, una vaga tendenza alla vita di avventure. Vi è, sopra tutto nelle genti di Basilicata e di Calabria, un senso di misticismo inconscio, che invade l’anima popolare. Non è il misticismo gentile e delicato che penetrò l’anima di Francesco d’Assisi, ma un misticismo rozzo e quasi selvaggio, com’è quello che dove albergare nell’anima di Gioacchino da Fiore, il calabrese abate Gioacchino, che esercitò appunto il suo rude apostolato nei monti di Basilicata e di Calabria.
In quelle aspre regioni ogni paese, ogni zona, ha il santuario lontano, in cima ai monti; chiese perdute tra i boschi, e costruite su antiche caverne, abitate da pellegrino o da santi. Si va ai santuari, dopo aver digiunato, pregando per via, qualche volta con i fiori in cima alle canne, gli umili fiori dei campi e dei boschi: molto spesso si va a piedi nudi, salmodiando e orando. Lunghi cortei di uomini e di donne salgono le erte faticose fino ai luoghi da cui si spazia l’orizzonte lontano. Nei lunghi pellegrinaggi il misticismo si trasforma; diventa qualche volta desiderio di avventure. Il pellegrino è ora più che non si pensi il precursore dell’emigrante; in altri tempi era il precursore del brigante. Nulla di più naturale che, nelle lunghe notti vegliate, nelle lunghe vigilie, nell’incontrarsi con genti nuove, sorga un bisogno di andar lontano e di espandersi. La terra maligna, che dà la febbre e uccide, discaccia. La razza sabellica ama l’intrapresa e l’ignoto; la Basilicata, che non ha la quarta parte della popolazione di Toscana, manda fuori di Europa assai più del doppio di emigranti all’anno. Senza dubbio la causa più profonda e più generale è la miseria; ma io non oserei dire che non vi sia in molti casi un bisogno di tentare e di cercare.
Ricordo, come se fosse ora, un vecchio contadino del mio paese, tutto bianco, ma diritto tuttavia come un abete delle montagne. Andava al Brasile: non possedeva che cinque lire e il biglietto d’imbarco; non sapeva leggere, non avea nessuna nozione dei paesi dove si recava.
Sapeva solo che altri della sua terra vi era stato. Gli chiesi da qual parte fosse il Brasile; mi rispose solo che era lontano, assai lontano che non si potea misurare quanta fosse la lontananza. E mi accennò con la mano in aria, come per indicare qualche cosa di strano e di indeterminabile.
Quando gli domandai che cosa avrebbe fatto: E chi lo sa? mi rispose con la profonda filosofia meridionale, così piena di fatalismo e di tristezza; e non volle dire niente più. Avrebbe lavorato, avrebbe goduta quella che gli pareva la grande ricchezza, cioè mangiare fino alla sazietà, come a Natale, come a Pasqua; sarebbe morto forse. Le anime inquiete non potendo far meglio ora emigrano; allora l’unica professione possibile per chi non volea rassegnarsi a una vita bestiale era il brigantaggio.
Così si spiega che tra i briganti noi troviamo alcune figure di veri idealisti, alcune anime pur nella loro rozzezza, e qualche volta nella loro crudeltà, desiderose di giustizia e amorose del bene.
Ciò che qualche volta sorprende nell’Italia meridionale è vedere nei contadini più rozzi alcune finezze di sentimento e qualche volta anche fisicamente alcune figure le quali fanno pensare a razze nobili decadute. In un paese, che è stato teatro di tutte le guerre, in un paese che è stato per molti secoli la porta del Levante e in cui è stata contesa la signoria del mare, mutamenti frequentissimi hanno assai volte cambiata la condizione degli individui: sì che le nobili stirpi sono precipitate più in basso. Non è raro vedere nei tratti di un contadino qualche cosa che rivela una antica grandezza, o l’abitudine di una vita non servile e non povera. I patologi dicono che la malaria sia causa predisponente dell’isterismo e delle malattie nervose: certo traversando le zone malariche (sopra tutto dove la malaria è meno grave e non prostra addirittura gli individui) si notano subito le tendenze fantastiche degli abitanti, la loro tendenza verso l’ignoto, il bisogno della vita di avventura. Adesso si emigra; quando l’emigrazione non v’era, il desiderio dell’ignoto produceva conseguenze ben diverse.
Altra causa che agevolava grandemente il brigantaggio era la mancanza di strade. La popolazione, agglomerata in alcune province, quasi non aveva strade. Per molte miglia si percorreva una campagna in cui non eran che sentieri mal sicuri e i trasporti per necessità eran lenti e difficili.
La Basilicata, centro principale del brigantaggio, ai tempi di Carlo III non aveva quasi alcuna strada rotabile. La strada delle Calabrie giungeva fino a Persano; nel 1792 era estesa fino a Lagonegro e solo nel 1795 giungeva a Muro e nel 1797 ad Atella. Ancora nel 1863, quando fu fatta l’inchiesta parlamentare sul brigantaggio, sui 124 Comuni del Basilicata, 91 erano senza strade; sui 108 della provincia di Catanzaro 92; sui 75 della provincia di Teramo 60. Dei 1848 Comuni del Napoletano, 1321 mancavano di strade. Or tutto ciò era necessariamente a profitto del brigantaggio; internandosi nelle boscaglie, facendo periodiche comparse al piano, i banditi resistevano facilmente alle persecuzioni più audaci. Alcuni dei banditi facevan fortuna, e qualche volta ottenevan la grazia e si ritiravano a vivere tranquillamente; ma nel grandissimo numero perivano uccisi o traditi, o erano imprigionati.
Qualche volta i signori del paese, per timidità, o per desiderio di guadagno, proteggevano i briganti; il più delle volte davano nelle loro masserie, nelle case di campagna asilo e rifugio. Ai tempi di Carlo III anche i conventi erano asilo sicuro; e Carlo dovè molti abolirne per questa ragione, che eran covo di malviventi. Nei piccoli paesi le lotte eran frequenti, eran frequenti le lotte tra un paese e l’altro; dove i comuni eran più divisi e quindi più aspre e più inique le persecuzioni della parte perditrice, maggiori eran le cause che determinavano gli individui meno tolleranti a darsi alla campagna, come si diceva allora. La vendetta era una necessità e un dovere, e le vendette era lunghe e terribili.
Oh! la tristezza di una borgata meridionale, perduta nelle gole di Basilicata o nelle asperità della Sila, una borgata senza luce di pensiero, senza blandizie dell’arte, senza la suprema poesia della lotta in comune.
Anche nell’Italia centrale le lotte erano terribili nei piccoli centri come nei grandi: e quei che un muro ed una fossa serra, si tormentavano e si dilaniavano fra loro quando non dovean lottare contro i vicini. Ma la relativa prosperità e la mitezza del clima e la salubrità dei campi davano alla lotta un carattere più umano; permettevano lo sviluppo delle forme libere dei comuni; determinavano il bisogno dell’arte, davano carattere di epica grandezza anche alle lotte delle fazioni delle stesse città.
Ma la vita in un piccolo centro campestre dell’Italia meridionale, nell’interno della Basilicata o delle Calabrie! ma la vita in un casolare dell’Appennino! ma la vita in un grosso borgo pugliese! La malaria da una parte e i cattivi ordinamenti dall’altra inducevano gli abitanti a vivere uniti; in una unione necessaria e forse per questo più ingrata. Le case si aggruppavano miseramente fra loro, e non v’erano, d’ordinario, che il castello del barone, la chiesa e il convento che avessero un’aria meno misera. Impedite quasi le comunicazioni, o limitate ai paesi vicini, la vita trascorreva sempre allo stesso modo; quando non era turbata da cataclismi violenti, come le guerre. Assoluto il potere del feudatario e peggiore di esso quello di coloro che lo rappresentavano; non era possibile al popolo nessuna salute fuori della rivolta individuale. La religione, quando non era una superstizione, aveva il carattere dei luoghi: una religione dura e paurosa, quasi crudele, mitigata solo dall’intervento del protettore, un santo, per lo più patrono di un male grave e pronto più a punire che ad amare, più a vendicare che a perdonare.
La violenza sessuale delle genti del Sud faceva il resto, e contribuiva non poco a inasprire i rapporti. Si può dire che fra dieci persone che si davano al brigantaggio tre o quattro almeno ricorrevano a un così estremo passo solo per vendicare la violenza patita da una moglie, da una figliuola o da una sorella. Per spiegarci alcune cose bisogna intendere quale violenza abbia l’istinto carnale nelle genti del Sud. Per i contadini specialmente è spesso l’unica forma in cui riescano a concepire l’ideale e ad avere una ebrietà dello spirito. Così come il desiderio è violento, l’istinto della proprietà è completo. La donna infedele – sopra tutto se cede a una violenza – altrove non è causa di disprezzo per il marito o per il padre. Fra i contadini del Mezzogiorno vi è invece una parola che riunisce tutti gli insulti, una parola che è pronunciata spessissimo, e che nella crudeltà sua è peggiore della morte, ed è il nome che è dato al marito ingannato o vittima. Che un uomo sia ladro, omicida o perverso e che tutte queste cose gli siano rimproverate egli soffrirà sempre meno che sentendosi insultare per colpa o per sventura della moglie.
Ho letto molte storie di briganti, ne ho sentite raccontare moltissime; ho vissuto nei luoghi dove più vivi sono i ricordi; dovunque ho visto le stesse cause agire allo stesso modo. Nei piccoli centri il potere del feudatario o del borghese, del funzionario o dei padrone era usato non di rado per attirare le donne dei contadini; quando non cedevano volontariamente erano persecuzioni lunghissime ai mariti, ai fratelli, ai padri. Era il disonore sotto altra forma; era la miseria; era la sopraffazione quotidiana. Come resistere in una lotta così impari? Le nature deboli si avvilivano e tolleravano; ma gli uomini risoluti si davano alla campagna, si facevano briganti; si ribellavano insomma nella sola forma che era loro possibile. La suprema gioia di uccidere dopo aver sofferto l’oltraggio supremo; la suprema gioia di vendicare e di vendicarsi dopo aver tanto penato tentavano anche le nature meno cattive. La religione aveva indulgenze per i forti; e ne aveano più ancora i funzionari dello Stato.
Il brigantaggio diventava un mezzo di salvezza e un mezzo di riabilitazione. Al marito oltraggiato, all’uomo perseguitato rendeva quasi sempre la stima del pubblico, qualche volta la tranquillità dello spirito, la gioia di vivere. Le persone out laws hanno avuta sempre una certa attrazione: maggiore essa dovea essere in una società in cui le leggi erano pessime. Il contadino che, dopo aver sofferto tutte le persecuzioni, si dava alla campagna, prendeva qualche volta la sua rivincita nel modo più assoluto: la donna che lo aveva rifiutato si dava spesso a lui per paura, o per amore, poiché sulle anime rozze la vita del brigante esercitava una attrazione: coloro che lo avevano perseguitato o cercavano scampo nella fuga, o si umiliavano venendo a patti; e quasi sempre vedeva il suo prestigio rialzarsi. Poteva essere odiato, non mai disprezzato, e in questa differenza è la causa non ultima del fascino che la campagna immensa esercitava sulle anime insofferenti.
Quasi tutto questo non fosse bastato, incitava al brigantaggio, come si è detto, l’opera dei governi. Nei periodi in cui ne avevano bisogno per sedare interne lotte, i governi ricorrevano ai briganti. E si videro i maggiori fra questi diventare ricchi e potenti, occupare alti gradi e imporsi agli uomini onesti; si videro mostri di crudeltà, come Mammone e Fra Diavolo premiati dal re e trattati come amici. Il vicereame spagnuolo aveva fatto lo stesso; ma nessuno aveva mai osato ciò che fece Ferdinando IV e ciò che fecero i suoi discendenti.
Nell’Italia meridionale esisteva ed esiste tuttavia un vero proletariato agricolo; vi sono in ogni provincia molte migliaia di persone che non posseggono che la loro forza di lavoro. I cafoni di Basilicata e di Calabria; i terrazzani di Capitanata sono le forme tipiche di classi la cui memoria e la cui incertezza del vivere spesso ha un livello che non potrebbe essere più basso. Non avendo altra industria che la terra, queste masse, che per giunta hanno assistito per un secolo alla usurpazione delle terre pubbliche, che vi assistono tuttavia, non amano le classi medie. Non amavano nemmeno l’aristocrazia; ma essa aveva almeno il prestigio del nome e della tradizione. Quando venne l’onorevole Castagnola insieme alla Commissione d’inchiesta sul brigantaggio giù nell’Italia meridionale, fu vivamente sorpreso di quest’odio che esisteva tra possidenti e salariati, fra galantuomini e cafoni, come si dice da noi, all’indomani stesso della rivoluzione liberale del 1860.
Prima del 1860 quasi nessun contadino sapea leggere; un certo numero di possidenti delle campagne ignorava persino le prime e più elementari nozioni. Superstiziosissime; per razza e per natura avventurose, abituate per secoli a vedere il più forte opprimere il più debole, le masse consideravano il brigante come il vindice dei torti che la società loro infliggeva. Ora i Borboni di Napoli, la cui colpa suprema fu non già la crudeltà, come si ripete a torto, ma la paura, che nei regnanti è madre della crudeltà, ed è peggiore di essa, non concepivano nemmeno che il popolo potesse essere altra cosa fuori di quello che era. Molti provvedimenti vollero per migliorarne le condizioni, nessuno per educarlo. Sentivano che la loro fortuna era appunto nel disporre di una forza cieca da scatenare contro le classi medie, tutte le volte che esse si mostravano desiderose di ordinamenti nuovi.
Non solamente durante il 1799, ma durante la monarchia francese, ma nel 1820, ma nel 1848, ma nel 1860, i Borboni ebbero il brigantaggio come suprema difesa. Il brigantaggio era il modo di sfogare tutte le vendette. Era un’onda cui non si resisteva; secondata dai preti, fatta servire alle passioni locali, inasprita da tutte le sofferenze, quest’onda irrompeva terribile e devastatrice. Passato il pericolo, restaurate le sue basi, la monarchia premiava i più fortunati, i capi delle insurrezioni, e sterminava gli altri: tranne a ricominciare ove ne fosse il bisogno.
Così nella storia del brigantaggio, noi troviamo due forme distinte: i briganti comuni erano o delinquenti desiderosi di far fortuna e di sfogare i loro istinti, o poverissimi uomini spinti dalla fame e dalle ingiustizie a mettersi contro la società. Oltre di questo vi è stato un vero brigantaggio politico che, riunendo gli elementi che già v’erano, e rivolgendosi alle masse e svegliando istinti rivoluzionari, è stato sostegno della monarchia e da essa a volta a volta creato e distrutto. Quando si parla di briganti si pensa subito a tutte le leggende che noi abbiamo sentito ripetere: si pensa al trombone, al cappello a punta, ai delitti terribili e alle grassazioni più spaventevoli.
Il brigante invece non era che un rivoltato: e fra i rivoltati vi erano, come vi sono oggi, i sofferenti, gli idealisti e i perversi. Bakunin ha detto che il brigante meridionale rappresenta il tipo del perfetto anarchico. Sa essere anarchico vuol dire soltanto mettersi contro la società, apertamente, violentemente, i briganti erano anarchici. Quando si pensi alle descrizioni terribili che abbiamo letto o udito, pare strano che anche i più feroci di essi erano religiosissimi. I ladroni che seguivano il cardinal Ruffo, prima di mettere a sacco e a fuoco le città, di commettere ogni terribile strage, ascoltavano la messa. La vita di avventure va sempre unita a un fondo di misticismo: ciascun brigante portava sul petto le sacre immagini, faceva doni alle chiese e non mancava di recitare il rosario. Era una religione rozza e primitiva credente in un Dio terribile, che qualche volta i banditi invocavano perché le loro operazioni riescissero. Così tra i briganti troviamo i tipi più diversi, come le nature più varie; accanto ai ladri e agli assassini, che costituivano il fondo del malandrinaggio, uomini desiderosi di più umano vivere e qualche volta perfino amanti di giustizia.
Una giustizia rozza, quale poteva apparire alla mente di uomini incolti e superstiziosi.
Il tipo più singolare, più interessante, direi quasi più leggendario del brigantaggio meridionale è stato Angiolo Duca, conosciuto dal popolo sotto il nome di Angiolillo. Ancora qualche anno fa la storia si cantava sul modo di Napoli e interessava e commoveva non meno di quella di Rinaldo di Montalbano. Ciccio Zuccarino, che vende e tradisce Angiolillo, apparisce più esecrabile di Gano di Maganza, il Maganzenese, orrore del popolo napoletano. I briganti che la letteratura tedesca ha vagheggiato e Karl Moor dei Räuber di Schiller trovano il loro riflesso in Angelo Duca, che fu filantropo anche nelle sue avventure brigantesche. Contadino della terra di San Gregorio, Angelo Duca divenne bandito per sfuggire all’ira di un barone, che volea vendicare un servo, cui Angelo in rissa avea ucciso un cavallo. Vagò da prima con altri banditi; poi formò una banda propria. Non ebbe mai grandissimo numero di compagni, come già altri famosi prima di lui, e quasi tutti erano delle terre di Basilicata e di Salerno. Angelo un po’ per abilità in quel tempo, fu per parecchi mesi padrone di una larga zona e operò con buon successo non solo nel nord di Basilicata, che fu il teatro delle sue gesta, ma nelle province di Avellino e di Salerno e si spinse in Capitanata.
Non uccideva se non coloro che lo perseguitavano: non assaliva mai i viandanti, né ricorreva mai ai soliti espedienti di rubare di notte. Preferiva chiedere apertamente ciò che gli era necessario: e tutti davano per timore o per calcolo. Quando fermava sulle vie maestre i ricchi viandanti divideva amabilmente da uomo educato. E il danaro che prendeva, solo in parte dava ai compagni suoi: il resto lo distribuiva ai poveri, impiegava a scopi di bene, sopra tutto a dotare le zitelle. Ogni brigante che volea durare a lungo doveva essere o mostrarsi filantropo: ma Angiolillo era sinceramente pietoso. Un secolo prima di Angelo Duca anche il terribile abate Cesare usava fare opere di pietà e dotava le fanciulle povere; e Peppe Mastrillo – il brigante più leggendario – secondo un suo biografo consigliava ai compagni di far la carità ai poveri e di difendere l’onore delle zitelle. Ma nessuno dei briganti né prima né dopo ha avuto la filantropia larga e disinteressata di Angelo Duca.
Quando entrava in un paese, e ciò gli accadeva di frequente, andava subito dai più ricchi, si faceva dare il danaro che possedevano e lo distribuiva ai poveri. Così fece a Calitri dove il più ricco era il parroco. Non amava che i ricchi godessero e i poveri soffrissero. Ad Ascoli in casa di un ricco signore si faceva festa: egli vi andò, ma volle che una parte dei cibi e molto danaro fossero distribuiti ai contadini.
Con dir se festa fa la signoria Anche alla povertà festa si dia.
Questi versi sono dei suoi biografi, che ne hanno raccontato in ottava rima le gesta; come in versi (o strazio della rima!) è la bellissima storia che si contava sino a pochi anni fa. Non amava gli usurai e con essi era qualche volta crudele. Una volta incontrò un pover uomo che era menato in prigione, perché non aveva pagato l’usuraio. La moglie l’accompagnava piangendo e singhiozzando. Angiolillo liberò l’arrestato, si recò subito al paese dall’usuraio, entrò nella casa di questi e lo atterrì dicendogli che l’usuraio è peggiore del brigante. Il poeta gli mette in bocca le seguenti parole: Il ladro ruba ed ha grande timore …
Ma l’usuraio ruba francamente E rende afflitta e misera la gente.
È inutile aggiungere che si fece dare dall’usuraio tutti i danari, tutti i registri e tutte le obbligazioni. Distribuì i primi ai poveri e bruciò il resto. Sopra tutto non amava l’economia politica, poiché fissava i prezzi a piacere. In un anno in cui in Puglia era grande carestia di grano, Angelo seppe che un barone aveva fatto grande incetta di frumento e avea venduto sulla piazza di Genova 12 mila tomoli di grano a 37 carlini il tomolo. Angiolillo non esitò un momento solo: andò dal barone e con bel garbo si fece dare le chiavi dei depositi, dicendo che voleva egli stesso occuparsi della vendita. Poi, secondo il poeta, fece dare il bando…
…a chi necessita lo grano, Angelo vende a quindici carlini cioè ad assai meno della metà. Il grano fu venduto in pochi giorni, e, cosa abbastanza singolare, Angelo restituì fedelmente il ricavato della vendita al barone. Non amava confondersi con i delinquenti comuni, e quando poteva arrestare i peggiori di essi lo faceva assai volentieri, e si occupava perfino di consegnarli ai giudici. Religiosissimo e accolto a braccia aperte, come un amico, dai frati in tutti i conventi della regione, avea una strana propensione a svaligiare i vescovi e i ricchi prelati, anzi si può dire che la sua opera fu principalmente diretta contro di essi. Ma nemmeno in tali casi amava essere scortese. Un vescovo avea 1000 zecchini; gliene prese 500, dicendogli con profondo rispetto: “Cinquecento vi bastano per il vostro viaggio”. Un’altra volta incontrò un abate benedettino, che ne avea 2500: gliene prese metà e di questa fece due parti: una per sé e per i suoi compagni; dell’altra si servì, al solito, per dotar zitelle.
Questo desiderio di proteggere l’onore delle fanciulle non può essere compreso da chi non abbia un concetto della prepotenza baronale e più ancora di quella della ricca borghesia, che abusava delle fanciulle nel modo più indegno che si possa immaginare. Angiolillo insegnava la morale non solo ai signori, ma anche ai preti e ai vescovi. Gli accadde che, andando pei boschi, s’incontrò in un prete che bestemmiava come un turco. Erano strani tempi, cui i preti bestemmiavano e i briganti insegnavano la morale.
Voi facendo sì trista funzione, Padre mi fate ancor scandalizzare gli disse Angiolillo: poi un po’ col tu, un po’ col voi, com’è abitudine dei meridionali, aggiunse: Quietatevi, ti prego in cortesia, e dimmi ancora la ragion qual sia.
Il prete raccontò tutto. Vacava una buona parrocchia: e il vescovo simoniaco l’avea destinata non a lui che ne avea diritto ma a un prete ricco e immeritevole, che avea pagato una grossa somma. Angiolillo andò subito dal vescovo, gli s’inchinò, gli baciò la mano e Dopo questo si misero a parlare Sul punto del dovere e dell’onore.
Il vescovo non seppe negar nulla a tanto intercessore, e la parrocchia fu data a chi ne avea diritto. La giustizia non era completa: Angiolillo si recò dal prete corruttore e si fece dare 950 ducati, in punizione di aver cercato di corrompere un vescovo, e, come al solito Tutto il contante che il prete ha portato Il fuoruscito ai poveri ha donato.
Circondato dalla simpatia delle masse Angelo Duca avea tale potenza, che entrava da trionfatore in città di sei o settemila abitanti. Il popolo lo considerava come un eroe e lo credeva invulnerabile. Perseguitato aspramente e tradito da un compagno, fu arrestato nel monastero di Muro Lucano e nel 1784 impiccato in Salerno, per semplice ordine del re, senza nemmeno la parvenza di un processo. Fu forse l’ultima condanna pronunziata a Napoli per biglietto, senza nessuna procedura; e il fatto parve mostruoso anche alla Curia, che di questo scandalo parlò a lungo. Né prima, né dopo di lui vi fu alcuno che, anche lontanamente, si potesse paragonare ad Angelo Duca. Vi furono tra i banditi molte anime desiderose di giustizia, o almeno di vivere più umano; vi furono individui che in non poche occasioni diedero prova di spirito di sacrificio e di devozione. Ma erano nature rozze, e la loro primitiva morale non permetteva mai di elevarsi fuori dell’ambiente di miserie e di odi in cui vivevano.
Ma il vero brigantaggio politico non comincia che nel 1799. Fuggiti in quell’anno i sovrani in Sicilia e proclamata la repubblica, questa non avea né potea avere salde radici nel popolo. Messa su dai francesi, raccoglieva intorno a sé gli spiriti più eletti e insieme gran numero di scontenti dell’aristocrazia del reame. Nondimeno si sorreggeva, e, nonostante Nelson, la lotta da parte della squadra britannica sarebbe durata se un uomo audace e intraprendente non avesse concepito il pensiero arditissimo di conquistare il regno al Sovrano, eccitando le passioni popolari e scatenando il brigantaggio.
Il cardinale Fabrizio Ruffo, il cui nome è rimasto tristemente famoso, ma che fu migliore della sua riputazione e sopra tutto fu più onesto dei suoi sovrani, concepì l’idea audace di riconquistare il reame, mettendo in rivolta le classi proletarie. Principe della Chiesa e feudatario, pieno di debiti e di audacia, senza scrupoli e pure non perverso, egli avea un piano assai semplice e ardito. Partendo dalla punta estrema della Calabria e descrivendo un grande arco di cerchio traverso la Basilicata, le Puglie e i Principati si proponeva di giungere a Napoli, dopo aver percorso le zone principali del brigantaggio. Riunendo dintorno a sé i banditi – come si diceva allora che la parola brigante non era ancora penetrata – riunendo i miserabili e gli scontenti, sapeva di arrivare a Napoli seguito da turba infinita e feroce, e contava di poter facilmente distruggere la mal difesa repubblica.
In una lettera da Monteleone al ministro Acton, il Cardinale spiega chiaramente i mezzi di cui volea valersi; contava sopra tutto di andare avanti “nutrendo sempre la gelosia fra il popolo e il ceto medio”. Le classi colte erano desiderose di nuovi ordinamenti; bastava atterrirle svegliando l’odio popolare contro i possidenti. “Spero – scriveva in un’altra lettera, partecipante la presa di Cosenza – che il popolo basso abbia saccheggiato insieme con gli aggressori, e così mantenga a freno i nobili e i paglietti”, cioè l’aristocrazia scontenta e la borghesia.
Il Cardinale era seguito da malfattori venuti d’ogni parte e da banditi famosi, cui si prometteva ogni sorta di premio e da turbe desiderose di saccheggio, le quali assai facilmente propendevano a dichiarar giacobino chiunque possedesse. A Napoli il sinistro canto dei sanfedisti diceva: Chi tene grane e vine ha da esse giacubbine.
Chi possiede è giacobino. Nelle province si pensava presso a poco allo stesso modo.
Quando il Cardinale giunse a Napoli, seguito dalle sue turbe brigantesche, dopo aver traversato sì larga parte del reame, scrisse sinceramente, in una sua lettera, che si era accorto che il popolo trasformava ogni possidente in giacobino: “è la rapina – egli scriveva – che produce i proprietari giacobini”. Il piano di Ruffo era il solo che potesse riescire e riescì; dire ai contadini: rubate le case dei ricchi, saccheggiate, dividete le terre era valersi di interessi e di sentimenti veri.
Uno storico austriaco, apologista del cardinal Ruffo, il barone von Helfert, dice che il Cardinale, per una così difficile impresa, non potea scegliere i suoi compagni. E certo non li scelse! Ruffo avea seco, condottieri del suo strano esercito, briganti famosi come Panedigrano, Pansanera, Sciarpa, Mazza, De Castro e tanti altri famosi negli annali del delitto. E mentre il Cardinale operava da un lato, Pronio e Rodio, due avventurieri, operavano in Abruzzo, Mammone e Fra Diavolo in Terra di Lavoro: altri iniquissimi altrove.
I nomi di Mammone e Fra Diavolo hanno ormai acquistata una celebrità internazionale.
Gaetano Mammone, nativo di Terra di Lavoro, era un monomane del delitto: uccideva senza ragione, per piacere, e giungeva a atti di crudeltà che parrebbero inverosimili. Vincenzo Cuoco dice di lui ch’era mugnaio di mestiere; che in due mesi di comando in poca estensione di terreno fece fucilare 350 persone; oltre forse del doppio uccisi dai suoi satelliti e accenna alle crudeltà e ai tormenti da lui inventati. “Il suo desiderio di sangue umano, scrive Cuoco, era tale che si beveva tutto quello che usciva dagl’infelici che faceva scannare: chi scrive lo ha veduto egli stesso beversi il sangue suo dopo essersi salassato e cercar con avidità quello degli altri salassati che eran con lui; pranzava avendo a tavola qualche testa ancor grondante di sangue, beveva in un cranio… A questo mostro scriveva Ferdinando dalla Sicilia: mio generale e mio amico”. Tutto ciò è confermato dalle cronache dei tempi e dagli scrittori più autorevoli.
Meno terribile ma più drammatica la storia di Michele Pezza, conosciuto sotto il nome di Fra Diavolo; le cui avventure romanzesche hanno fornito a Scribe e ad Auber il soggetto di uno dei loro migliori melodrammi. Omicida e dei più terribili avea, dicono, l’astuzia del monaco e la perfidia del diavolo. Era già brigante da qualche anno, quando sopraggiunsero gli eventi del 1799; non tardò a illustrarsi con le sue crudeltà. Dopo la restaurazione monarchica ebbe, come Mammone, un altissimo grado nell’esercito, una pensione di 3000 ducati e fu nominato duca di Cassano. Nel 1806 volle ancora insorgere in difesa del re Ferdinando contro la monarchia francese; ma dopo molte peripezie, fu impiccato al largo del Mercato – e a dileggio, dicono, gli si lasciò l’uniforme di generale addosso e gli si sospese al collo il diploma di duca di Cassano.
Or guardate i miracoli della previsione. Nel 1803, tre anni prima cioè che Fra Diavolo fosse impiccato, era pubblicata a Parigi una storia romanzesca sotto il titolo Les exploits et les amours de Fra Diavolo, general de l’armée du cardinal Ruffo. L’incisione del frontespizio rappresenta Fra Diavolo in abito da frate, armato di carabina, pistola, pugnale, sciabola e accetta; nel romanzo egli è fatto cavaliere e la scena delle sue azioni è raffigurata in Calabria. Il romanzo non è che una serie d’invenzioni. Ma vi è di vero solo una predizione. Il romanziere fa finire Fra Diavolo sulla forca, per essersi messo di nuovo in campagna: allora Fra Diavolo era vivo, ma tre anni dopo finì in realtà sulla forca.
Or fu con questi elementi, che la monarchia borbonica fu restaurata. I lazzari di Napoli gridavano a Ferdinando IV che rientrava a Napoli: Signò, ‘mpennimmo chi t’ha traduto, Prievete, muonece e cavaliere! Fatte cchiù cà, fatte cchiù là, Cauce ‘n facce a la libbertà.
Tutti i canti popolari di quel tempo non sono che feroci apostrofi alla libertà, violente ingiurie ai giacobini: poesia infame, ma che esprimeva sentimenti veri e sopra tutto speranza di tempi migliori: A lu suono de li tammurilli So risurte li puverielli! Il brigantaggio del 1799 fu, come assai più tardi quello del 1860, accresciuto dall’aver disciolto l’esercito del re. L’esercito raccoglieva allora i più poveri, poiché i ricchi e i borghesi si faceano esentare, e raccoglieva anche gli elementi peggiori. Macaulay dice che al ritorno del re legittimo in Inghilterra fu necessario sciogliere l’esercito rivoluzionario di Cromwell. Cinquantamila uomini, abituati a battersi, furono lasciati sulla strada. V’era da aspettarsi qualunque cosa: invece alcuni mesi dopo non rimaneva traccia che indicasse che una delle armate più formidabili era stata assorbita nella massa del popolo. E quando si vedeva un operaio prosperare in oneste industrie, si poteva dire quasi con sicurezza che egli aveva fatto parte dell’esercito di Cromwell.
Nel reame di Napoli, quando per due volte fu sciolto l’esercito del re legittimo, la maggior parte di esso si diede al brigantaggio, alla rapina e al vagabondaggio. Del resto che cosa poteva essere un esercito in cui i gradi eminenti erano riserbati a Mammone e a Fra Diavolo, e che cosa poteva essere un’amministrazione in cui si davano i posti più alti a uomini come il brigante Panedigrano? Quando nel 1806 si stabilì a Napoli con Giuseppe Bonaparte da prima e poi con Gioacchino Murat la monarchia francese, i Borboni fuggirono di nuovo in Sicilia. Ancora una volta non mancarono di aizzare il popolo e di rinfocolare il brigantaggio; Fra Diavolo uscì in campo di nuovo e uscirono altri già noti nel 1799, i Pizza, i Guariglia, i Furia, gli Stodui e altri di pessima fama. Con danari e con promesse il brigantaggio fu promosso dovunque. Molti si davano alla campagna perché avean vendette da compiere; altri perché l’esempio dei contadini promossi colonnelli o duchi, come Mammone e Fra Diavolo, accendeva le menti.
Così in Basilicata dominavano Taccone e Quagliarella; nei due Principati Laurenziello; nelle Calabrie Parafante, Francatrippa, Benincasa, il Boia, Carmine Antonio, Mascia, Mazziotti, Bizzarro; negli Abruzzi Antonelli, Fulvio Quici, Basso Torneo e altri celebri. Quando Murat salì al trono, tutto il regno si può dire che era infestato di briganti: gli esempi del 1799 accendevano le menti, e ogni contadino insofferente della miseria, come ogni ribaldo desideroso di conquistare la fortuna si davano alla campagna.
Ma non era possibile ripetere a pochi anni di distanza il tentativo di Ruffo, e mancava in ogni caso l’uomo. Seguiti da torme fameliche, i briganti entravano nelle città, depredavano, violavano le donne e si dicevano difensori del sovrano legittimo. Bizzarro, non meno feroce di Mammone, osava dare in pasto ai suoi cani ufficiali francesi trucidati barbaramente e aveva abituato i mastini a dare la caccia agli uomini; altri facean cose ancor più crudeli e avevano aria di dominatori. Taccone dominava addirittura il nord della Basilicata. In una delle sue crudeli escursioni corse ad assediare, nel castello di Abriola, il barone Federici. Dopo un blocco di parecchi giorni costrinse il barone a rendersi, promettendo che non si sarebbe fatto male ad alcuno. Appena entrati i briganti violarono la moglie e le figlie del barone e poi buttarono tutta la famiglia nelle fiamme, da cui non si salvò per miracolo che un bambino.
Basso Torneo, crudelissimo, detto il Re della campagna, bruciava perfino una caserma di gendarmeria e condannava a esser bruciati vivi le mogli e i figli dei gendarmi assenti. Parafante, il Boia, Francatrippa e Laurenziello commettevano gesta ancor più nefande.
Per il governo era necessità vincere il brigantaggio, sradicarlo sia pure in modi crudelissimi.
La monarchia di Gioacchino non era sicura se non debellando le torme ogni dì crescenti e i cui capi erano in corrispondenza con casa Borbone e la corte di Palermo. Fu adottato un rimedio estremo, e il generale francese Carlo Antonio Manhès ebbe l’incarico di distruggere a ogni costo i briganti e gli furono conferiti poteri eccezionali. Il generale Manhès, che a quasi un secolo di distanza si nomina ancora con terrore nelle Calabrie e in Basilicata, era un degno generale di Gioacchino: intraprendente, arditissimo, senza scrupoli e nello stesso tempo uomo galante e avventuroso.
Manhès non esitò. Bisognava, per agire sulle fantasie meridionali, per vincere rapidamente il brigantaggio, non avere pietà, sopra tutto non transigere mai. In Abruzzo il brigantaggio fu distrutto in poco tempo: Antonelli impiccato, altri uccisi. Ma le difficoltà più gravi erano in Basilicata e in Calabria, province più vicine alla Sicilia, da cui i briganti ricevevano soccorsi e aiuti e promesse. Manhès avea pieni poteri: vi si recò, fece cose crudelissime. Taccone fu preso ed entrò a Potenza non da trionfatore si come aveva sperato, ma a cavalcioni di un asino, la coda del quale servivagli da briglia e con una mitra in testa, sulla quale leggevasi a grandi lettere: “Questo è l’infame e crudele assassino Taccone”. Era un supplizio molto comune allora, e voleva riescire di esempio al popolo. Quagliarella, abbandonato dai compagni, fu ucciso a colpi di falcetto dai mietitori di Ricigliano, desiderosi di guadagnare la taglia che gli pesava sul capo.
Bisognava che la repressione non solo fosse terribile, ma apparisse tale. Manhès non trascurò nulla a quest’ogetto. Il villaggio di Parenti, ove una compagnia di francesi era stata trucidata, fu messo in fiamme; altri paesi distrutti. Con procedimento sommario, qualche volta senza nessun procedimento, migliaia di uomini furono uccisi. “lo non vorrei essere stato il generale Manhès – dice Pietro Colletta – ma nemmeno vorrei che il generale Manhès non fosse stato nel Regno nel 1809 e nel 1810. Fu per opera sua se questa pianta venefica del brigantaggio venne alla perfine sradicata”.
Manhès – come disse nel suo ordine del giorno di Monteleone – volle agire di un tratto, colpendo la causa stessa del male: volle prendere i briganti per fame. Sotto pena di morte fu vietato a chiunque di fornire loro viveri: e la disposizione fu applicata senza pietà. Significava colpire al cuore il male, poiché dopo la caduta delle nevi non era possibile ai briganti durare senza avere i viveri dai borghi.
La terribile repressione cominciò con il comune di Serra. In quel comune, messo fra le giogaie dell’Aspromonte, i briganti avevano fatto sapere che voleano arrendersi: chiesero un abboccamento al sindaco, al tenente della gendarmeria e al capitano della guardia nazionale. Non diffidando, questi non presero alcuna precauzione: i briganti invece irruppero armati nella sala e trucidarono le autorità. Il tenente si chiamava Gérard, e sua moglie, bella giovane di 22 anni, caduta poco tempo prima nelle mani dei briganti di Castrovillari aveva subìto il più crudele oltraggio e dopo era stata assassinata. Manhès volle fare una vendetta terribile. Si recò a Serra seguito da molti soldati: il paese fu pieno d’armati, e la costernazione entrò nell’animo di tutti.
Manhès non volle ricevere alcuno; vegliò tutta la notte, pensando alla vendetta più crudele. La scelta della punizione era difficile. Da una parte non si poteva distruggere un paese necessario alla difesa nazionale. Gli abitanti di Serra erano infatti addetti alla industria del ferro ed essendo allora, a causa degli inglesi, impossibili o molto difficili le comunicazioni per via di mare, le poche miniere di ferro di Calabria eran preziose.
La gente di Serra, convinta che il paese sarebbe stato distrutto passò la notte in orazioni e in pianti, cercando di mettere in salvo quanto poté di mobili e di oggetti di valore. La mattina il generale ordinò che tutta la popolazione fosse riunita nella pubblica piazza: l’assemblea fu innumerevole. Neppur uno mancò: vecchi e malati si trascinarono e si fecero trascinar. Manhès entrò in mezzo alla folla e parlò con veemenza: tutti tremavano. Ei disse che erano uomini senza onore, che tutti dovevan perire, che neppur uno si sarebbe salvato.
A un punto ebbe una idea luminosa. Nel profondo terrore di tutti: “Io ordino – esclamò – che tutte le chiese di Serra siano murate, che tutti i preti senza eccezione abbandonino questo paese maledetto e vadano a Maida. I vostri fanciulli nasceranno senza battesimo; i vostri vecchi moriranno senza sacramento. Se alcuno tenterà di uscire dal paese sarà ucciso e voi dovrete vivere soli come cani”.
Bisogna conoscere il paese per comprendere l’abbattimento che vinse tutti; una condanna di morte non avrebbe agito così. Quando Manhès partì, tutta la città era deserta. Ma nel bosco il generale s’imbatté in una processione interminabile: migliaia di persone con le camicie bianche, si battevano il petto nudo con le pietre e imploravano misericordia. – Uccideteci piuttosto! – esclamavano.
Manhès fu inesorabile. I preti furono condotti via tutti; fu portato a braccia perfino un vecchio prete di ottant’anni e rinchiuso nel seminario di Maida. Serra rimase nella desolazione con le sue chiese chiuse. Il generale promise che avrebbe perdonato solo quando in tutto il territorio di Serra e nei boschi vicini non fosse stato in vita un solo brigante. La disperazione fece fare cose terribili: i legami di amicizia o di sangue non impedirono la strage. Neppure un brigante sfuggì. In pochi giorni fu fatto ciò che nessun esercito avrebbe potuto. E allora Manhès tolse l’interdetto. La popolazione tutta intiera si recò a Maida a riprendere i suoi preti, fra le grida di giubilo, e d’allora Serra non ebbe mai più un brigante.
“Ove i popoli sono infieriti con le armi – ha detto Vico – talché non vi abbiano più luogo le umane leggi, l’unico potente mezzo di ridurli è la religione”.
Oltre gli uccisi, il cui numero è assai difficile indicare, 1200 briganti furono rinchiusi nelle diverse prigioni della Calabria. Sotto la più terribile delle persecuzioni i capi si videro abbandonati dai seguaci; resa loro impossibile la comunicazione con coloro che erano nei paesi e che li aiutavano, fucilati costoro su semplice sospetto, messe grosse taglie sui briganti più noti, l’avidità, il desiderio di salvarsi fecero sì che molti tradirono o vendettero compagni.
La fine di molti briganti fu crudelissima.
Più terribile, più tragica di tutte la fine del brigante Bizzarro. Attorniato da ogni parte, abbandonato da tutti, si era ridotto nel bosco di Rosarno con la sua amante Niccolina Licciardi di Seminara e con i suoi due terribili mastini, divoratori di uomini. L’amante avea dato da pochi mesi a Bizzarro un figliolo, e nelle lunghe fughe precipitose, nelle peregrinazioni dolorose la donna portava a braccia il bambino: madre e amante fedele nel periglio. Bizzarro si era ricoverato in un antro solitario, noto forse a lui solo, e di cui l’entrata assai angusta era difesa e nascosta dai rovi e dalle erbacce. Ora il bambino, che avea sofferto di quella vita errante, piangeva sempre. La donna cercava invano di attaccarlo al seno esausto; la notte sopra tutto non facea che gridare. Una notte in cui le grida erano maggiori e i terribili cani guaivano quasi sempre per segnalare l’avvicinarsi di gente, Bizzarro esasperato, temendo di essere scoperto, prese il figlio per un piede e lo fracassò contro il muro. La donna non disse nulla.
La mattina, quando il brigante fu uscito, scavò con il coltello una fossa nella grotta e vi seppellì dentro il figliolo e vi pose sopra il letto, perché i cani non scavassero il cadavere per divorarlo. Nelle notti insonni ella dovette maturare il pensiero terribile; e una notte che Bizzarro dormiva prese il fucile e lo uccise. Poi gli recise la testa, la mise nel grembiale e si recò al comune vicino per chiedere il danaro promesso a chi avrebbe dato morte al brigante. Qualche tempo dopo la donna si maritò e il generale Manhès dice che fu sposa e madre esemplare. La persecuzione di Manhès in Basilicata e in Calabria durò pochi mesi; ma fu così terribile, che in breve tempo non rimase più in vita un solo brigante. Dalla persecuzione di Manhès, avvenuta fra il 1810 e il 1811 sino alla fine della dinastia borbonica, nel 1860, in mezzo secolo, fatta qualche eccezione, il brigantaggio torna a essere malandrinaggio.
Appaiono anche in questi cinquant’anni alcune eccezioni notevoli, come quel famoso don Gaetano Vardarelli, intelligente e non privo di studi, che insieme ai suoi fratelli e a molti compagni dominò quasi la provincia di Foggia fra il 1815 e il 1817. Carbonaro e cattolico avea, malgrado non poche ribalderie, tendenze liberali e umanitarie e volea rassomigliare e rassomigliava in qualche cosa ad Angelo Duca. I Vardarelli aveano con sé la simpatia delle popolazioni, e non erano da confondersi con i banditi volgari. Il governo borbonico, che non avea potuto averli per forza d’armi, li ebbe per tradimento: promise loro ciò che chiedevano, e come tante volte prima e dopo, venne meno al patto. Il brigantaggio ebbe ancora qualche figura meno crudele o corrotta: ma fu sempre, dopo sfogo naturale della miseria, della ingiustizia e della delinquenza, sì com’era stato prima nel 1799.
I famosi briganti del regno di Francesco I, la “grande compagnia di Gasparone”, la quale taglieggiava i comuni e i proprietari in Abruzzo; la triste comitiva di Mezzapenta, famosa in Terra di Lavoro; le piccole bande sparse dovunque nella Basilicata non riunivano che disgraziati o delinquenti. Le operazioni erano sempre le stesse; si derubavano i viandanti, s’imponevano taglie ai possidenti, sotto minaccia di rovinare le loro proprietà; si rubavano e violavano donne, si eseguivano vendette per incarico o per commissione; storia di tristezze e di miserie.
Accanto al brigantaggio fioriva il manutengolismo, come si dice ancora da noi, ed era di due specie: era fatto per timidità ed era fatto per avidità. Vi erano coloro che speculavano sui briganti, che qualche volta arricchivano su di essi. I briganti doveano avere il protettore, l’informatore, il difensore; e spesso queste qualità si trovavano in coloro stessi che doveano perseguitarli.
Parecchie fortune sono state fatte col brigantaggio; assai spesso il manutengolo arricchiva e il brigante finiva sulla forca. Le chiese stesse e i monasteri erano asilo di briganti, e i monaci di Venafro pregavano il giorno e non disdegnavano la notte di travestirsi per assalire i viandanti e per derubarli. Anche durante il regno di Ferdinando II il brigantaggio non fu che malandrinaggio: raccontarlo non sarebbe che ripetere una storia di dolore e di sangue. Le autorità erano fiacche, le popolazioni impaurite, le miserie grandi; l’esempio dei briganti arricchiti esaltava e accendeva le nature più miti. Perfino in tempi molto vicini a noi Ferdinando II, non riescendo a vincerlo altrimenti, graziava il brigante Giosafat Talarico, gli accordava lauta pensione e soggiorno nella ridente isola d’Ischia.
Ma la minaccia era sempre sospesa sul capo dei liberali, e le classi desiderose di novazioni (in grandissimo numero per necessità o per bisogno, in una certa parte per idealità) si preoccupavano dei massacri che ogni mutamento avrebbe prodotto: si sapeva che qualsiasi rivoluzione volea dire Santa Fede a Napoli e il brigantaggio nelle province. Nel 1820, che pure non lasciò traccia alcuna, perché fu moto incomposto e ingiustificabile, mentre i carbonari discutevano di libertà e i loro seguaci chiedevano impieghi nelle province, il brigantaggio si acuiva.
Più ancora il male si manifestò nel 1848.
Data la costituzione a malincuore, si volle dalla Corte determinare quello stato di squilibrio, che rendeva necessario il ritorno al vecchio regime. I principi di casa reale, come il conte d’Aquila e il principe di Salerno pensarono di “promuovere la rivolta dei contadini nelle province, della plebaglia nella capitale”, come scrive P.S. Leopardi. Difatti, in parecchi comuni, torme di contadini invasero le terre pubbliche e vollero dividersele e il brigantaggio, già depresso, cominciò a rifiorire.
Leggendo gli scritti e la corrispondenza dei liberali del 1848 traspare ogni momento la loro ingenua sorpresa nel vedere che, mentre essi lottano per la libertà, i contadini si rivoltano, invadono le terre pubbliche e se le appropriano, oppure si trasformano in briganti. L’8 giugno del 1848 Carlo Poerio scriveva a Raffaele Poerio: “Una setta anarchica s’impadronisce delle proprietà dei privati e quindi irrita e allarma i ricchi e li rende devoti a qualunque governo che prometta sicurezza”. E dopo ingenuamente confessa che, mentre la famiglia Poerio fa tanti sacrifizi, “i nostri coloni non pagano e la guardia nazionale di Policastro s’impadronisce della Sila e la divide fra i suoi abitanti!”. E lo stesso Carlo Poerio scriveva ad Alessandro il 22 luglio del 1848: “La difficoltà non è di far cadere il Ministero; ma sibbene di comporne un altro, mentre vi è una feroce reazione sanfedista nelle province, dove vi era stata mossa… La rapina e i ricatti delle bande armate aveano finito di disgustare la massa dei proprietari e degli onesti cittadini. Nel Cilento, poi, gli sciagurati, che si sono mossi, formano una setta antisociale e bestiale, che non si occupa d’altro fuorché di mettere a sacco e a ruba il paese”.
Nei nostri Parlamenti si fa sovrastare ora il pericolo dei dinamitardi; allora non v’era la dinamite e si parlava con terrore dei fuochisti, miserabili contadini che a ogni agitazione volevano riprender le terre che gli altri usurpava. E la monarchia trovava la difesa appunto nel divampare degli odii popolari. Così Francesco II cercò di salvarsi nel 1860, impiegando la stessa politica che più di sessant’anni prima avea salvata la corona del suo bisavolo. Egli e i suoi, prima di andar via, gittarono in fiamme il reame. L’esercito disciolto, proprio come nel 1799, fu il nucleo del brigantaggio, come la Basilicata ne fu il gran campo di azione. Anche allora uomini di fede pura lasciarono la vita miseramente. I briganti entrarono nelle borgate e nelle città, ebbero i loro generali, i loro capi, i loro protettori, i loro sfruttatori; fu l’esplosione di tutti gli odii, fu il divampare di tutte le vendette. Sopra tutto al sorgere del brigantaggio nel nord-est della Basilicata, fra i trucidati furono alcuni uomini che erano per la virtù della vita e la nobiltà delle idee onore della loro terra. Ma più tardi la politica entrò solo in parte, come mezzo di unione e di rallegamento. Il popolo non comprendeva l’unità, e credeva che il re espulso fosse l’amico e coloro che gli succedevano i nemici. Odiava sopra tutto i ricchi, e riteneva che il nuovo regime fosse tutto a loro benefizio.
L’Italia nuova non ha avuto il suo Manhès; ma le persecuzioni sono state terribili, qualche volta crudeli. Ed è costata assai più perdite di uomini e di danaro la repressione del brigantaggio di quel che non sia costata qualcuna delle nostre infelici guerre dopo il 1860.
V’ho detto che cosa sia stato il brigantaggio: vi ho raccontato tutta una storia di dolore. Ora permettete che io mi chieda: abbiamo noi rimosse le cause del male? La stessa domanda si rivolgeva venti anni or sono Pasquale Villari, e rispondeva con tristezza che le cause esistono tuttavia. Alcune, e le principali, non solo non sono state eliminate, ma in qualche punto si sono inacerbite.
Abbiamo costruito alcune ferrovie ed è stato un bene anche quando non rappresentano un’attività; abbiamo imposta, sia pure con poca efficacia, l’istruzione obbligatoria, e il popolo, se ha imparato molte cose inutili, alcune utili ha appreso. L’esercito, per fortuna nostra non ancora basato sull’ordinamento territoriale, che vorrebbe dire la fine dell’unità, ha avuto un vantaggio: centinaia di migliaia dei nostri contadini sono usciti dai loro paesi, hanno visto nuove città, hanno sopra tutto dimenticato. Gli odii trasmessi per eredità, acuiti dalla vicinanza, esacerbati dalla ingiustizia, sono qualche volta diminuiti. Il contadino ha acquistato un più alto concetto di sé; chi ricorre a lui, sia pure per il voto, per la sovranità fittizia del momento, non può esser sempre inumano.
Ma in tutto il resto le cose non sono mutate. La massa degli intermediari è cresciuta, è altresì strabocchevolmente aumentato il numero dei professionisti. Vi erano nel regno di Napoli centomila ecclesiastici un tempo: maggiore è forse oggi, nelle province che lo componevano, il numero dei professionisti laureati e diplomati. E almeno gli ecclesiastici non si sposavano e non chiedevano alle amministrazioni impieghi per i figliuoli. Le terre pubbliche sono state usurpate, usurpate contro la legge, e noi abbiamo assistito spettatori silenziosi a tanto male. Le imposte sono cresciute e cresciute su chi non può pagarle: e sono pondo insostenibile e crudele. Non una parola di amore ha portato la civiltà nuova a tante sofferenze, non una parola di pace. I contrasti sono ancora stridenti; e così assorbiti come siamo dalle nostre miserie, dalle nostre vanità, dalle nostre preoccupazioni, noi chiudiamo gli occhi a tutto e non vediamo. In un’ora difficile, in un’ora di periglio, il male sopito ora potrebbe divampare.
E allora, voi mi chiederete, perché il brigantaggio non esiste più quando molte cause permangono? Perché noi mandiamo ogni anno fuori di Europa, dal solo Mezzogiorno continentale, un vero esercito di quasi cinquanta mila persone e i contadini di Basilicata, delle Calabrie, del Cilento, che non chiedono nulla allo Stato, nemmeno bonifiche derisorie, nemmeno consorzi mentitori, nemmeno tariffe di protezione, danno il contingente più largo. Io vorrei fare, io farò forse un giorno una carta del brigantaggio e una dell’emigrazione e l’una e l’altra si completeranno e si potrà vedere quali siano le cause di entrambi.
Una delle più crudeli accuse e più inique è nel dire che i contadini meridionali amano l’ozio; ho visto molta gente lavorar meglio, nessuno lavorar più. La miseria crudele non ha ucciso le intime energie della razza, l’anima essenziale della stirpe; il brigante e l’emigrante con la rivolta e con l’esodo sono la prova di una mirabile capacità espansiva.
– Che cosa farai? – io chiedevo al vecchio contadino che partiva.
– Chi lo sa! – egli mi rispondeva.
Non chiedeva nulla, non voleva nulla. Andava a lottare, a soffrire; aspirava alla sazietà. In altri tempi sarebbe stato brigante o complice; ora andava a portare la sua forza di lavoro, il suo misticismo doloroso nella terra lontana, a costituire forse con i suoi compagni quella che dovrà essere la nuova Italia.
O povera gente così forte e così infelice, così buona e così calunniata!
(1899)
* Non ho creduto necessario di riprodurre la lunga bibliografia sul brigantaggio meridionale, né le molte fonti cui son dovuto ricorrere. Ringrazio qui solo l’amico Benedetto Croce delle notizie e dei dati che mi ha voluto cortesemente fornire.
fonte
Eroi e Briganti



 invio in corso...
invio in corso...