Il caso Aunis
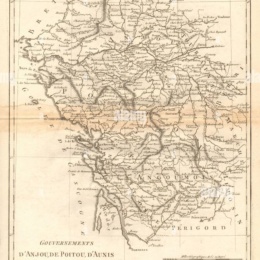
A tutt’oggi, siamo nella seconda metà del 2013, il caso dei due nostri marò in servizio sulla nave Enrica Lexie e tenuti in stato di arresto in India, non è ancora arrivato alla sua conclusione.
Pochi sanno che alcuni “ribelli” napoletani furono protagonisti di un caso simile nel lontano 1863. Si tratta del cosidetto Caso Aunis, dal nome della nave che li trasportava.
Pubblichiamo un estratto del brillante articolo scritto da Gaetano Marabello e pubblicato dalla rivista L’Alfiere. Ringraziamo il suo gentilissimo direttore, Eduardo Vitale, per averci consentito la pubblicazione di questa interessantissima storia.
Il brutto affare dell’ Aunis
Di sicuro, in una nazione diversa dall’Italia odierna, il caso della Enrica Lexie, ove erano i due marò del battaglione San Marco fermati per l’uccisione di due indiani, sarebbe stato tutti i giorni sulle prime pagine. Invece per il tarantino Massimiliano Latorre e il barese Salvatore Girone, imbarcati ufficialmente in funzione di contrasto alla pirateria, le notizie col contagocce sono state la regola, benché rischiassero e rischiano l’ergastolo o la pena capitale. Nell’intera a vicenda, a prescindere dalla sua conclusione, ci sembra giochino ragioni che nulla hanno a che fare con la giustizia. Naturalmente, anche in passato le cronache marittime hanno registrato di quando in quando episodi, capaci di creare tensioni tra due Stati.
…
Il caso Aunis
Seguì in data 10 luglio 1863 il clamoroso Incidente dell’Aunis. Ce ne occuperemo qui di seguito, perché per molti aspetti esso s’avvicina al caso della Enricao Lexie. Quella volta, a trovarsi di fronte, furono Italia e Francia. Il bastimento coinvolto nella querelle fu un piroscafo, che portava il nome d’una provincia francese e che svolgeva servizio di messaggeria postale imperiale. Quel giorno, esso annoverava come passeggeri cinque guerriglieri del deposto sovrano delle Due Sicilie Francesco II. I “briganti” possedevano un regolare passaporto che li qualificava “onesti industrianti”, vistato dalle ambasciate francese e spagnola di Roma (come meta c’era non solo Marsiglia, ma anche Barcellona). Su delazione di qualche spia capitolina, il prefetto di Livorno segnalò al collega di Genova la presenza a bordo dei ricercati. Sicché, appena il vapore fece scalo intermedio nel porto ligure, il questore inviò sulla nave una squadra di poliziotti con l’ordine di perquisizione e arresto. E solo dinanzi alle resistenze del comandante e del suo vice le autorità locali si decisero a rivolgersi al consolato francese della città. Messo sotto pressione, il console cedette, salvo rimangiarsi tutto a cose fatte adducendo d’aver voluto “evitare scandali”.
L’arresto e la contesa franco-italiana
Sta di fatto che i cinque passeggeri vennero comunque arrestati, anche se i due fratelli La Gala tentarono invano d’evitar la cattura buttandosi in mare. Due giorni dopo, il ministro degli esteri francese accusò apertamente il prefetto italiano e il console francese d’eccesso di potere in una questione politica, la quale dipendeva esclusivamente dalla Legazione dell’Imperatore in Italia. Chiese quindi la restituzione dei prigionieri. Anche la stampa transalpina s’accodò alla protesta, toccando le corde dell’onore offeso della bandiera di Francia e accusando il governo italiano di ‘Violazione della territorialità”. Di rimando, alcuni giornali italiani come L’Armonia e Il diritto arrivarono ad incitare il governo a fucilare i prigionieri e a restituirne i corpi per la tumulazione “nelle tombe dei Reali di Francia”. Questa virulenta reazione rendeva evidente che a Torino qualcuno non aveva ancora digerito il precedente “affronto” del Gulnara. Nel 1844, questo bastimento sardo era stato costretto da una tempesta ad un approdo forzato a Bastia. La polizia francese ne aveva però subito profittato, per arrestare un brigante corso che era a bordo. A certi oltranzisti non sembrava vero di poter rendere ora la pariglia ai cugini francesi, tanto che la discussione rimbalzò in Parlamento. A conti fatti, dunque, per l’affaire Aunis il governo italiano si trovò compresso tra l’incudine francese e il martello dell’opposizione. Dovette assumere di conseguenza una posizione imbarazzata, in quanto, checché ne pensasse Pasquale Stanislao Mancini che ne assunse le difese, le disposizioni dei trattati erano chiare.
La soluzione diplomatica
Sta di fatto che il Consiglio del contenzioso diplomatico il 19 luglio del ’63 ritenne che gli arrestati dovessero essere restituiti alla Francia, suggerendo però all’Italia di richiederne l’estradizione in base ad una convenzione del 23 maggio 1838. Il seguito si svolse di conseguenza. In sostanza, i cinque ricercati passarono dal carcere di Genova a quello di Chambery e di lì, una volta estradati, finirono il 24 febbraio 1864 davanti alla Corte d’assise di S. Maria Capua Vetere.
Il processo ed il cacere duro
Il processo, che ebbe una risonanza enorme tale da imporre l’uso di un’aula più grande, fu condotto avanti a ritmi davvero inconsueti perché si concluse in un paio di settimane appena. Inutilmente l’ottimo collegio di difesa degli imputati s’industriò a smantellare le testimonianze, poste a base del castelletto d’accusa.
L’esito inevitabile fu la condanna a morte per i fratelli La Gala e una serie variabile di condanne detentive per gli altri imputati minori. Si tacitava in tal modo quella parte d’opinione pubblica, reclamante il pugno di ferro contro i ribelli meridionali che ancora s’opponevano con le armi all’annessione. In realtà, come ammise nel gennaio 1865 il ministro di grazia e giustizia Vacca, c’era stato un accordo sottobanco con la Francia con la quale si stava per addivenire alla Convenzione di settembre. In pratica, venne fuori che l’Italia aveva assunto l’impegno morale di salvar la vita ai detenuti. Ciò spiega la ragione per cui la domanda di grazia, avanzata dai due condannati a morte, venne subitaneamente commutata nei lavori forzati a vita.
Comunque sia, Giona e Cipriano La Gala finirono i loro giorni in bagni penali diversi (Portoferraio e Genova), ma in condizioni di detenzione identiche. E queste ultime furono tanto orribili da far esclamare al Vismara che le loro pene confinavano con le “sevizie”. Si pensi che la loro cella era lunga due metri e larga 1.20, che luce e aria giungevano solo da un finestrino della porta e che il letto era un banco di pietra con la latrina incorporata. Inoltre i condannati portavano al piede una catena di circa 20 chili, infissa nel muro e lunga appena un metro. Insomma, la cancrena era quasi scontata. La vigilanza poi non dava tregua, essendo prevista un’ispezione ogni tre ore, con divieto ai guardiani di rivolgere la parola ai due carcerati. Un inferno, dunque, che non concorreva certo al ravvedimento e che faceva alla lunga perdere memoria e favella a quei sepolti vivi. Sentendo dalla voce di un liberale, com’era indubbiamente il Vismara, quali generi di “delizie” riservassero le carceri dei Savoia ai detenuti, vien da rabbrividire. E il pensiero corre subito a quel lord Gladstone, che divenne – ed è ancor oggi – un idolo per certa gente proprio grazie alla descrizione delle “terribili” carceri borboniche. Carceri, che peraltro l’interessato impostore d’oltre Manica in realtà mai ebbe a vedere.
fonte
http://www.quicampania.it/ilregno/caso-aunis.html



 invio in corso...
invio in corso...



