La quarta Calabria

Le Calabrie, com’è noto, erano tre: la Calabria Citeriore, l’Ulteriore Prima e l’Ulteriore seconda e coincidevano, grosso modo, con le tre storiche province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Non ricordo chi, aggiungeva, tra il serio ed il faceto, che c’era una quarta Calabria: la Calabria Deteriore! La notazione veniva lasciata volutamente in sospeso né, credo, sia mai stata identificata la parte di territorio regionale cui attribuire tale denominazione.
Poteva essere, quindi, di volta in volta, individuata questa o quell’area della regione a seconda dell’estro di chi voleva servirsi di questo strano toponimo. Nel romanzo di Pantaleone Sergi, al suo esordio letterario, l’immaginario paese di Mambrici, più che al Macondo di Garcia Marquez, troppo distante e troppo diverso, appartiene a questa “quarta” Calabria. Anzi Sergi ha dato, con il suo bel racconto, anima e corpo a questa “Calabria Deteriore”, che, fin’ adesso era solo una categoria astratta ed ora, invece, viene rappresentata come la sintesi perfetta e completa di tutti i vizi, i difetti, i mali che affliggono questa nostra complicata regione. Si può dire che Sergi ha creato un modulo, ha costruito una sorta di microcosmo calabrese in cui ciascuno di noi, specialmente se appartiene o è vicinissimo (come me) alla sua generazione, può facilmente identificarsi, riconoscersi e riconoscere uomini, ambienti e vicende. Per chi conosce il territorio calabrese, anche da un punto di vista strettamente geografico, l’A. è riuscito a costruire una sorta di plastico architettonico-letterario perfettamente collocabile in qualsiasi area della regione.
La Calabria tra la fine dell’800 ed il primo dei grandi terremoti, quello del 1905 (l’altro sarà quello catastrofico di Reggio e Messina del 1908) era quella che Sergi magistralmente disegna e poi fotografa con una descrizione minuziosa delle strade, delle case, dei palazzi, dei tuguri, dei catoi, delle stalle, dei frantoi. Qualsiasi paese della Calabria è Mambrici.
In qualsiasi comune della Calabria c’era la divisione castale di cui parla Sergi tra l’aristocrazia gretta, pomposa e lontana; la borghesia fatua, ignorante, interessata ed avara; un ceto artigiano geloso, ambizioso, spesso frustrato; uno strato di “massari” desiderosi di arricchirsi alle spalle dei padroni ed una massa sterminata di contadini, braccianti, jornatari, carbonai, mulattieri, pecorari che vivevano in condizioni subumane. Plebe superstiziosa ed ignorante, allevata nella miseria e nell’odio, soggiogata da proprietari senza scrupoli e da un clero inerte ed accomodante.
Il destino di quella plebe è stato riassunto da Nicola Zitara nell’espressione “o emigrante o brigante” poiché chiunque prendeva conoscenza (e prima ancora: coscienza) di quello stato di cose, stanco di affidarsi ad una divina provvidenza che tardava, e di parecchio, a manifestarsi, non poteva che scegliere una delle due strade. La terza via, che pure Sergi, con pennellate di colore, delinea, quella della ndranghita statu nascenti (ma, mi pare, che all’epoca, non vorrei apparire pedante, si dicesse: picciotteria) che s’insinua come una vipera strisciante nel corpo della comunità di Mambrici, appariva una strada praticabile solo da coloro i quali si fossero dimostrati pronti a delinquere, elevando un simile comportamento, con tutti i rischi connessi, a proprio stile e scelta di vita.
Vorrei sottolineare che agli emigranti giunti in America, specialmente negli Stati Uniti, si poneva un altro dilemma, diventare “o anarchici o maffiosi”, almeno stando ai pochi ricordi e alla scarne e scarse lettera che inviava il mio nonno paterno, emigrato negli USA nel 1903 ed ai racconti di emigranti del tipo di Antonio Margariti (Ferruzzano, 1891 – Willow Grove, 1981), che scrive la sua autobiografia in un calabrese inglesizzato di difficile comprensione e che scolpisce con una frase la sua condizione incerta:
–…quando mi domandano voi siete americano? Io rispondo: in America mi chiamano italiano e in Italia mi chiamano ‘u mericanu.
Questo è un aspetto che, anche dal punto di vista letterario, non è stato ancora sufficientemente indagato e speriamo che qualcuno abbia voglia di metter mano.
Nell’affresco che Sergi dipinge più che le atmosfere sudamericane di Garcia Marquez o di Isabel Allende, più che il cinismo realistico di un Tommasi di Lampedusa o il pessimismo veristico di un Verga, personalmente vedo, invece, riflessa tutta la nostra migliore letteratura da Repaci a Perri, da Seminara a Strati, da Alvaro a Lacava, passando attraverso Peppino Occhiato fino ad arrivare a Mimmo Gangemi. La lectio di questi autori, Sergi l’ha assorbita, l’ha rivista e l’ha rielaborata ed è in grado così di mettere in scena un intero e variegato popolo con le sue vicende minute, quotidiane, semplici, a volte perfino banali.
La comunità di Mambrici subisce gli eventi, accetta disgrazie e calamità naturali come ineluttabili, vive in un tempo che sembra essersi fermato ed attende il suo riscatto non da un’azione che possa scaturire dal suo interno, bensì dall’abbandono, dalla fuga dal paese, dall’emigrazione per l’appunto. Salvo dover ritornare perché le metropoli americane, troppo tentacolari, rischiano di inghiottirti, di annullarti, di cancellare per sempre anche il passaggio della loro esistenza su questa terra.
Una ragione di vita, dolce quanto effimera, per tutti i componenti di quella comunità, nobili o plebei, borghesi, professionisti o artigiani, è il sesso vissuto dai potenti come passatempo, sollazzo e godimento e da tutti gli altri come un impulso irresistibile, che può diventare per le donne fonte di guai e di disonore, marchio d’infamia e causa di emarginazione.
Quando finalmente quel popolo si ribella, le manifestazioni di protesta assumono il carattere della classica vampata breve, violenta e disorganizzata, che deve essere repressa con virulenza tanto per dare un esempio e riallineare le lancette della Storia. Un fuoco di paglia che gli storici chiameranno “ribellismo primitivo”, che incuterà terrone ai ricchi ed ai preti, ma che non sposterà neppure di un millimetro la condizione umana di quei reietti.
La dimensione magica di cui pure il romanzo è pervaso e che, di tanto in tanto, affiora con le figure delle magare o con i santoni o con il manifestarsi di eventi naturali mal interpretati e mal compresi, è vero, come in molti hanno notato, crea delle atmosfere suggestive e tuttavia questa dimensione viene immediatamente fagocitata dalla superstizione più cupa di fronte alla quale vacillano perfino le certezze dell’uomo di scienza o dello scettico o del libero pensatore o dell’ateo socialista, quasi a voler dire: “non è vero, ma, in cuor mio, ci credo”. L’incombere del soprannaturale si manifesta attraverso “l’epifania del mostro”, ennesimo cattivo presagio che sembra annunciare per la piccola comunità, lutti e rovine, mentre nel clima positivistico di inizio secolo, appare come la conferma di teorie paludate di Scienza ed invece intrise di pregiudizi e di razzismo.
Il Narratore è un testimone esterno alla comunità, guarda a volte con occhio benevolo, spesso assume un tono critico, certo non è mai compiacente e neppure didascalico e sicuramente non commette l’errore di giudicare fatti e personaggi di un passato all’apparenza lontano ma, che sappiamo, in realtà, ci siamo lasciati alle spalle da poco tempo.
Un paese prigioniero dell’ignoranza, delle superstizioni, della miseria al quale non sono concesse né speranze né prospettive di riscatto, corre inesorabilmente verso un finale catastrofico: il terremoto.
La Natura s’incarica ancora una volta, senza odio e senza risentimento, neutrale com’è, di livellare, di sistemare e a suo modo, di riordinare lo spazio di cui gli essere umani, con poco discernimento, si erano appropriati.
Il romanzo di Sergi è costruito con un impasto linguistico fatto di lingua colta e dialetto, in un continuo gioco di scambi, di riverberi e riflessi. Sergi ha il grande merito di ri-proporre la questione della lingua da usare nella narrazione di una Calabria, per dirla sempre con Zitara, non ancora pienamente italianizzata. Noi abbiamo affidato la sopravvivenza del dialetto (lingua?) calabrese alla poesia ed ora alle canzoni c.d. “popolari” eseguite al ritmo della tarantella ed abbiamo rinunciato del tutto a ri-costruire una lingua che potesse esprimere i nostri sentimenti più profondi ed il nostro pensiero. Ci siamo acconciati a raffazzonare un dialetto italianizzato alla meglio tanto per farci comprendere dagli altri, per comunicare e per non sentirci isolati ed abbiamo accettato di buon grado lo sfottò sulla nostra pronuncia aspirata vergognandoci di parlare calabrese.
Nessuno si sogna di scherzare sul siciliano o sul sardo semmai l’aspetto caricaturale viene posto sull’intonazione, ma nei confronti della lingua si continua a registrare il massimo rispetto.
E’ sufficiente andare a controllare i manuali di Letteratura italiana al capitolo introduttivo sulle origini della lingua italiana, laddove il siciliano di Cielo d’Alcamo e di Jacopo da Lentini viene posto sullo stesso piano del toscano di Guittone d’Arezzo e Chiaro Davanzati, per rendersi conto dell’alta considerazione in cui è tenuto “il dialetto” siciliano. E’ mancata fin’ora la ricerca della forma, una ricerca che mira principalmente a riuscire, tramite il colore delle parole, il potere evocativo del linguaggio, il suono stesso della lingua a far non solo vedere quanto soprattutto a far rivivere nel lettore quello che viene narrato. E’ mancata quella ricerca che ha condotto Stefano D’Arrigo, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino ed in ultimo Andrea Camilleri ad inventare, a costruire e ad impiegare una lingua colta, difficile però fortemente espressiva e massimamente evocativa, che in maniera del tutto impropria, approssimativa e riduttiva ci ostiniamo a chiamare dialetto siciliano.
In Calabria ci ha provato Giuseppe Occhiato, con un ambizioso progetto linguistico che imprime, all’inizio, una traiettoria che conduce, inevitabilmente, ad una rotta di collisione tra il dialetto calabrese e la lingua italiana che diventa poi “scambio” e successivamente “simbiosi” in una forma linguistica nuova, creativa, arricchita, espressiva con la finalità di narrare, anzi del “saper cuntari” la storia, la realtà, la cultura, le tradizioni, gli usi, le consuetudini, i costumi e le superstizioni di una terra, quella calabrese, antica.
Sergi, dopo averci convinto delle sue capacità affabulatorie, si è assunto con questo suo primo romanzo, il compito di “logotheta” (colui che racconta e non semplicemente colui che conta nel senso di calcolare) della lingua calabrese, lingua della tradizione e delle nostre radici.
A noi spetta non solo incoraggiarlo, ma aiutarlo, sostenerlo, appoggiarlo in questo percorso all’indietro impervio e affascinante al tempo stesso. Non uno qualunque, ma uno come Pirandello quando era ancora studente a Bonn aveva notato che un siciliano e un piemontese
–…messi insieme a parlare, non faranno altro che arrotondare alla meglio i loro dialetti, lasciando a ciascuno il proprio stampo sintattico, e fiorettando qua e là questa che vuol essere la lingua italiana parlata in Italia delle reminiscenze di questo o quel libro letto.
Se si crea lo spazio, all’interno della lingua letteraria, per il dialetto, il varco che si è apre deve consentire di portare nella lingua la scorrevolezza e la vivacità del parlato, la forza dell’espressività e l’immediatezza comunicativa di parole che arrivano da un tempo lontano. La dialettalità smette di essere sinonimo di emarginazione e diventa mescolanza di codici linguistici greci, latini, arabi, spagnoli e francesi. Una mescolanza esuberante non una mistura indistinta e confusa.
Antonio Orlando
fonte
eleaml.org



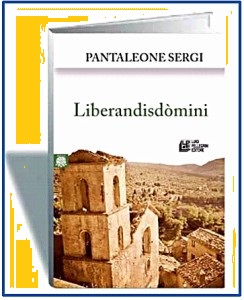
 invio in corso...
invio in corso...



