LA STORIA PROIBITA-INTRODUZIONE
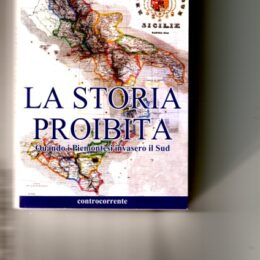
Se qualcuno, per semplice curiosità o perché spinto da più profonde e pressanti esigenze, sentisse il bisogno di spiegarsi perché – nonostante l’insistente retorica risorgimentale, che sostiene e pretende di aver compiuto un processo unitario da quasi due secoli – l’Italia sia l’unica nazione al mondo in cui parte di essa e parte dei cittadini siano discriminati e non godano degli stessi diritti riconosciuti ad altri, non deve fare altro che leggere la Prefazione del compianto Nicola Zitara al libro “ La storia proibita.
Quando i Piemontesi invasero il Sud”,[1] di un gruppo di liberi pensatori,[2] che, unendo i loro sforzi, hanno dato vita ad una pubblicazione che mostra la vera anima del Risorgimento e i veri motivi che spinsero una parte della società italiana, che versava in uno stato di bisogno, a portare guerra al Regno delle Due Sicilie, senza neanche una dichiarazione, perché mancavano le premesse, anche quelle più cavillose, per risanare la propria economia e avere la possibilità di fare una trasfusione di liquidità alle proprie casse prosciugate dalle interminabili guerre che erano il pensiero fisso di una monarchia alla continua ricerca di terre da conquistare e di popoli da sottomettere.
La libertà di pensiero del gruppo di cui sopra, non dovendo sottostare né adeguarsi ad ordini superiori o a preventivi “ imprimatur “, è stata il legante che ha veramente unito persone dagli interessi più disparati ( medici, ingegneri, avvocati, insegnanti, ecc,) riuscendo in quello in cui ha fallito il tanto decantato Risorgimento: cioè, far sentire piemontesi, liguri, lombardi, veneti e toscani veramente fratelli dei meridionali, mortificati, danneggiati, diffamati ed affamati da una proditoria invasione spacciata per liberazione, al cui confronto passano in secondo ordine i massacri e le rapine perpetrati dalle orde francesi dal 1796 al 1799.
L’invito di cui sopra non intende minimamente sminuire l’importanza del lavoro fatto dal gruppo per offrire una chiave di lettura diversa della falsa storia cominciata a raccontare agli italiani dal 1861 ad oggi. L’invito è stato rivolto solo perché quanto scritto da Zitara è così esatto, così obiettivo e così completo nella sua concisione che può ben considerarsi sufficiente per una sommaria inquadratura del momento storico ed instillare poi un desiderio di approfondimento degli aspetti, per niente nobili, che hanno costituito l’humus di un periodo della storia d’Italia, che, per amplificazione e mistificazione , non ha eguali al mondo, elementi, questi, che ci hanno fatto meritare la disistima delle rimanenti nazioni, che, non ricorrendo al mendacio, sono state capaci di costruire una storia comune che facesse sentire comprimari dell’accaduto sia i vincitori che i vinti.
Occasioni di approfondimento per chi, invogliato dalla Prefazione dello Zitara, volesse addentrarsi nelle cose da cloaca di garibaldina memoria che sono stati i motivi ispiratori del Risorgimento il libro ne offre in abbondanza. Esse sono tutte a prova di smentita e solo intelligenze asservite ed ideologicamente distorte possono negarne la fondatezza e la veridicità. Nessun aspetto della vita e dell’organizzazione sociale del Regno duosiciliano sconvolte ed annullate dalla proditoria invasione piemontese è tralasciato e vengono puntigliosamente elencati tutti i danni e tutte le più crudeli infamie che si andarono a pescare negli archivi del diavolo per annientare e far scomparire dalla scena mondiale dinastia, regno e popolo napolitano, che di lì a poco sarebbe diventato “meridionale”.
Qui si conclude il mio contributo. Passo ora alla trascrizione della Prefazione dello Zitara, che, per gentile concessione dell’editore, sono stato autorizzato a pubblicare. Buon proseguimento e buona lettura. (Castrese L. Schiano)
P R E F A Z I O N E
Come collettività nazionale, siamo considerati il paese più subdolo del mondo e, in effetti, lo siamo. Si tratta di un vizio antico, sanzionato dagli stessi italiani a cominciare dal padre Dante, ed elogiato, addirittura, da Machiavelli.
Bisogna aggiungere che la disistima degli altri popoli europei, se un tempo coinvolgeva i signori regionali, la curia romana, i soldati di ventura e il personale politico che si metteva al servizio di monarchi stranieri, toccava molto meno i meridionali.
Al Sud, l’ipocrisia politica è un malcostume acquisito per contagio, la sua prima manifestazione ha una data ben precisa, i fatti del 1799, allorché la concezione borghese della proprietà piena e assoluta si scontrò con la vitale esigenza dei contadini di tenere in vita le antiche forme di godimento promiscuo della terra.
La patriottica campagna denigratoria dell’uomo meridionale ebbe un corposo seguito al tempo della conquista del Sud. Cominciò Cesare Abba, seguirono Francesco De Sanctis e Pasquale Villari. Edmondo De Amicis e Renato Fucini vi aggiunsero un tocco di elegante scrittura, Cesare Lombroso inquadrò il tema in termini “ scientifici “.
Poi, rinsaldatosi lo Stato unitario, la cosa passò in mano agli stessi meridionali, quelli reputati più illustri, come Giovanni Verga e Benedetto Croce.
Dopo la seconda guerra mondiale, il Principe di Lampedusa e tutta un’orda di maestri della penna e della macchina da presa trovarono che era pagante l’intingere nel brodo dell’arretratezza sudica.
La corale e patriottica condanna dei sudici e acefali meridionali s’intrecciò – non proprio per caso – con la sistematica diffamazione dell’intera dinastia dei Borbone di Napoli, con calunnie confezionate nelle logge massoniche nazionali e forestiere.
La cinica ed interessata ipocrisia che insozza gli ultimi due secoli di storia nazionale italiana merita non solo d’essere demistificata, ma anche irrisa e beffata.
Nella prima metà del XIX secolo la nuova classe dei capitalisti agrari, industriali e finanziari, oltre a mal sopportare il proletariato divoratore di pane – una terribile remora all’accumulazione dei profitti – mostrava una grande avversione per quei re che si ostinavano a non cederle il potere. I re di Napoli erano fra i più coriacei, e non solo perché si consideravano degli unti del Signore, ma anche perché erano convinti che le modernizzazioni non si dovessero obbligatoriamente accompagnare alla pauperizzazione capitalistica. Ma la calunnia è un venticello …
Attraverso la stampa londinese e le missioni all’estero dei suoi leader mondiali, il partito dell’ avvento dei capitalisti al potere e della fame popolare ebbe l’abilità di caricare l’aggettivo borbonico di un segno fortemente negativo. Al buon esito della macchinazione, fece da supporto subliminale l’antagonismo tra il predace mondo anglosassone e la quieta civiltà mediterranea.
Siccome il contenuto negativo, insufflato nell’aggettivo borbonico, faceva comodo a chi governava l’Italia unita, in senso antimeridionale, le sue radici vennero rincalzate con insolita diligenza, cosicché l’ortica continua a provocare il prurito. Tuttora un’imposta particolarmente oppressiva viene definita borbonica, Una burocrazia poco funzionante viene raffigurata come borbonica. Un padrone antiquato ed esoso subisce identica censura e viene accusato di borbonismo. Ancora oggi i Borbone sono considerati la negazione di Dio, i nemici più fieri e accaniti della modernità, della civiltà, della democrazia politica, della giustizia sociale, del progresso culturale, della libertà di pensiero. Le loro carceri erano infami, e così pure la loro polizia; i loro ministri erano degli autentici carnefici; gli stessi re dei feroci buffoni. Per opposizione logica, i loro avversari godono della palma di patrioti, di persone che si prodigarono fino al martirio per la libertà del popolo meridionale e per la grandezza d’Italia; a loro viene attribuito il merito di aver salvato il Meridione, altrimenti condannato all’arretratezza, all’improduttività, all’ignoranza.
Quanto detto salvataggio sia stato proficuo, è inutile dire: la cosa è sotto gli occhi di tutti. Non si tratta, però, di una fotografia stampata su un cartoncino. La perdizione dei salvati dall’assunto naufragio non migliora minimamente, anzi ci sono dei momenti in cui peggiora fortemente. Nell’analisi dei processi sociali attraverso cui il passato è divenuto questo presente infame (e non uno diverso), c’è qualcosa che resta ancora in ombra. Si tratta della ragione politica in forza della quale un castello di bugie regge da centoquarant’anni e tuttora allunga la sua ombra maligna sulla prosa giornalistica, sulla comunicazione mediatica e persino sui testi accademici. A ben vedere, la dinastia borbonica è ormai un ricordo vecchio di un secolo e mezzo. Nelle quotidianità, le sue tracce dovrebbero essere evaporate, come quelle dei Lorena, degli Estensi, del papa-re, dell’imperatore d’Austria. Allora perché anche gli attuali mali del Sud sono da imputare ai Borbone? Se Genova viene sommersa dall’acqua e dai detriti dei torrenti, a nessuno viene in mente di chiamare in causa Carlo Alberto o la Compagnia di San Giorgio. Se a Firenze accade la stessa cosa, nessuno si mette a sciorinare le responsabilità del granduca. Non è, per caso, che le colpe dei Borbone facciano il paio con quella mancanza di voglia di lavorare o con il familismo amorale per cui noi meridionali siamo stati resi famosi in Italia?
La spiegazione c’è, ma si ha un pressante interesse a tenerla nascosta. Essa consiste nel rovesciamento delle responsabilità, nella precostituzione di un alibi a favore del vero colpevole.
Ormai vediamo una tale quantità di libri gialli che ciascuno di noi può impancarsi a Sherlock Holmes.
Garibaldi era ancora a Napoli, l’intrepido re del Regno di Sardegna non era ancora sceso attraverso le Marche e l’Abruzzo a prendere possesso della nuova conquista, che le classi proprietarie meridionali si rendevano conto d’aver commesso un errore grossolano, un atto controproducente, svendendo – immediatamente dopo la vittoria di Napoleone III sull’Austria – la dinastia borbonica e l’indipendenza del paese meridionale (qui stiamo attenti: non tanto ai Savoia, quanto alla classe dirigente piemontese).
Dal canto loro i contadini, gli artigiani, gli sbandati dell’esercito borbonico, piccoli e grandi proprietari, sacerdoti, professionisti e massari delle province insorgevano contro l’invasore, accendendo una guerra per bande.
Io non so dire se chi aveva il potere a Torino si pose veramente il problema di lasciare il Sud conquistato. A riguardo si ha solo qualche dato, per esempio un articolo di Massimo d’Azeglio, nel quale l’ex primo ministro sabaudo propone una specie di referendum pro o contro l’unità, da svolgersi fra i meridionali.
La proposta non ebbe eco presso la destra moderata, che era al governo, né tantomeno presso le varie correnti di sinistra, fortemente unitarie. Sta di fatto che, nonostante il malumore si diffondesse fra tutte le classi e nonostante la rivolta contadina andasse assumendo le dimensioni di una rivoluzione popolare, gli uomini che avevano la direzione del nuovo Stato non erano più nella condizione di tornare indietro e di restituire la libertà agli italiani del Sud. Il re, che adesso aveva contro non solo l’Austria, ma anche la Francia, non avrebbe potuto declinare a cuor leggero il trono di una potenza in fieri di dimensioni europee. Dal canto loro i comandi militari, che si prospettavano un grosso esercito e un’armata navale capace di fronteggiare sia la flotta austriaca sia, eventualmente, quella francese, sapevano che l’erario sabaudo non bastava alla bisogna. La base imponibile, passata, in meno di due anni, da cinque a ventitré milioni di contribuenti, non poteva venire revocata. L’apporto della Lombardia, della Toscana, dei Presìdi e di gran parte dello Stato della Chiesa era stato divorato in un lampo dalla voragine debitoria che le iniziative cavourriane avevano prodotto nel bilancio sabaudo. Per giunta, il nuovo Stato si rivelava più costoso di tutti gli ex Stati conquistati, messi assieme. La montagna d’argento circolante al Sud avrebbe fornito cinquecento milioni di monete metalliche, una massa imponente da destinare a riserva, su cui la banca d’emissione sarda – che in quel momento ne aveva per cento milioni – avrebbe potuto costruire un castello di moneta bancaria alto tre miliardi. Come il Diavolo, Bombrini, Bastogi e Balduino non tessevano, eppure avevano messo su bottega per vendere lana. Insomma, per i piemontesi, il saccheggio del Sud era l’unica risposta a portata di mano, per tentare di superare i guai in cui s’erano messi.
C’erano poi l’Inghilterra, contraria all’ipotesi che la Francia avesse altro spazio nel Mediterraneo, e non ultimi gli affaristi che badavano solo ad arricchirsi. Dal loro punto di vista,l’allargamento del Regno di Sardegna all’intera Italia era una manna: aveva fatto calare dal cielo, attraverso miracolosi processi, un mercato pari in ampiezza a quello britannico e a quello francese, ma tutto ancora da riempire di speculazioni. In tale clima, i progetti stradali e ferroviari saltavano fuori dai loro portafogli e da quelli dei mediatori sardi dei banchieri inglesi e francesi, come i piccioni dal cappello di un prestigiatore.
Insomma, nel quadro della politica liberista e allo stesso tempo espansionista (protezionismo dall’interno, la definì Francesco Ferrara) impostata, ed imposta, da Cavour, il paese meridionale, con i suoi nove milioni di abitanti, con il suo immenso risparmio, con le sue entrate in valuta estera, appariva una gran risorsa. Invece il Sud borbonico era pago di sé, alieno da ogni forma di espansionismo territoriale e coloniale. La sua evoluzione economica era lenta, ma sicura. Chi reggeva lo Stato era contrario alle scommesse politiche e preferiva misurare la crescita in relazione all’occupazione delle classi popolari. Nel sistema napoletano, la borghesia degli affari non era la classe egemone, a cui gli interessi generali erano ottusamente sacrificati, come nel Regno sardo, ma era una classe al servizio dell’economia nazionale.
La retorica unitaria, che copre interessi particolari, non deve trarci in inganno. Le scelte innovative adottate da Cavour, quando furono imposte all’intera Italia, si erano già rivelate fallimentari in Piemonte. A voler insistere su quella strada fu il cinismo politico di Cavour e dei suoi successori, l’uno e gli altri più uomini di banca che veri patrioti. Una modificazione di rotta sarebbe equivalsa ad un’autosconfessione. Quando, alla fine, vennero imposte anche al Sud, ebbero la funzione di un cappio al collo. Bastò qualche mese perché le articolazioni manifatturiere del paese, che non aveva bisogno di ulteriori allargamenti di mercato per ben funzionare, venissero soffocate. L’agricoltura, che alimentava il commercio estero, una volta liberata dai vincoli che i Borbone imponevano alla esportazione delle derrate di largo consumo popolare, registrò del tutto una crescita e ci vollero ben venti anni perché i governi sabaudi arrivassero a prostrarla. Da subito, lo Stato unitario fu il peggior nemico che il Sud avesse mai avuto; peggio degli angioini, degli aragonesi, degli spagnoli, degli austriaci, dei francesi, sia i rivoluzionari che gli imperiali e prima ancora che si riunisse il parlamento nazionale (marzo 1861), il paese meridionale mandava segnali ben visibili d’insofferenza.
Il Sud borbonico era un paese strutturato economicamente sulle sue dimensioni. Essendo, a quel tempo, gli scambi con l’estero facilitati dal fatto che nel settore delle produzioni mediterranee il paese meridionale era il più avanzato al mondo, saggiamente i Borbone avevano scelto di trarre tutto il profitto possibile dai doni elargiti dalla natura e di proteggere la manifattura dalla concorrenza straniera. Il consistente surplus della bilancia commerciale permetteva il finanziamento di industrie, le quali, diversamente dalla favole sabaude raccontate dagli accademici circonfusi di alloro, erano sufficientemente grandi e diffuse, sebbene ancora non perfette e incapaci di proiettarsi sul mercato internazionale, come, d’altra parte, tutta l’industria italiana del tempo (e dei successivi cento anni).
Niente di più sbagliato, dunque, che analizzare tale politica economica applicando canoni di valutazione coerenti con il liberismo, secondo la moda invalsa nelle nostre università, a cominciare da quella di Napoli. I nostrani scrittori di storia, quando affrontano il tema “ Meridione borbonico”, hanno il vezzo di lasciar intendere al lettore che la Torino del tempo non avesse niente da invidiare a Manchester e che Cavour fosse il fratello minore di lord Cobden, quando in affetti l’industria piemontese era alquanto indietro rispetto a quella napoletana e l’officina Ansaldo era finanziata da Cavour non meno di quanto lo fosse Pietrarsa da Ferdinando II (con la bella differenza, però, che questa era in condizione di realizzare prodotti che Genova ancora non si sognava).
L’approccio borbonico alla modernizzazione era un dirigismo esplicito e non un dirigismo mascherato da liberalismo, come quello cavourriano che scaricava sul groppone delle classi diseredate il costo della modernizzazione. I Borbone non intendevano bruciare le tappe, creando parrocchie di ladri e tangentisti ante litteram come faceva il cosiddetto grande ministro. Il circuito economico legava le varie realtà regionali in modo perfetto, esemplare, come mai più si vide; la capitale assolveva compiutamente la sua funzione, assicurando al paese napoletano un prestigio di rilevanza mondiale, come mai più si vide; l’erario era ricco e i segni monetari in circolazione (le famose fedi di credito) accettati con fiducia e rispetto, come mai più si vide; la banca era incredibilmente solida, cosa di cui non solo le Due Sicilie, ma l’intera Italia ha perduto persino il ricordo. Il risparmio era interamente incorporato nell’argento circolante e in quello depositato presso il Banco. Partendo da così solide basi, all’occorrenza si sarebbe potuta emettere moneta bancaria per tre miliardi, senza dar luogo ad alterazioni nel cambio, cosa che invece turbò per più di trent’anni la vita italiana.
Quella consistente ricchezza avrebbe permesso la crescita industriale del paese e il compimento delle opere stradali, ferroviarie e portuali quando, quarant’anni dopo, la navigazione a vela sarebbe stata scavalcata anche nel piccolo cabotaggio. Ma essa andò tutta a beneficio dei padani. Non si dice, forse, che l’uomo valente muore per mano del fetente? In cambio di quell’ingente esborso, il Sud ebbe un coloniale allungamento delle ferrovie padane, la cui costruzione dette patriotticamente luogo all’intrallazzo più grosso e clamoroso della storia nazionale (altro che tangentopoli) e non ebbe altro scopo che permettere un veloce spostamento dell’esercito dal Nord al Sud.
Tutto questo non al fine di difendere le coste meridionali da un eventuale attacco dei turchi, che se ne stavano buoni buoni a casa loro, ma per il caso di altre insurrezioni dei cafoni meridionali.
In verità la preoccupazione principale degli esecrati Borbone stava nell’assicurare il vitto al popolo, nel suo paese. Dall’esperienza inglese avevano appreso che la corsa sfrenata allo sviluppo industriale avrebbe provocato ciò che si ebbe effettivamente: la fame, la disoccupazione di massa, la fuga in Argentina e negli Stati Uniti di otto milioni di uomini in età di lavoro, un terzo della popolazione del Sud, quella più capace di produrre. Nella loro visione politica i processi di modernizzazione andavano regolati, la modernità sarebbe venuta un passo dopo l’altro, con una crescita equilibrata della produttività del lavoro.
E anche qui avevano ragione.
Con gli incredibili sacrifici imposti al popolo, i nostrani capitalisti furono piuttosto affaristi e speculatori che industriali. In Italia, di industria moderna e capace di proiettarsi sul mercato mondiale si può parlare solo a partire dalla Vespa, dalla Lambretta e dal frigorifero a buon prezzo, cioè dal 1950. E’ storia vera: la gestazione dell’industria padana durò novant’anni e costò il completo azzeramento del Sud.
Allorché di fronte all’avanzata di Garibaldi, Francesco II non fuggì a ripararsi fra le braccia della Austria, come avevano fatto i sovrani di Toscana e dei Ducati, ma si asserragliò a Gaeta con l’intento di sollevare i contadini, Cavour capì che l’oro inglese aveva esaurito le sue capacità corruttrici e procedette a trasformare il Sud in un campo di battaglia, in un paese soggiogato da uno Stato nemico. La tensione crebbe. La classe proprietaria stava tornando sui propri passi. Il Piemonte strinse le briglie. L’esercito d’occupazione mostrò i muscoli.
Siccome il tutto doveva essere coperto da una decente maschera (anche Napoleone III si sentiva preso per il naso), fu richiamata in servizio attivo l’ipocrisia, arte antica degli italiani. L’esercito era stanziato al Sud per reprimere il moto di qualche migliaio di selvaggi. Ne nacque, infine, una di quelle congiure politico – culturali che Pietro Giannone aveva così fieramente denunziate: si dice bianco dove è nero, si disegna un bel profilo in modo che il brutto si presenti in bella forma, si mente metodicamente, si adorna di allori la disonestà morale, si mettono in trono i ladri e si espone la onestà al pubblico ludibrio. Si chiusero gli occhi di fronte ai profittatori di regime, anzi li si celebrò come illustri e meritevoli di patrie gloria. I ministri più incompetenti ed esosi furono definiti dei salvatori della patria; i traditori del loro popolo furono chiamati eroi nazionali. E ancora oggi, fra gli effluvi dell’incenso scolastico, degli autentici banditi accompagnano il povero meridionale nel suo passaggio da ragazzo a uomo.
La storia d’Italia si regge su una menzogna sfacciata. Le colpe dei Borbone sono l’alibi rivolto a coprire le colpe delle classi dirigenti padane e, da ultimo, dell’intera “nazione nordista”. Il disastro del Sud e le responsabilità dello Stato nazionale sono entrambi incommensurabili. Un paese di venti milioni di abitanti, di cui cinque milioni inoccupati a vita, appartiene allo stesso Stato in cui, fra trentasei milioni di abitanti, tutti quelli che intendono lavorare hanno un’occupazione e un alto reddito. Non credo che al mondo ci sia stata una nazione altrettanto doppia e altrettanto ridicola. E non esiste un termine più appropriato per definire la pagliacciata.
In nessun paese al mondo il colonialismo interno è stato così duro e interminabile quanto in Italia. Esso non sarebbe stato (e non sarebbe) possibile altrimenti che rovesciando su altri la responsabilità del disastro. L’onta riversata a piene mani sui Borbone e sull’uomo meridionale non hanno altro scopo e funzione che assolvere i gruppi dominanti dalle loro storiche responsabilità.
Persino la tesi secondo cui l’unità d’Italia sarebbe nata dalla conquista regia puzza di falso lontano un miglio, questo perché la vera arma usata in quel gioco fu l’oro inglese e il tradimento dei notabili del Sud.
La verità vera è che lo Stato unitario altro non è che un’arlecchinata, un imbroglio.
Riportare a galla la verità, la storia effettiva, non è impresa facile in un ambiente in cui il falso è glorificato come patriottismo. Farla conoscere è ancora più arduo, perché la verità si scontra con una falsificazione istillata nella mente dei fanciulli insieme al catechismo.
In quest’opera di recupero, che coinvolge animi generosi e autentici patrioti, gli autori non hanno messo soltanto la passione che il lettore vede zampillare da ogni frase, ma alquanta sagacia; la sagacia di chi vuole comunicare una fede, e che pertanto scrive per farsi leggere.
Nel libro, le informazioni arrivano come le raffiche di una mitragliatrice che non s’inceppa. Bastano le prime venti pagine per stendere l’avversario.
E’ vendetta, rivalsa, giustizia sommaria? No, è la dignità di patria nata nel cuore di persone coraggiose. Ed è un’arma terribilmente efficace, in quanto arma a sua volta il cuore degli altri.
Nicola Zitara
[1] Edizioni Controcorrente, giugno 2001 = Via Carlo de Cesare,11 – Napoli (www.lanuovacontrocorrente.it – tel. 081421349)
[2] Carmine Colacino (ricercatore universitario, Potenza) – Alfonso Grasso (ingegnere navale , Genova ) – Andrea Moletta (medico analista, Milano ) – Antonio Pagano (avvocato, Vicenza ) – Giuseppe Ressa (medico, Roma ) – Alessandro Romano ( storico del brigantaggio, Latina) – Maria Russo ( insegnante, Firenze ) – Marina Salvadore ( giornalista, Milano ) – Maria Sarcinelli ( medico analista, Milano )
inviato da Lucio Castrese Schiano



 invio in corso...
invio in corso...



