LE DUE SICILIE – Normanni e Svevi

I Normanni transitano in Italia sullo scorcio del decimo secolo, in veste di pellegrini di ritorno dalla Terrasanta. Il luogo li affascina, li attrae, così decidono di porre la propria abilità militare al servizio dei signori locali, prendendo posizione nei conflitti tra Longobardi e Bizantini per la contesa del meridione della penisola.
Nel volgere di una generazione il loro contributo diventa decisivo, sino a meritare la contropartita di vaste concessioni territoriali. L’anno 1029 vede sorgere la prima contea normanna, ad Aversa, a titolo di ricompensa del duca bizantino di Napoli per il sostegno contro il principe longobardo di Capua. E’ il primo traguardo di un’interrotta serie di successi, con cui i Normanni si affermeranno tanto sui Longobardi quanto sui Bizantini.
Il fronte normanno è invero piuttosto frammentato, le sue vittorie non sono l’esito di sforzi congiunti e coordinati. Spiccano però gli Altavilla – dalla località di Hauteville, in Normandia – più di altri capaci di dar corso ai desideri di conquista, sino a puntare alla più florida terra del Mediterraneo: la Sicilia musulmana.
La spedizione prende le mosse da un’ambigua invocazione di soccorso di un signore locale, ma già dallo sbarco a Messina, nel 1061, s’intuisce la volontà normanna di sfruttare l’occasione per allargare i propri domini. Palermo sarà conquistata nel 1071 e vent’anni più tardi saranno tacitate anche le ultime sacche di resistenza, a Butera e Noto.
Siamo alle porte di un Regno con innanzi una storia plurisecolare.
Il Regno sorge come di Regno di Sicilia nella notte di Natale del 1130, a opera di Ruggero II di Altavilla, e progressivamente riunisce la Contea di Sicilia, i Ducati di Puglia e Calabria, Amalfi, Napoli e Gaeta, il Principato di Capua.
Le fonti non concordano sugli eventi prodromici alla sua nascita – se un atto d’imperio dell’ambizioso Ruggero II, desideroso di passare da Gran Conte a Re, col sostegno della classe nobiliare, o una mossa strategica in un gioco di poteri e contro-poteri ecclesiastici, alla ricerca di sponde politiche per la nomina del Papa – ma quale ne sia l’origine il Regno rimane un esempio ante litteram del moderno Stato europeo, per assetto istituzionale, estensione territoriale, peso politico e potenza militare.
I Normanni impongono un sistema feudale centralizzato, che lascia autonomie locali, ma toglie spazio al particolarismo giuridico. Il Re governa tramite i suoi funzionari – burocrati dello Stato, non potenti signorotti – nella misura in cui riesce a fondere i rapporti aristocratici feudali con l’idea di un capo non più un primus inter pares, ma autorità superiore, di emanazione “divina”. Il potere regio continua a confrontarsi con i poteri locali, ma la loro subordinazione al potere centrale e l’organizzazione verticistica e piramidale della società – un inedito, in un panorama politico dominato dalla proliferazione di centri di potere – inibiscono lo sviluppo dei movimenti comunali, che in quegli anni iniziano a diffondersi nel settentrione.
Questa forma di controllo politico e sociale – sconosciuta alle popolazioni del meridione – si modulerà nel tempo in armonia con le diverse situazioni di fatto. E’ un esempio mirabile del “genio normanno”, quella rara capacità di saper interpretare, contemperandole, le molteplici manifestazioni della realtà da governare. Il Regno prospera sulla tolleranza tra culture, la lungimiranza dei governanti, la varietà degli esponenti di corte. A quel tempo si diceva: devi andare a Roma, se vuoi imparare il latino; a Bisanzio, per il greco; a Damasco, per l’arabo; a Palermo, per imparare latino, greco e arabo tutti assieme, in una sola volta. Anche la sorte arride alla dinastia, collocandola in un’epoca di ricchezza materiale, di fluidità nei commerci e crescita economica.
Da Ruggero I, il conquistatore della Sicilia dagli Arabi, a suo figlio Ruggero II, chela rese grande, e poi ai discendenti Guglielmo I il malo, quartogenito di Ruggero II, e suo figlio Guglielmo II il buono, mecenate e uomo di cultura, la dinastia normanna segna il momento di concepimento e di gloria del Regno, racconta l’epopea di una schiera di capitani di ventura, che iniziarono l’intrapresa con la nomea di banditi, per concluderla con lo status di Re, Duchi e Principi.
La scomparsa senza eredi di Guglielmo il buono prospetta il problema della successione.
La politica indica Tancredi di Lecce – figlio illegittimo di Ruggero II, esiliato sotto Guglielmo il malo e rimpatriato con Guglielmo il buono – in un intreccio di spinte e veti: da un lato la pressione della corte normanna, per favorire l’ultimo maschio degli Altavilla, dall’altro l’insofferenza del Papato per gli Svevi, che ambiscono al Regno e vi hanno già messo un piede col matrimonio tra Enrico VI e Costanza d’Altavilla, zia di Guglielmo II.
Tancredi è un soldato di valore, coraggioso e intelligente, e prevale anche nello scontro militare. Respinge le velleità di Enrico VI, in una battaglia rocambolesca, in cui gli è amica una pestilenza che decima l’esercito avversario. Consolida poi la posizione della dinastia, le conferisce un respiro più ampio. Incorona il figlio Ruggero III, un modo affatto subliminale per blindare la successione, e ne combina il matrimonio con la figlia dell’Imperatore d’Oriente, in una logica di pacificazione con i bizantini.
In quello stesso periodo i tre più grandi Sovrani d’Occidente – l’Imperatore germanico Federico I, il Re di Francia Filippo Augusto e il Re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone – compartecipano alla Terza Crociata. Riccardo muove per via di mare, attraversa il Mediterraneo e fa scalo in Sicilia. Lo sbarco non è solo un fatto logistico. Il Re vuole manifestare il suo disappunto per la sorte della sorella Giovanna, privata dell’eredità promessa nel matrimonio con Guglielmo II, e manifestare il disappunto – all’epoca – significa invadere, devastare, saccheggiare. Solo l’intervento diplomatico di Re Filippo – anch’egli approdato sull’Isola – consente di ricomporre la situazione. L’episodio è marginale, e tuttavia rappresenta un presagio, il segno dell’imminente precipitare degli eventi.
Ruggero III muore improvvisamente, a soli 19 anni, e poco dopo viene meno anche Tancredi, in una spedizione nella parte peninsulare del Regno, per ridurre all’obbedienza i vassalli di fede imperiale. Sul trono sale formalmente Guglielmo III, un bambino di 9 anni, sotto la reggenza della madre Sibilla di Medania. L’epoca degli Altavilla è alla fine, il sipario aperto nel 1130 inizia a chiudersi nel 1194.
Enrico VI non scorge ora più ostacoli, non ha più nemici a tenergli testa, e un inaspettato strascico della Terza Crociata gli fornisce pure le risorse per l’intervento militare. Riccardo Cuor di Leone, sulla via di ritorno, attraversa le terre del Duca d’Austria, pubblicamente sbeffeggiato durante la spedizione. Il Re inglese è riconosciuto, arrestato e consegnato proprio a Enrico, neo Imperatore di Germania, che reclama un colossale riscatto, pagato dalla Regina consorte e subito impiegato per finanziarie la discesa nel Regno.
Tancredi non c’è più, Guglielmo III è solo un bambino, i baroni normanni, scoraggiati, si sottomettono. Enrico VI è incoronato il giorno di Natale, il 25 dicembre 1194, e sarà proprio il piccolo Guglielmo a depositare simbolicamente la corona ai piedi dell’Imperatore, in segno di rinuncia solenne a ogni possibile rivendicazione.
La moglie Costanza è intanto in viaggio verso la Sicilia e mette al mondo l’erede il giorno dopo l’incoronazione. Più il folklore e le pittoresche tradizioni postume, che non le fonti coeve, raccontano di un parto avvenuto sulla pubblica piazza di Jesi, per fugare le dicerie sull’effettivo stato di gravidanza della Regina, suscitate da un’età anagrafica – 40 anni – all’epoca inusuale per una maternità. Tutti devono assistere alla nascita del futuro Re, nessuno può covare sospetti sulla sua origine regale, sul suo diritto al trono. Il neonato passerà alla storia come Federico II, ma è battezzato Federico Ruggero, in omaggio a Federico Barbarossa di Hohenstaufen, da un lato, e a Ruggero II d’Altavilla dall’altro, per contemperare le tradizioni sveva e normanna. Costanza lo affida alla duchessa di Spoleto, e prosegue il suo viaggio verso la Sicilia, più per vigilare sulle maestranze tedesche, che per amore del marito.
E’ iniziata la dinastia sveva, in un clima inquieto, di repressioni sanguinose e esecuzioni di massa. Enrico VI vede nemici ovunque, tra i vivi e i morti, tra i forti e i deboli. Profana le spoglie di Tancredi e di suo figlio Ruggero. Spedisce il piccolo Guglielmo in Germania, non prima di averlo mutilato, per eliminare il rischio residuo di future pretese, non pago dell’umiliazione inflittagli nel cerimoniale dell’incoronazione. Attua una spoliazione dei baroni normanni – cui aveva lasciato intravedere la possibilità di un atto di clemenza – a vantaggio dei suoi favoriti. Risponde a ogni protesa con repressioni sproporzionate, spesso inutili. Dubita persino della moglie Costanza, la obbliga ad assistere alle torture inflitte a chi, devoto alla Regina, aveva complottato contro il Re, per poi confinarla nel Palazzo Reale di Palermo, sotto stretta sorveglianza. Al grande potere di Enrico VI non corrisponde dunque la coesione e l’armonia dei popoli su cui lo esercita, e soltanto la sua improvvisa dipartita restituisce al Regno una parvenza di normalità.
Le ultime volontà di Enrico consegnano la Sicilia al Papa, ma il testamento è occultato da Marcovaldo di Anweiler, siniscalco, amministratore e vassallo delle regioni prossime a esser cedute, in accordo con altri nobili tedeschi intenzionati a perpetuare il governo del Regno in nome dell’Impero. Le trame di potere si sfaldano però davanti a un’arguzia e a una risolutezza tutta al femminile. Costanza è la protagonista di una fase breve, intensa e decisiva. Trasferisce il piccolo Federico a Palermo, proclamandolo Re, ancora infante, nella pentecoste del 1198. Riporta in auge la Sicilia normanna e procede contro i tedeschi, ormai libera dal vincolo del matrimonio svevo. Accetta il vassallaggio verso il Papa – rifiutato da Enrico – per ricevere la protezione ufficiale della Chiesa, per farne spada e usbergo del figlio Federico. Morirà poco dopo, consegnando alla storia una vita costellata di leggende e imprese poderose. “Quest’è la luce de la gran Costanza” – scriverà Dante nel “Paradiso” (III, 118-120) -“che del secondo vento di Soave, generò il terzo e l’ultima possanza“.
Costanza è riuscita a districarsi nel labirinto di un corte infida, a portare in salvo il piccolo erede. La sua breve reggenza ha condotto alla restaurazione e al rafforzamento dell’influenza papale sul Regno, dopo un periodo di temporaneo affrancamento, una scelta imposta dall’incalzare degli eventi, ma risolutiva per assicurare il futuro dominio del figlio.
Federico II ha perciò un debito immenso verso il Papa e il suo governo sarà marcato da una continua rottura e ricomposizione dei delicati equilibri con lo Stato della Chiesa, in un confuso inseguirsi e sovrapporsi di reciproci vantaggi materiali e obblighi morali.
Federico ha in sé le peculiarità dell’una e dell’altra discendenza, la durezza e l’alterigia dei tedeschi, lo spirito audace e avventuroso dei normanni. E’ venuto su con un’educazione cavalleresca, esposto e recettivo a tutti gli stimoli dell’ambiente cosmopolita della metropoli siciliana. Il suo atteggiamento aperto mal si concilia con lo spirito reazionario della Chiesa e fatica a raccogliere consensi anche nell’emergente mondo borghese. Ma Federico preserverà sempre la piena consapevolezza delle potenzialità del suo Regno e mostrerà una lungimiranza politica capace di oltrepassa i grandi contrasti come i piccoli interessi.
Il Re svevo rafforza il ruolo dello Stato centralizzatore, teocratico e autocratico, culturalmente distante dalle monarchie feudali, animato da finalità culturali idealistiche, libere dalla subordinazione al potere ecclesiastico. Emana la Constitutiones Augustales – il codice legislativo del Regno di Sicilia, giudicato ancor oggi una pietra miliare della storia del diritto – con cui accentra i poteri legislativo, giudiziario e esecutivo, esercitati in prima persona o per mezzo di uomini di legge di sua fiducia. Abolisce con una sola legge – la De Regnantis Privilegis – il complesso delle rendite di posizione cristallizzate negli ultimi trent’anni. . Edifica diversi castelli, l’Ursino a Catania e il Maniace a Siracusa, ma anche ad Augusta e Salemi, e poi le Torri di Enna e la Colombaia di Trapani. Dimostra una spiccata sensibilità verso la “cosa pubblica”, con la formazione di un’adeguata classe di funzionari, l’istituzione di un’università a Napoli e il sostegno della Scuola Medica Salernitana, la più rinomata struttura sanitaria del Medioevo. Promuove la città di Palermo a crocevia culturale di attività scientifiche, artistiche e sociali.
La morte di Federico, sul finire del 1250, segna inevitabilmente un punto di svolta.
Il testimone passa sul momento a Manfredi di Sicilia, in attesa della consegna all’erede legittimo, Corrado IV, in quel frangente impegnato in Germania per farsi riconoscere il titolo d’Imperatore. Nel Regno si sono intanto riaccesi dissapori e malcontenti, anche per l’azione fomentatrice del Papato. Corrado arriva in Italia nel 1252 e con Manfredi promuove un processo di pacificazione, non senza reciproci sospetti, che inducono Manfredi a rinunciare ai feudi minori e all’autorità sul Principato di Taranto, conferitogli da Federico II.
Corrado muore nel 1254. Vi succede il figlio Corradino, nominalmente sotto l’alta tutela papale, ma nei fatti dello zio Manfredi. E’ un periodo di ripetuti conflitti col Papato – sia ideologici che materiali, a colpi di scomuniche e battaglie sul campo – vuoi per la riluttanza di Manfredi ad assecondare i desiderata della Chiesa, vuoi per la storica insofferenza della Chiesa verso la dominazione sveva, per quella tenaglia geografica in cui si vede stretta, per la costante minaccia dell’unificazione delle corone. Manfredi ne esce invariabilmente vincitore. Con un colpo di mano, incurante dei diritti del nipote, sale al trono il 10 agosto 1258 e negli anni successivi consolida il suo potere, pur sotto le incessanti scomuniche che ne contestano la legittimità, e la violenta campagna diffamatoria della pubblicista guelfa.
Il Papato cambia registro. Chiama i Francesi in Italia, in una vera e propria crociata contro gli Svevi, giustificata da una fantomatica combutta con i saraceni, e spalleggiata da una nobiltà locale desiderosa di riappropriarsi dei propri privilegi.
Papa Urbano IV offre la Corona a Carlo I d’Angiò – dopo esser andati a vuoto i tentativi di coinvolgere Riccardo di Cornovaglia, di discendenza normanna, e suo nipote Edmondo di Lancaster – e la stessa linea è sostenuta dal suo successore Clemente IV. Carlo è il fratello giovane di Luigi IX, ne ha ricevuto il Maine e l’Angiò, da cui il nome di Angioini assegnato alla dinastia. I suoi appetiti lo hanno portato rapidamente nello spazio del Mediterraneo. E’ il Signore della Provenza e di Forcalquier, e da quella posizione si ritaglia il dominio di Asti, una posizione favorevole per prender le parti della Santa Sede nel conflitto con la Casa Imperiale di Svevia.
Gli accordi tra il Papato e gli Angioini muovono da una visione del Regno alla stregua di un feudo della Santa Sede. Carlo accetta di limitare le sue mire di conquista, s’impegna a non brigare per la Corona Imperiale, accetta la corresponsione di un tributo al Papa, pari a un multiplo di quello stabilito per gli Svevi.
L’esercito francese prevale sulle milizie di Manfredi, che pure oppone una fiera resistenza, con al fianco i soldati siciliani e teutonici, ma tradito dai nobili italiani. Morirà prima di arrendersi – preferirà combattere con coraggio, esaurire tutto il suo immenso valore piuttosto che consegnarsi – e i suoi stessi nemici non potranno che omaggiarlo, lasciando un sasso ciascuno sul tumulo scavato nel terreno su cui ha abbandonato la vita. Il tributo militare avrà il suo contrappeso nella vendetta ecclesiastica, la violazione della tomba da parte dell’arcivescovo di Cosenza Bartolomeo Pignatelli, con l’assenso del Papa Clemente IV. Dante ricostruirà con la sua arte l’intero evento e il personaggio, nel Canto III del “Purgatorio”.

Popolo dell’Alto Medioevo dell’Europa settentrionale, Svezia, Danimarca e Norvegia, migrato a ondate successive, per portarsi in Francia, in Inghilterra e nell’Italia meridionale.

Antico popolo germanico di origini plurime:
“i Suebi non costituiscono un unico popolo”
– scrive Publio Cornelio Tacito –
“occupano infatti la maggior parte della Germania, per di più distinti in tribù con nomi diversi, pur chiamandosi, nel loro complesso, Svevi”.

Cristo impugna il rotolo della Legge, che Ruggero incarnerà per trasmetterla al suo popolo.
La regalità normanna aspirava a una legittimazione divina, poneva il Re su un piano trascendente,
ne faceva un “imitatore di Cristo in Terra”, come evocato dalla somiglianza tra i due volti.
La cerimonia d’incoronazione è peraltro intrisa di elementi arabi e bizantini:
il Re ascolta la litania dei Santi, sdraiato a terra, con le braccia a croce, per poi giurare fedeltà alla Chiesa, ricevere la sacra unzione e le insegne del potere.
Cammina con corona, spada, scettro e globo sotto un ombrello donato dal Califfo d’Egitto, che simboleggia il suo dominio sui sudditi musulmani.
Il fasto dell’evento è nelle parole dell’abate di S. Salvatore di Telese:
“fu tale la pompa che parve che tutte le magnificenze del mondo si fossero riunite a Palermo.
Le sale della reggia erano ricoperte di preziose tappezzerie, i pavimenti di tappeti di squisita fattura.
Il nuove re uscì preceduto da tutti i baroni e cavalieri del regno che incedevano a coppie, montati su cavalli di finimenti d’oro e d’argento; seguivano il monarca, i più autorevoli personaggi
anch’essi riccamente vestiti, e su cavalli magnificamente bardati.
Giunto al duomo, Ruggero fu consacrato dagli arcivescovi di Benevento, di Capua, di Salerno e di Palermo
e ricevette la corona dalle mani del principe di Capua.
Alla cerimonia seguirono sontuosi banchetti in cui non fu usato altro vasellame che d’oro e d’argento.
Gli scalchi, i paggi, i donzelli e perfino i valletti che servivano le mense erano vestiti di tuniche di seta”.
E’ un’esibizione sfarzosa, che meraviglia e intimorisce, con una valenza politica per suscitare emozioni che coagulino il consenso.

in seta rossa, ricamato con fili d’oro, smalto e perle, 146 centimetri di altezza, con una apertura di 345 centimetri di diametro.
La palma al centro rappresenta l’albero della vita e divide in due il mantello.
Su ogni lato sono simmetricamente raffigurati due leoni che sovrastano due cammelli, a rappresentare la supremazia normanna sugli arabi.
Una scritta sull’orlo innalza lodi al Re, alla Regina e alla fiorente officina reale, “dove hanno sede fortuna, gloria, agiatezza, perfezione, merito e onore”.
Nella ricercatezza del mantello riecheggia la poliedrica figura di Ruggero II: condottiero, statista, fondatore di un Regno, sovrano crudele e illuminato, eccezionale politico, legislatore, poliglotta, protettore di del sapere, costruttore di cattedrali.

Guglielmo I (1154-1166)
Guglielmo II (1166-1189)
Tancredi (1189-1194)
Guglielmo III (1194-1194)

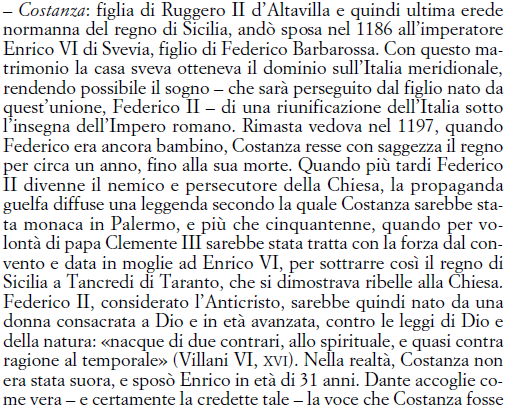
Intorno a Costanza d’Altavilla girano tante favole, molte raccontate da Tommaso Fazzello, nella sua “Le Due Deche dell’Historia di Sicilia”.
Tante favole, sì, ma anche molti fatti reali e tanti altri sul crinale dell’immaginazione.
E’ prigioniera nientemeno che di suo nipote Tancredi, durante la battaglia con Enrico VI, per farne un mezzo di scambio in vista di una possibile tregua.
Tancredi accetta di consegnarla a Papa Celestino III, che si è proposto come mediatore, ma gli Svevi attaccano il convoglio normanno nel suo viaggio verso Roma e la liberano, cosicché Tancredi perde il suo prezioso ostaggio e con esso la prospettiva di un armistizio.
Costanza aleggia anche introno alla morte improvvisa di Enrico VI: una febbre maligna, il riacutizzarsi di un’infezione intestinale o forse… un avvelenamento, proprio per mano della Regina, stanca dei soprusi del marito.
Costanza promana però un fascino che va oltre le leggende e le avventure.
E’ solo “zia Costanza”, una figura noiosa e sfocata, un ramo secco della dinastia, agli occhi e nel giudizio della variegata platea di pretendenti al Regno.
Dietro quella pallida zitella c’è però la “gran Costanza”, che abbagliò Dante in Paradiso, nel primo cielo della Luna.
Gran Costanza, a iniziare dalla tempra fisica: perché in un’epoca di epidemie, d’igiene precaria e virus mortali, la “banale” resistenza fisica val più d’ogni altra qualità. Costanza sopravvive a fratelli e nipoti, li vede scendere nella tomba uno dopo l’altro, tutti quei bei maschi della dinastia li vede trasformarsi in cibo per i vermi. Costanza sopravvive e sviluppa sottili doti intellettuali e ferrei valori morali: la capacità di afferrare l’essenza di un problema, il pragmatismo nel risolverlo, il rigirare le situazioni a proprio vantaggio, il dono di presentarsi al meglio e persuadere.
Costanza non è solo un erede: è un personaggio, una fusione di mondi, è l’anello di congiunzione tra Normanni e Svevi.

che avrà giocoforza un ruolo centrale nel cammino di vita del piccolo svevo.
Nel 1208 lo dichiara maggiorenne, nel 1209 ne combina il matrimonio con Costanza d’Aragona, che gli porta in dote un contingente di cinquecento cavalieri, oltre a vivacizzare la corte di Palermo.
Ma il destino di Federico è pilotato da eventi di più grande portata.
La morte di Enrico VI ha riaperto la partita tra i guelfi e i ghibellini, tra la casata di Baviera di Ottone Brunswick e la dinastia Sveva.
Ottone è eletto Re di Germania e dei Romani dai Principi guelfi del basso Reno, con l’appoggio della Corona inglese di Giovanni Senzaterra, in opposizione a Filippo di Svevia di parte ghibellina, fratello di Enrico VI, sostenuto dalla Francia di Filippo II d’Augusto.
Papa Innocenzo III lo riconosce, avendo la conferma degli impegni a favore dei domini pontifici.
Ma la promessa è disattesa: il nuovo Imperatore rivendica una serie di diritti in Italia,
e addirittura la Corona di Sicilia e alcuni possedimenti della stessa Chiesa.
La scomunica, nel 1210, e poi la deposizione, nel 1211, sono inevitabili.
Il Papa gli contrappone proprio Federico, incoronandolo Re di Germania nel 1212,
e la reazione di Ottone è frustrata nella Battaglia di Bouvines, nel 1214.
Federico ne prende il posto, subordinatamente a una serie di obblighi verso il Papato:
tenere divise le due Corone, Imperiale e di Sicilia, riconoscere la Sicilia come feudo dello Stato della Chiesa,
promuovere una Crociata anti-islamica e anti-bizantina.
L’impegno nelle Crociate era stata una costante, nella dinastia sveva.
Federico Barbarossa era morto nel corso di una di queste Campagne,
ed Enrico VI era deceduto prima di cimentarsi in progetto che aveva pianificato con cura.
Gli esempi del nonno e del padre sono un ammonimento per Federico, che lo vive però come una promessa personale rivolta a Papa Innocenzo, e non come un impegno istituzionale di un Regno verso un altro Stato.
Ritiene perciò di potersene esimere, di non avere più obblighi, quando Innocenzo muore.
Il successore Gregorio IX è ovviamente di ben altro avviso e pone a Federico un aut-aut: organizzare la Crociata o subire la scomunica.
Federico parte, non avendo di fatto alternative.
Giunto in Asia Minore, tuttavia, anziché combattere, negozia col Sultano la restituzione di
Gerusalemme ai cristiani.
La singolarità della mossa diplomatica non è affatto gradita dal Papato,
che ha gioco facile nell’emanare la scomunica, accusando Federico di combutta con i saraceni.
E alla scomunica segue inevitabilmente l’azione bellica, l’invasione di una parte del Regno di Sicilia.
Il ritorno di Federico, dopo otto anni, ripristina la normalità, se pur a prezzo di azioni cruente, e anche il Papato è ridotto all’obbedienza, con la Pace di San Germano, nel 1230.
Il traumatico Concilio di Lione, convocato da Papa Innocenzo IV nel 1245,
riconfermerà la scomunica e scioglierà i i sudditi dal giuramento di fedeltà.
Ne approfitterà la fazione tedesca anti-sveva, per togliere ogni appoggio all’Imperatore.
Attaccato più volte con successo dai guelfi italiani, e abbandonato dai feudatari tedeschi,
Federico sarà definitivamente sconfitto a Fossalta, presso Modena, nel 1249.
Morirà l’anno dopo, la notte del 13 dicembre 1250, nel castello di Fiorentino di Puglia, assistito dall’arcivescovo di Palermo, lasciando attorno a sé un aura di mistero e leggenda,
di esecrazione e venerazione, di odio e compianto.

una delle figure più esaltate nella storia del Regno.
Degno discendente dei grandi Re normanni, precursore del Rinascimento e dell’assolutismo illuminato, un mattatore capace di imporsi ai contemporanei, di diventare un’icona nei secoli successivi.
“Nella monarchia di Federico noi ravvisiamo un modello di reggimento politico che, primo in Europa, fece sentire i benefici frutti derivanti da una forte potestà statale associata al senso vivo d’una più alta giustizia sociale”
– scrive lo storico Ernesto Pontieri –
“Cotesto modello, creazione in terra nostra, è rimasto, attraverso i tempi,
la più schietta caratteristica del popolo meridionale”.

Manfredi è tra i contumaci dell’Antipurgatorio, tra gli scomunicati.
“Biondo era e bello e di gentile aspetto”, evocando Re Davide nell’Antico Testamento,
“ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso”, ha cioè il volto deturpato da un taglio.
Chiede a Dante se lo riconosce, con l’orgoglio proprio di un’anima ancora impura, e alla risposta negativa gli mostra una piaga sul petto, la ferita mortale in battaglia, presentandosi come Manfredi, figlio di Federico II e nipote dell’Imperatrice Costanza d’Altavilla.
Confessa le sue colpe – “orribil furon li peccati miei” – e parla delle sue scomuniche, ma mostra anche il suo sincero pentimento, in punto di morte, nella Battaglia di Benevento.
“Poscia ch’io ebbi rotta la persona, di due punte mortali,
io mi rendei, piangendo, a quei che volentier perdona”.
Il Signore Iddio alleviò le pene della sua anima, “bontà infinita ha sì gran braccia, che prende ciò che si rivolge a lei”,
non così il Papato, giacché il Vescovo di Cosenza ne fece
dissotterrare le ossa, che “or le bagna la pioggia e move il vento”.
Morire da scomunicati, anche se pentiti, obbliga a sostare nell’Antipurgatorio, “per ognun tempo ch’elli è stato, trenta, in sua presunzion”, cioè trenta volte tanto il tempo trascorso in contumacia, a meno che i vivi non abbrevino l’attesa con le loro
preghiere.
Manfredi chiede così a Dante di riferire alla figlia Costanza della sua sosta in Purgatorio, semmai ella lo creda tra i dannati, per l’atteggiamento avuto in vita verso la Chiesa.
La poesia dantesca ricostruisce quanto la storia non ha raccontato,
contrappone la bassezza degli odi umani all’infinita misericordia divina: che segue vie imperscrutabili e concede la salvezza anche a personaggi “scandalosi”, purché sinceramente pentiti, anche se solo in fin di vita.
Siamo al crepuscolo degli Svevi, la dominazione sorta nel 1194 e tramontata nel 1266.

Federico II (1198-1250)
Corrado I (1250-1254)
Corrado II (1254-1258)
Manfredi (1258-1266, reggente dal 1250)
continua…………..
fonte
https://tesoridicarta.blogspot.com/2019/03/le-due-sicilie-normanni-e-svevi.html




 invio in corso...
invio in corso...



