«QUANDO NAPOLI ERA CAPITALE» di GIUSEPPE PIANELLI (IV)
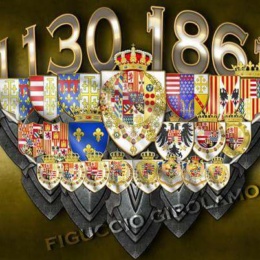
La dinastia Angioina
Chi dovesse essere il successore nel Regno non era chiaro, tanto più che, tendenziosamente, si accavallavano notizie di morti e di rinunzie, come nel caso del primogenito di Federico, Corrado I, e poi del nipote Corrado II, che vivevano in Germania. Su tutto mestava l’illegittimo ambizioso Manfredi che da Taranto, intanto, faceva il re in tutto e per tutto. I partiti dell’uno e dell’altro pretendente si combattevano a vicenda e gli avversari di tutti quanti, a loro volta, ingrossavano la confusione.
A fermare l’anarchia nel Regno, che non dimentichiamolo, era suo vassallo, provvide il Papa in persona, Urbano IV che, ormai diffidente di «quella razza di vipere» degli Svevi troppo impicciati con le mire imperiali, si mise a cercare in giro per l’Europa una nuova dinastia capace di governare in pace il Regno del Sud.
Fra i candidati possibili v’era il Re d’Inghilterra Riccardo «Cuor di leone» e qualche altro rampollo di illustri dinastie straniere. Ma la scelta cadde su quella più fedele alla Santa Sede, sui re «cristianissimi», i «re taumaturghi» che avevano il potere di guarire dalla scrofola i loro sudditi con il tocco delle mani, sui re cui era concesso il potere e la dignità dei vescovi e il cui attuale capo, Luigi IX, già godeva fama di santo: i re della «nazione primogenita della Chiesa», la Francia16.
Il «Campione del Papa» da contrapporre a Manfredi fu dunque il fratello minore del Re di Francia, Carlo, Conte d’Anjou e di Provenza. Il suo valore era indubbio: con imprese oculate aveva rafforzato i confini orientali del regno di Francia e assoggettato molti signori borgognoni, savoiardi e piemontesi. Di ritorno dalla Crociata, dove si era comportato valorosamente, nel 1253, il Papa offrì a lui la corona di Sicilia che Carlo accettò solo nel 1263, dopo essersi preparato un vasto apparato di alleanze e di finanziamenti. La cinse poi, solennemente, in San Pietro, nel giorno dell’Epifania del 1269.
Certo, Manfredi, quella corona non era disposto a cederla con buona grazia e, dopo aver inutilmente trattato col Papa e con gli altri pretendenti, armato un esercito cercò di precedere il candidato sovrano che ora si accingeva a marciare con i suoi cavalieri e con i suoi alleati verso Napoli. Con il re deposto si schierarono i suoi fedeli mentre l’armata di Carlo si ingrossava per l’accorrere degli avversari degli Svevi che anche nel Regno non eran pochi. Vinse Carlo e Manfredi lasciò la vita combattendo valorosamente presso Bene vento.
Carlo d’Angiò rappresentava non solo un nuovo re ma il simbolo di tutti coloro che volevano il Papa arbitro imparziale delle sorti d’Europa: i Guelfi. Gli Svevi superstiti rappresentavano, per i Ghibellini, un impero che non doveva rispondere a nessuno del suo potere. La lotta che si svolse finché Carlo d’Angiò non sedette sul suo trono, non coinvolse quindi solo le sue truppe e quelle avversarie per il dominio del Sud d’Italia ma scatenò in tutto il continente, e soprattutto in Italia, un rinnovato turbinio di odi e di battaglie.
Carlo d’Angiò vinse su tutti i fronti e, nel giro di pochi anni fece dimenticare al suo Regno la passata dinastia. Non è affatto vero, come s’è sempre detto, che provvide crudelmente ad estinguerla, giustiziando proditoriamente Corradino, ultimo discendente. Questi, mandato allo sbaraglio dai ghibellini, avrebbe dovuto usurpare una corona legittimamente assegnata. La casa sveva continuava ancora nei tre figli di Manfredi che morirono prigionieri proprio in quel Castel del Monte che doveva simboleggiare la gloria della dinastia. E naturalmente, come usava per le stirpi reali, e come era già stato per il figlio di Federico Enzo ostaggio a Bologna, si deve supporre che furon prigionieri con tutti gli onori ed ogni riverenza17.
Carlo, insediatosi con la sua corte a Napoli, rimise ordine nell’amministrazione dello stato e nell’anarchia dei baroni allo sbando durante il tramonto della dominazione sveva. Intraprese grandi lavori pubblici e cercò di rinsanguare le finanze esauste dalle imprese di Federico e dalle lotte di transizione. Il compito non era facile e contava molto sulla politica di espansione della Cristianità verso Oriente a cui egli si accinse. Ma, mentre il suo potere s’estendeva verso l’Albania, i Balcani e l’Ungheria, della quale il nipote sarebbe diventato Re, non altrettanto s’assestava l’economia pressata anche dai debiti che aveva contratto, per la conquista, con i banchieri toscani e con i potentati economici dell’Italia settentrionale.
Nonostante i sacrifici imposti ai sudditi, Carlo rimaneva l’amato simbolo del potere spirituale del Papa. Notoria era la sua pietà cristiana: la sua corte, austera e religiosissima, a differenza di quella sveva, viveva circondandosi di santi prelati e monaci, trasformata quasi in un monastero. Le vedove regali invariabilmente si rinchiusero tutte nei cenobi delle Clarisse. Lo stesso abbigliamento degli angioini, che vestirono, anche sull’armatura, sempre il saio dei Frati Minori e che, secondo l’usanza di San Francesco, e a differenza dei romanizzanti re palermitani, portarono sempre la barba lunga, mostrava il loro indefettibile guelfismo18.
Protettori degli ordini mendicanti quanto i predecessori lo erano stati di quelli monastici, i re angioini favorirono in ogni modo l’insediamento di conventi domenicani e francescani e la fondazione delle loro chiese in tutto il regno, a cominciare, a Napoli, da quelle di San Domenico Maggiore e di Santa Chiara nella quale vollero anche essere sepolti.
Ma se la Germania, patria di ogni ghibellinismo, era il punto d’attrazione della precedente dinastia, la Francia, patria d’ogni guelfismo, era il naturale polo degli Angioini. Di lì tutto complottava perché vi facesse capo il Papato. E del resto i disegni dei gallicani si sarebbero avverati sciaguratamente non molto più tardi portando il capo della Cristianità ad Avignone.
Intanto, la corte angioina di Napoli diventava residenza preferita dei papi e lo stesso Celestino V non vide le folle devote di fedeli del suo effimero pontificato se non dalle finestre del castello che si affacciava sul golfo partenopeo.
Su Carlo, passato ingiustamente alla storia per sovrano avido e crudele, come volevano i ghibellini, si addensarono tutte le sfortune. La più grande quella della secessione della Sicilia che, mortificata dalla perdita della sua centralità, sobillata dai baroni in cerca di potere, indocile all’austera politica fiscale della Corona, si ribellò, nei famosi «Vespri», allo scettro del Re, e si sottomise a Pietro d’Aragona separandosi dal resto del Sud.
Sicilia e Napoli, due regni divisi per sempre
I diritti di Pietro, III re di Aragona, I di Sicilia, poggiavano, un po’ traballando, sul fatto che costui aveva sposato la figlia di Manfredi, Costanza. Tanto bastava per pretenderne l’eredità nel momento che i siciliani glie ne davano l’occasione. Ma anche gli aragonesi erano vassalli del Papa e contendere con Carlo significava insolentire l’autorità paterna.
La questione non era di facile soluzione pur se il diritto dava ragione a Carlo d’Angiò che però tentò invano di riconquistare l’isola con le armi. Ci provarono anche i suoi discendenti, e sempre disastrosamente. Finalmente, a sedare la contesa intervenne lo stesso papa che, più per amor di pace che salomonicamente, confermò Carlo nel titolo di Re di Sicilia, com’era sempre stato, e riconobbe le pretese degli aragonesi concedendo loro, per il momento, la corona di un inedito «Regno di Trinacria».
Estintasi la dinastia angioina, dopo il grande e saggio Roberto, fra gli sfortunati discendenti del ramo durazzesco e le deboli Giovanne infelici e sentimentali, nessuno dei successivi pretendenti francesi pensò più a quell’isola ribelle e a quel nome che aveva designato tutta l’Italia meridionale. Già prima si parlava di due Sicilie, una «di là» ed una «di qua del faro», dopo si parlò solo e sempre di un Regno di Sicilia e di un Regno di Napoli. Fu quest’ultimo a primeggiare e ad essere oggetto di contesa fra le grandi potenze.
Più tardi, quando sia l’uno che l’altro regno finirono entrambi al re d’Aragona, Ferdinando I «il Magnanimo», questi continuò a tenere le corone divise e solo quella di Napoli toccò al suo figlio bastardo Alfonso. Ancora una volta, tornate le due corone sulla stessa testa, quella di Ferdinando «il Cattolico», nel 1503, che accumulava, con quella d’Aragona, sia pure “a tempo”, anche quella di Castiglia ereditata da Isabella insieme a quelle di tutti gli altri regni liberati della penisola iberica, nemmeno quando questi furono tutti unificati nel nome di Spagna (1512) si decise a ricomporre l’antico Regno di Sicilia com’era nato in quella notte di Natale del 1130.
Una decisione sommamente prudente giacché, ormai, quei due tronconi d’Italia erano molto più distanti, culturalmente, per temperamento, per usi, costumi e destini, di quanto lo fossero le sponde del faro di Scilla da quelle di Cariddi.
E, precedendo quel XIX secolo, di cui a suo tempo diremo, possiamo affermare già da ora che altrettanto prudente non fu Ferdinando IV di Borbone che riunificò la Sicilia con Napoli diventando I Re delle Due Sicilie. Parve, a quel sovrano restaurato dal Congresso di Vienna, che le castagne bollenti fossero già state levate dal fuoco dai napoleonidi.
Giuseppe fratello di Napoleone e Gioacchino cognato infatti avevano già fatto proprio quell’antico nome, «delle Due Sicilie», per dieci anni, vantandosi già padroni di tutto. Sui loro stemmi e sulle loro bandiere, con le provincie del Napoletano avevano posto già la caparra dell’aquilotto imperiale sulla Triquetra siciliana (le tre gambe che camminano in cerchio facendo perno su una testa di Medusa). Non riuscirono invece ad impossessarsene mai e l’Europa, umiliata da Napoleone, si vendicò levando ai suoi luogotenenti anche il ricordo di ciò di cui s’erano illegittimamente appropriati.
Ferdinando e i suoi successori, poiché dovettero sempre vedersela con l’infida e ribelle Sicilia, e poiché proprio quella parte inquieta del regno fu una delle ferite che suppurando cooperò non poco alla grande infezione che portò alla sua dissoluzione: i Borbone su quelle castagne si scottarono le mani.
fonte
https://www.eleaml.org/sud/storia/storia_del_sud_vista_dal_sud.html#NATO
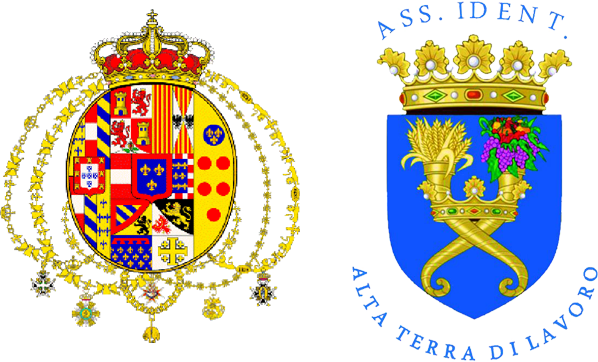


 invio in corso...
invio in corso...



