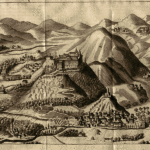«QUANDO NAPOLI ERA CAPITALE» di GIUSEPPE PIANELLI (XVI)

I “lazzari” da popolo a plebaglia
Il Re, dicevano francesi e giacobini, s’è alleato cogli scomunicati e gli infedeli. Turchi e russi, in effetti, erano uno sparuto gruppetto ma al popolo napoletano, che i rivoluzionari volevano prendere dalla parte della fede, la cosa (dimenticando che, ai meridionali, la tolleranza non glie la può insegnare nessuno) non faceva né caldo né freddo: «pe ‘ Tata nuosto», come dicevano chiamando il Re Papà, erano pronti a far patti anche con Belzebù.
Il ché è proprio un modo di dire, perché, piaccia o non piaccia ai sociologi progressisti, ai napoletani (e a tutti i meridionali) tutto gli puoi toccare fuorché quel che riguarda l’anima loro. Un meridionale ad un settentrionale che gli ripeteva, sull’onda del libro di Carlo Levi, che «Cristo s’è fermato a Eboli», rispondeva serafico d’essere pienamente d’accordo ma che Cristo, in quel caso, sicuramente, veniva da Reggio Calabria. Ancora per anni, dopo la vittoria della Santa Fede, i “pazziarielle”, con corteo di suonatori di tamburielli, tricchebballacche, putipù, scetavajasse e caccavelle, cantavano, fra nugoli di popolo plaudente e corteo di scugnizzi, la storia del loro trionfo e la ragione della loro devozione al Re: «Viva TataMaccarone ca rispetta la religgione».
I francesi avevano immediatamente importato a Napoli le usanze rivoluzionarie, il numero degli anni a partire dalla proclamazione della Repubblica francese, i mesi coi nomi bucolici, Germile, Termidoro, Messidoro e via dicendo, la “settimana” di dieci giorni con, al posto della domenica il “decadì”. Bastava quest’ultima novità a spazientire i napoletani che nessuno avrebbe mai convinto a lavorare più di sei giorni di seguito, come Dio comanda, e a rinunciare ad almeno un giorno di riposo ogni mese.
L'”albero della libertà”, un palo inghirlandato con scritte, motti, allegorie, coronato da un berretto frigio, simbolo delle conquiste rivoluzionarie, a Napoli fu piantato in cinque posti diversi. Intorno ad esso avrebbero dovuto celebrarsi i trionfi giacobini ma il popolo, di notte, li buttava continuamente a terra. Girandovi attorno tre volte, si poteva concludere un matrimonio: bastava che il maschio dicesse «All’ombra di questo albero fiorito, tu mi sei moglie e io ti son marito», e la femmina: «All’ombra di questo albero fiorito, io ti son moglie e tu mi sei marito». Ma scherziamo? vaglieli a toccare, ai meridionali, il matrimonio e la famiglia.
Fra le leggi della Repubblica, naturalmente, oltre la marea di “contribuzioni” fissate dai francesi, non poteva mancare la coscrizione obbligatoria per Napoli e per il resto dello Stato. Si era reclutati dai 15 ai 60 anni: sono esentati solo «gli storpi, i ciechi, gli indisposti per malattie croniche» e «tutti gli altri che pe’ loro delitti, o per l’immoralità di loro condotta» non fossero degni dell’onore di prendere le armi in difesa della patria. I coscritti venivano divisi in due classi, “sedentanea” e “attiva”. I primi, che non prestavano servizio attivo, dovevano pagare una somma di denaro in cambio del beneficio di cui usufruivano. Insomma, i napoletani erano proprio refrattari alla «democratizzazione».
Con lo stesso spirito degli antropologhi, i visitatori dell’Ottocento e quelli odierni vanno a cercare a quale punto dell’evoluzione corrisponda l’homo meridionalis visto, sempre e comunque, nella fattispecie del “lazzarone” che, a duecento anni di distanza, ha preso il significato di poltrone, scansafatiche, profittatore, mariuolo, irresponsabile, oltre, naturalmente, che di «camorrista» e «mafioso». Ma dell’attributo di lazzarone il napoletano fu sempre fiero. Forse quello che andò più vicino a capire cosa fosse un lazzarone, contro l’opinione corrente, fu Goethe che, «avendo sentito parlar tanto di questo gran numero di perdigiorno, di oziosi, di sfaticati che riempivano la città», una volta arrivato a Napoli, lo coglieva il sospetto «che tali affermazioni dovessero essere effetto del modo di giudicare di sentenziosi, che scambiano per ozioso chiunque non si affatica penosamente tutto il giorno». Infatti, osservava il tedesco, essi «erano facchini, cocchieri, garzoni, barcaioli, pescatori, e avevano mille minuti mestieri e mansioni. I pretesi oziosi non esistevano».
Finita, con la Cristianità, l’humanitas, perso il centro da cui farsi un giudizio, cercando un punto qualsiasi su cui fondare l'”ordine nuovo”, una gerarchia qualsiasi su cui ricomporre una città, a Croce (che, del fatto di «non poterci non dire cristiani», non riusciva ad andare oltre un vago sentimento) sulle orme di Marx, non rimaneva che sentenziare: «I lazzari sono l’infima classe dei proletari di Napoli, il Lumpenproletariat, quella classe che i sociologi moderni contrappongono al proletariato industriale, del quale forma spesso l’antitesi». Lenin, più preciso, definiva il “sottoproletariato” quella parte del popolo che non ha preso coscienza della lotta di classe, inattiva, reazionaria, che non risponde alle direttive del partitoguida. Insomma, visto da destra o da sinistra, da liberali o comunisti, il popolo napoletano, che ancora non ha risposto alle istanze del “progresso” è, ancora oggi, quell’atroce marmaglia famelica e belluina, che nel ’99, come narra un anonimo «cronista di S. Paolo» citato dai “risorgimentali”, strappava il cuore e il fegato ai condannati, se li friggeva e se li vendeva all’angolo delle strade.
A scusante, gli “amici del popolo” di ieri e di oggi, se la cavano col dire ch’è ignorante, nel senso che ignora come stanno veramente le cose e, aggiunge, in fin dei conti, basta educarlo: e mo’ ci pensiamo noi. Non lo nascondevano, sui loro giornali, nei proclami, nella costituzione, tutti quelli che, con l’aiuto molto interessato dei francesi, vollero fare quella che i lazzari chiamavano «la repubblica dei paglietti».
Quando Re Ferdinando tornò a Napoli, si trattenne, perché ancora si sparava nella città, sulla nave ancorata nella baia. Il popolo lo seppe e fu un accorrere di barche, a migliaia, per salutarlo. Le donne piangevano, tutti gridavano: «Vulimme veré tata nuosto», «Vogliamo veder papà nostro» e il Re era costretto a tornare continuamente in coperta perché di “figli” ne arrivavano continuamente mentre, da terra, al fuoco di Sant’Elmo facevano eco le batterie di tutti gli altri forti che sparavano a salve per far festa. Durò così tutta la giornata.
Da allora, la storia chiama Ferdinando IV «re lazzarone». Non se ne offenderebbe lui né tantomeno il popolo di Napoli che, fedele ai patti, come un gran signore, di quelli, insomma, che hanno “onore”, con buona coscienza, un re s’è sempre considerato.
Quel «mostro» del Cardinale Ruffo
«Oltre le preghiere, che ripeto a Vostra Eccellenza, di leggere il mio grifonaggio [“appunto”, dal franc. griffonage, ndr], ove si parla di clemenza e perdono, aggiungo che, con mio rammarico, nelle lettere dei padroni si segue sempre a parlare di rigore, ora più, ora meno, ma sempre di punizione. Ora io seguito a credere che la condotta sarebbeassolutamente diversa, e che, sinceramente, dovessersi perdonare i passati trascorsi». Lo scriveva il Cardinale Ruffo ad Acton l’8 maggio 1799, quando Nelson aveva preso in mano la situazione vendicandosi dei repubblicani. E più oltre: «Ma ve ne sarà qualcuno che, sapendo bene che non li sarebbe perdonato nulla, starà quieto e buono; ma, in tal caso, non merita questo convertito il perdono?».
Fabrizio Ruffo, che sarà nominato Luogotenente generale del Re, nelle condizioni proposte per la resa di Castelnuovo e di Castel dell’Ovo, generosamente scriveva: «Art. 3. Le guarnigioni usciranno cogli onori militari; armi e bagagli, tamburo battente, bandiere spiegate, micce accese, e ciascuna con due pezzi di artiglieria. Esse deporranno le armi sul lido. Art. 4. Le persone e le proprietà mobili ed immobili di tutti gli individui componenti le due guarnigioni saranno rispettate e garantite. Art. 5. Tutti i suddetti individui potranno scegliere d’imbarcarsi sopra bastimenti parlamentari, che saranno loro preparati per condurli a Tolone, senza essere inquietati essi né le loro famiglie».
Il Monitore di Eleonora de Fonseca Pimentel dell’8 ventoso (28 febbraio) invece, scriveva: «Segnato… dall’infamia di tutti i vizi, Fabrizio è il capo masnada sedicente Cardinal Ruffo, Fabrizio è l’esoso tiranno».
Cuoco, a proposito dei rivoltosi impenitenti giustiziati nelle provincie all’avanzata liberatoria della Santa Fede, scrive che «furon molto meno numerosi di quel che si possa credere». Ma il Monitore, come, del resto, gli altri fogli repubblicani, continuavano a propalare le menzogne più assurde. La più grossa fu quella segnalata da un proclama dell’Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Capece Zurlo, il «16 germile, anno I della Repubblica napolitana» (5 aprile): «È pervenuta a nostre orecchie l’orribile voce, comunicataci anche dal Governo, che il Cardinal Ruffo abbia assunto nelle Calabrie il nome di Romano Pontefice, e che coll’abuso di questa Sacra Autorità si affretti a sedurre que’ popoli, incitandogli a delitti di ogni genere e alla più sanguinosa strage».
Che, questa e altre volte, per pusillanimità o per evitare maggior guai alle sue pecorelle trasformate in leoni (Dio solo lo sa), l’Arcivescovo si lasciasse andare un po’ troppo alle lodi del governo, né il Re né i lazzaroni gliela perdonarono: Ferdinando, uomo pio, pensò che un po’ di ritiro spirituale a un uomo di Dio non dovesse far male. Lo sollevò dell’incarico a Napoli e lo spedì nel monastero di Monte Vergine, un quieto romitorio fra le montagne dell’Irpinia. Il Cardinale, salvo quando, un anno dopo, fu lasciato andare al conclave che elesse Pio VII, vi rimase fino alla fine dei suoi giorni.
Fabrizio Ruffo, nato a San Lucido, in Calabria, dai duchi di Baranello, a quattro anni fu mandato a Roma per essere educato dallo zio, il Cardinale Tommaso Ruffo. Pio VI, appena eletto, nel 1775, nota quel giovane prete e se lo tiene vicino. Dieci anni dopo lo nomina Tesoriere generale. Alla solida dottrina e alla pietà, Don Fabrizio unisce uno spirito sveglio e intraprendente. Incaricato di tirar sù le finanze disastrate dello stato, dà vita ad un complesso sistema legislativo in materia tributaria e fiscale, abolisce molte dogane, leva tributi protezionistici, incrementa il commercio, promuove seterie, lanifici, ferriere, aumenta finanche la flotta e costruisce, oltre una chiesa all’Isola Sacra, le fortificazioni di Ancona e Civitavecchia. A 47 anni, Pio VI lo crea Cardinale ma se lo tiene “inpectore” giacché un simile prodigio di prelato si attira l’invidia di certa gente di curia e, peraltro, è troppo povero per fornirsi di quel minimo di appannaggio che serve a un Principe della Chiesa. Lo proclama infine nel 1794 e lo spedisce nel Regno di Napoli dove Ferdinando lo nomina soprintendente delle seterie di San Leucio e lo investe dei benefici di un’abbazia.
Nominato, a Palermo, Vicario generale del Regno, Fabrizio Ruffo, che aveva allora 55 anni, lasciò il Re il 27 gennaio, con la sola compagnia del Marchese Malaspina. Il 31 è a Messina e il 7 febbraio sbarca a Punta del Pezzo, presso Scilla. Con lui, in tutto, ci sono tre gentiluomini e due preti. Il 18 febbraio invia un proclama «ai Reverendissimi Vescovi, ai Signori Parrochi, ai Governatori e ai bravi e fedeli calabresi». Da questo momento nasce l’«Armata Cristiana e Reale della Santa Fede». Coloro che arrivano ad arruolarsi da ogni parte e si aggiungono man mano che avanza verso il Nord, non hanno armi se non qualche schioppo e gli arnesi del loro lavoro, non hanno divise, non hanno cavalli, solo qualche bestia staccata dall’aratro, non hanno danaro, non hanno provviste. Quando l’Armata giungerà a Napoli il 13 giugno, conta 20.200 uomini perfettamente vestiti nelle loro uniformi, equipaggiati di tutto e ben addestrati, un reggimento di cavalleria di 450 uomini, un reggimento di “Fucilieri di montagna” di 800 uomini, e 18.000 soldati appiedati, le cosiddette “Truppe di massa”. Alla Santa Fede si sono aggregati, via facendo, 600 russi e 400 fra austriaci e turchi. Alla loro testa sventola la bandiera bianca che la Regina e le figlie hanno ricamato apposta inviandola al Cardinale, il 5 giugno, quando le truppe sono ad Ariano, in via dalle Puglie già liberate, scendendo dall’Appennino verso Napoli. Sulla bandiera, da un lato vi è lo scudo borbonico, dall’altro «la Croce, ch’è il segno glorioso della nostra Redenzione», come scrive ai soldati la «Vostra grata e buona Madre Maria Carolina ».
La lunga marcia della Santa Fede, durante l’avanzata, si è arrestata a lungo solo a Crotone dove una base di francesi ha impedito, per tre giorni, che la città potesse arrendersi. Prima dell’assalto, il Cardinale celebra il Triduo pasquale. Da Corigliano emana un editto in cui si promette perdono ai giacobini e minaccia punizioni a chi farà vendette private. Ovunque passa e sosta, le donne cuciono le divise per i soldati, portano provviste, curano i feriti. Gli uomini si arruolano, portano armi e munizioni, cavalli, animali da macellare, ognuno i suoi risparmi. A Bernalda, in Lucania, il 3 maggio, con tutti i suoi paramenti cardinalizi, celebra solennemente la festa dell’Invenzione della Santa Croce. La Croce viene piantata in ogni paese conquistato, al posto dell’albero della libertà.
In Puglia, le città che ancora non sono insorte (quasi tutte), si arrendono immediatamente mentre i francesi e Carafa battono la ritirata. I combattimenti con i francesi, man mano che la Santa Fede si avvicina a Napoli, divennero sempre più aspri. Il Cardinale è sempre alla testa delle truppe. Aveva scritto, prima di partire: «Eccomi, dove si tratta di sostenere l’onore della Religione, che vuole ubbidita la Maestà di un Principe dato da Dio, sarà un pregio della Porpora che mi ricuopre, se rimarrà di sangue intrisa per la difesa di quel che prescrive colla sua Legge. Io andrò girando per le Provincie del Regno non con altro in mia compagnia, che col Crocefisso».
Gli ultimi scontri avvennero al Ponte della Maddalena, dove un forte sorvegliava l’ingresso alla capitale. Anche questa volta i francesi furono sbaragliati.
La nazione napoletana aveva vinto la “nazione in armi”. Il Regno del Sud fu l’unico stato a respingere l’Armata d’Italia, con le sue sole forze, con il primo esercito di volontari dopo quello della Vandea. Sia in Italia che in Francia si combatté per difendere l’onore della parola data al Re in nome di Dio.
Le prime avanguardie della Santa Fede arrivarono alle porte di Napoli che era notte. Pattuglie di esploratori si spinsero fin oltre il Ponte della Maddalena. Il primo drappello di due, tre uomini si infilò al galoppo per le strade e i vicoli verso la marina, i francesi erano tutti rintanati nei forti assediati dai popolani. Sbucò in una piazzetta con i cavalli schiumanti e si arrestò scalpitando sulle lastre di lava. La città era buia e silenziosa. Non una finestra da cui trasparisse una luce. Il capo pattuglia lanciò la parola d’ordine che usavano sia i repubblicani che i lealisti: «Viv’a chi?». Non ci si poteva sbagliare, né da una parte né dall’altra: la prima risposta rivelava gli amici o i nemici. Il silenzio durò solo pochi istanti, poi qualche lume cominciò ad accendersi, qualche finestra a spalancarsi e le prime voci a rispondere, senza esitare: «Viv’o Re!», «Viv’o Re!».
E tutta Napoli si svegliò, e si aprirono ad uno ad uno, sempre più in fretta tutti i balconi, e le voci si rincorrevano, si facevano coro: «Viv’a chi?», «Viv’o Re!», «Viv’o Re!». Tutti accendevano lampade, candele, applaudivano dalle logge, scendevano in strada. Napoli, quella notte, fu tutta una luminaria.
GUIDA ALLA LETTURA / 5.
La letteratura sulle “insorgenze ” in Italia è ancora ai suoi inizi. Di questo periodo ancora pressoché ignorato dalla storiografia, è molto utile leggere:
MASSIMO VIGLIONE, La “Vandea italiana”. Le insorgenze controrivoluzionarie dalle origini al 1814, Effedieffe, Milano, 1995 Di uno dei più acuti storiografi di questo periodo, vi è un romanzo storico perfettamente aderente alla realtà:
FRANCESCO MARIO AGNOLI, Gli insorgenti, Reverdito Ed., Trento, 1988.
Sulla Santa Fede, la cronaca fedele di chi partecipò a quell’epopea: DOMENICO PETROMASI, Alla riconquista del Regno. La marcia del Cardinale Ruffo dalle Calabrie a Napoli, Edit. Il Giglio, Napoli, 1994.
Una bella e precisa biografia del Cardinale Ruffo è quella di: ANTONIO MANES, Un Cardinale condottiero. Fabrizio Ruffo e la Repubblica partenopea, Jouvence, Roma, 1996.
Aneddoti storici su San Gennaro dalle origini ad oggi, compresa naturalmente la Repubblica giacobina, sono a profusione nel divertente: RINO CAMMILLERI, San Gennaro. Come ha fatto un martire semisconosciuto del IIIIV secolo a diventare famoso in tutto il mondo, Piemme, Casale Monferrato, 1996.
fonte
https://www.eleaml.org/sud/storia/storia_del_sud_vista_dal_sud.html#NATO



 invio in corso...
invio in corso...