VOCABOLARIO NAPOLETANO LESSIGRAFICO E STORICO
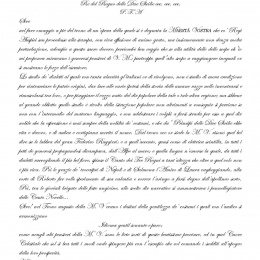
articolo tratto da eleaml.or
Pubblichiamo il dotto saggio introduttivo che Vincenzo De Ritis antepose alla sua opera principale. Il Vocabolario napoletano lessigrafico e storico, un’opera che non portò a compimento e che ebbe vita travagliata. Pare che l’autore fosse completamente estraneo al commercio di fogli dell’opera intrapreso dagli stampatori. Un commercio che ovviamente interruppe i finanziamenti ottenuti dal sovrano Ferdinando II.
Vincenzo De Ritis fu intellettuale eclettico, animatore della Accademia Pontaniana e autore di vari testi.
Il Martorana si rammarica che si celebrasse il generale Fanti (in quanto considerato uno degli artefici del Risorgimento) e si ignorasse il De Ritis, nonostante il suo elevato impegno nello studio delle lingue.
vocabolario_1845_napoletano_lessigrafico_storico_2016
VOCABOLARIO NAPOLETANO
LESSIGRAFICO E STORICO
VOLUME I.
N A P O L I.
DALLA STAMPERIA REALE
MDCCCXLV.
SISTEMA LESSICOGRAFICO
DEL
DIALETTO NAPOLETANO
La lessigrafia di un dialetto altra esser non può, nella sua essenzial parte, se non quella di un comune idioma al quale con altri dialetti appartiene; il quale idioma, con vedute più larghe, vuol considerarsi come un dialetto anch’esso: e così vievia, fin che si giunga, sempre più di mano in mano differenziando, e quel lessigrafico sistema in che consiste la imprescindibile comune gramatica di tutti gli umani linguaggi. Senza la quale non sarebbe possibil cosa che popoli di molte favelle venissero a parlamento tra loro: perciocché le forme rappresentative, o, a dir meglio, risvegliatrici delle nostre idee, tradur non si possono senza di quella da idioma ad idioma e passar quasi di cranio in cranio come un liquido si tramuta di vaso in vaso.
Questa iniziante e primigenia lessigrafia noi troviamo di già stabilita da’ nostri maggiori: ché nulla e mero cangiamento di nomi vi aggiunsero que’ moderni i quali di una così detta Gramatica Universale anfanarono a dichiararsi insegnatori. E però la nomenclatura de vecchi grama ti ci seguiamo; e parole di greca o di latina forma credemmo nostro debito includere nel nostro vocabolario le quali, se tra le parole non si rinvengono de’ volgari, pure della speciale indole del nostro dialetto sol valgono a fissar le condizioni che dagli altri italici dialètti il distinguono e dal comune aulico linguaggio. Del quale, comunque voglia riguardarsi dialetto anch’esso di un primitivo idioma che dir potremmo iapetico, se si vuole, anche falegico o pelasgico; pure, perché contiene in sé eminentemente quel gramaticale sistema modello dal quale fluiscono tutte quante le lingue del mezzogiorno di Europa; abbiano voluto (e ci si condoni questa naziònal debolezza) seguir piuttosto le ragioni come dal Bembo in giù i nostri gramatici le ponevano, e considerar le divergenze non altrimenti che idiotismi, vuoi francesi, vuoi casigliani, vuoi d altra razza.
Ed è questa la giustificazione dell’aver noi allogato nel nostro vocabolario tutto il tecnicismo gramaticale italico; nel quale, e nel qual solo, della speciale indole del dialetto stabilir si potevano con agevolezza e caratterizzare le differenze. Avremmo ben potuto alla profferenza napoletana adagiarlo ma l’autorità ci ha confortati del Buommattei quando disse, che i termini quanto più si fanno volgari, tanto son meno intesi.
Le quali differenze a tre principali obbietti si riferiscono: 1.° di profferenza, e conseguentemente di ortografia; 2. di sintassi 9 e conseguentemente di quegli amminicoli gramaticali che dell’ordinamento di un discorso costituiscono le ragioni; 3. di parole speciali, o dagli antichi idiomi ritenute, o da popoli stranieri introdotte, 0 da noi stessi foggiate secondo che bisogna o fantasia le occasionavano.
Dell’ultimo non è qui ragionamento: e alla parola Etimologia è detto abbastanza. Ma nell’ordine alfabetico per noi seguito (gli articoli che i primi due obbietti riguardano esibir non si potevano in modo che da per sé soli dar potessero un compiuto concetto senza molte ripetizioni. Di qui gli articoli di rinvio che ne offrissero l’iniziativa o il complemento.
E di tali articoli un ordinamento. metodico qui presentiamo, nella cui successiva lezione rinvenir si possa quel che a nostro avviso costituisce il differenziale sistema lessigrafico del dialetto napoletano.
PRONUNZIA ED ORTOGRAFIA
In una sensazione qualunque dell’udito, in un suono qualunque, cinque parti integranti stabilir si possono: la Voce, ed in essa il tuono e la durata; l’articolazione, ed in essa la tempera. Tutte queste cose ab antico ne’ suoni della voce umana si è andato distinguendo e con maggiore 0 minor minutezza notando: ma la voce, il tuono, la durata è argomento più musico che gramaticale; come argomento più gramaticale che musico è stato ed esser dee l’articolazione e la tempera. Perciò gli antichi le articolazioni co’ segni principali notarono, che dissero lettere, e poi tutti gli altri accidenti, con subordinati segni diacritici più o meno copiosamente di mano in mano introdotti.
Ed in vero: perché la voce umana esser possa la enunciativa di un pensiere agevolmente comunicabile, nella ipotesi ancora che con le semplici onomatopee sino a un certo punto provveder potesse; P atteggiamento solo dell’organo stomoideo per emettere un A, un I, una E, ec. già è per sé stesso un’articolazione. Per lo che ci sembra che non si esprimesse con la sua solita precisione il Tracy quando disse:
» Essere la voce quella circostanza del suono la qual fa ch’egli sia un’A o un I piuttosto che un O o un U».
Con miglior senno i nostri antichi queste circostanze del suono non dissero voci, ma vocali, e i più antichi anche mozioni della voce. Di fatti: perché la muta emissione del fiato in voce si trasformi, fa bisogno che perda l’equilibrio e mettasi in oscillazione: la quale (da una protovibrazione sempre mai dipendendo) se isocrona si rimane, esser ben può valutabile per durata; se l’isocronismo non conserva, può discendere al grave e innalzarsi all’acuto, e dall’acceleramento o lentezza delle vibrazioni esser valutabile per tuono. Ma sempre rimane quella condizione che l’espressione meramente musica trascenda e ad un sistema di segni comunicativi d’idee si trasporti: il qual non si rimane al semplice ufizio di risvegliatore ed eccitatore anche della tale o tale altra passione a larghe divisioni compartita, ufizio limitativo della musica; ma che delle minime differenze s’industri a far distinguere i più tenui particolari, e della concezion de’ pensieri si renda insiememente risvegliatore, dilucidatore e ministro, uffizio esclusivo della loquela umana nell’ampia e trascendentale espansione delle sue facoltà.
Quindi è che l’umana voce in espressione logica ed in espressione rettorica si vuol distinguere. E se questa dal ministerio della espressione musicale non poca parte trac della sua energia, e. quella altresì nella più placida enunciazione d’un pensiere da ciò che chiamasi musica del linguaggio non può affatto distaccarsi; pure rimarrà sempre tema incontroverso e solenne assioma, essere nelle articolazioni l’ipomoelio di ogni umano linguaggio. Il che nelle più tenuamente espresse articolazioni vuol da prima considerarsi, e nelle vocali stesse le protovibrazioni andar considerando. E perciò ben disse Platone che le lettere vocali nella laringe pie Orante si formano: perciò lettere gutturali negli alfabeti antichissimi le vocali si rimasero: perciò di uno spirito tenue nella scrittura ellenica tutte le vocali si caricavano se prime si fossero presentate in una parola: e perciò le prime scritture latine tante H iniziali si ebbero di parole e di sillabe che dai più moderni scrittori si andarono poi vievia dismettendo.
Dal che segue che il tocco articolare, la parte plettrante dell’organo stomoideo, è ciò che principalmente vuol essere esaminato nelle sue diverse funzioni se della vera analisi gramaticale allontanar non ci vogliamo da una tal quale recisione. Col progresso della civiltà e l’ingentilirsi delle loquele molte di queste articolazioni ben possono attenuarsi e divenir quasi evanescenti: ma abolirsi affatto non mai: e virtualmente almeno sempremai si riproducono, se delle trasformazioni delle parole ci facciamo a ricercare il perché. ’ Ma in tal disamina dall’avviamento porremo studio a non divergere che i nostri grandi avoli segnarono, ricalcandone quasi le orme.
LETTERE VOCALI
» Prendi questo Corano, disse Abscilarvad al suo scribente, e prendi una tinta di color diverso dall’inchiostro: e quando mi vedi aprir la bocca, metti un punto al di sopra della lettera: quando stringerò le labbra tra loro, metti un punto al lato della lettera: ma quando le infrangerò metti un punto al basso della lettera». E di fatti son questi i segni esterni dell’organo stomoideo per distinguere spiccatamente le prime differenze delle voci, le quali tutte, come dicemmo, considerava Platone articolate nella laringe. Ma, oltre a quella protovibrazione nella laringe, aver dee la bocca diverso atteggiamento. Basta solo aprirla nella prolazione dell’A.; bisogna stringer le labbra per profferire un O; infranger le labbra con un atteggiamento linguale per avere una E. Intanto un insegnamento dottrinale e scolastico, per adottar le frasi del beato Agostino, può soltanto segnare i limiti di quell’apertura, ai quel tondeggiar delle labbra, di quell’atteggiar della lingua. Nella volubilità della prolazione della voce umana v’ha un procedere quasi insensibile: ed ecco non tre sole vocali, ma tre classi di vocali» Dall’A chiarissimamente profferita si può far passaggio, senza giugnervi tuttavia, all’E ed all’O, che i Greci segnarono per H ed Ù, e i nostri gramatici con tutta ragione dicono aperti: si può dall’O procedere al TU nostro, stringersi anche più nell’U fiutato degl’italici transappennini e de’ Francesi, e giugnere ancora lievemente a toccarsi e nella più tenue delle labiali, nella V a trasformarsi. E del pari quell’atteggiamento della lingua che alquanto al palato accostandosi determina l’E, può avere un avvicinamento ulteriore, ed ecco l’I; può giugnere lievemente a toccarlo, ed allora nella più tenue delle linguali., nella J si trasforma.
Ecco adunque tre classi delle lettere vocali.
I. Vocale mera gutturale, A, Í, Ð.
II. gutturale labiale, Ù, O, U, r, V,.
III. gutturale linguale, H, E, l, J, t.
L A par che rimanga solitaria; ma sanno i gramatici che ben dieci suoni diversi Prisciano le attribuiva; ed abbiamo di già osservato come con l’Ù e la H (che i nostri chiamano O aperto ed E aperta) non di rado si confonda.
Nelle altre due classi abbiamo evidentissima l’iniziativa delle consonanti. Perché la prima ne mancherebbe? Ma fatevi a pronunziare un A con molta forza, e la consonante in quella vigorosa protovibrazione diverrà spiccante e l’iniziativa vi rinverrete di tutte le gutturali.
Giunti a questo stadio della nostra analisi, già della caratteristica speciale del nostro dialetto cominciano a presentarsi le condizioni..
È dorizzante il nostro dialetto: e conseguentemente all’apertura dell’organo stomoideo sono i Napoletani inchinatissimi. Di qui il tramutare in A, senza eccezione alcuna, quelle articolazioni vocali che altrove giungono appena all’O aperto, alla E aperta: e il tramutare in O ed in E le più strette articolazioni U ed I.
Intanto di quell’avvertimento del Salviati non vuol qui tacersi il ricordo: » Essere non infrequente che più o meno finite le lettere si mandin fuori. » Ma non diremo con lui che ciò si faccia lanciandone addietro una parte ed alla seguente saltandosi: salti non v’ha nella pronunzia delle articolazioni se non quando v’è lo ntoppo, com’ei diceva, nel percotimento delle diverse consonanti; e nemmeno delle consonanti generalmente considerate, ma di quelle che mute i vecchi gramatici denominarono: in tutti gli altri casi le articolazioni strisciano dall’una all’altra lievemente e quasi in un dittongo articolare per dir cosi vengono a trasformarsi.
Dal che segue che delle tenuissime articolazioni delle vocali son due le vicende: 1.° di attenuarsi sempre più ne’ così detti dittonghi raccolti: 2.° di rendersi più spiccanti in quelli che a noi rimangono dittonghi distesi, quando cioè di due vocali sentir bisogna spiccatamente la doppia profferenza.
Ed ecco perché, ne’ volgari d’Italia, molti dittonghi raccolti dittonghi più non sono, essendosi quel mezzo I (e va detto lo stesso del mezzo U) vieppiù diminuito e quasi obliterato, o al semplice tocco dell’articolazione ridotto, e perciò ortograficamente con la J o V figurato; mentre ne’ dittonghi distesi quel lieve tocco articolare in articolazione più spiccante si trasforma. Cosi nelle antiche scritture, come nella bocca de’ volgari di alcune italiche regioni, di Paolo si ha Pagolo e Pòlo, toccando gli estremi della troppo spiccata o troppo liquescente profferenza: gl’intermedi sono Pavolo e Paulo.
Nel dialetto napoletano è costante l’interposizione dell’l, più o meno vibrato, tra due vocali di classe diversa, come maiestà, paiese, maiestra, in vece di maestà, paese, maestra, senza per altro giugnere sino alla J consonante, come in alcune stampe si osserva; e non di rado v’ha l’addizione di quelle mezze lettere per semplicemente attenuare 1espressione della vocale che segue; attenuazione ordinariamente determinata per vedute lessigrafiche, come or ora sarem per vedere.
Ma dalle protovibrazioni tenuissime alle più scolpitamente pronunziale.
SEMIVOCALI
Se una delle caratteristiche spiccanti della lingua italica è quella di conchiudere qualunque parola con una lettera vocale; spiccante caratteristica del dialetto napoletano è quella di conchiudere con una vocale tutte le sillabe ancora.
Ma tra le consonanti alcune ven sono che gli antichi dissero semivocali; e queste, sebbene conchiuder possono una sillaba italica, come conchiudono nel domestico conversare le parole di molti volghi dell’Italia transappennina, e molte parole ancora del comune aulico linguaggio; pure nella loro integrità non rimangono. E ben si dissero liquide tali articolazioni perché strisciano agevolmente e si adagiano con altre sul bel principio di una sillaba in modo da poter essere non di rado in alcuni alfabeti espresse con un sol carattere; e non solo formano un prolungamento della vocale che precede, ma ne modificano altresì la natural profferenza. Tali sono le L, R; M, N; F, S; il cui ufizio nelle varie loro posizioni per ciò che riguarda la profferenza italica, andremo esaminando.
Quando, nel principio di una parola o di una sillaba, solitarie le semivocali si presentano, conservano l’integrità del loro carattere per nulla difforme in tutti gl’idiomi. E nel dialetto napoletano, come nelle lingue semitiche, scrivonsi scempie o doppie per esprimere la loro ordinaria o più spiccante vibrazione. Il che avviene in tutte le consonanti. E qui non è da non rammentare il saggio avvertimento del Salviati, essersi contra ragione e per mero abuso introdotto il costume di non addoppiare al principio delle parole le consonanti le quali spiccatamente si pronunziano e quasi con doppia forza, e di scompagnarle e dividerle tra due sillabe nel mezzo delle parole quando indivisibile esser ne dee la profferenza, non rappresentando le due consonanti una ripetizione del tocco articolare, ma soltanto un tocco più vigoroso il qual, tutto intero, alla seconda sillaba si appartiene.
E tutta intera alla vocale seguente si appartiene altresì la profferenza di quel gruppo di consonanti che dittonghi o trittonghi posson sibbene apparire nella primitiva rigidità dell’organo della parola, ma che per la fusione delle liquide articolazioni coll’andar del tempo in monottonghi s’ingentiliscono: e viceversa ima specie di dittongo compor possono se ad una precedente vocale si aggiungono, come più su dicevamo.
La quale addizione di un altro tocco articolare, ma evanescente, in tutti gli umani idiomi si rinviene. Dopo di avere Abscilarvad indicato al suo scribente i tre segni diacritici delle tre classi delle mozioni di una voce, soggiugneva:
» E se dopo alcuno di tai moti senti un appoggio nasale, o metti due punti invece di uno».
Ed ecco 1indicazione dell’ufizio delle lettere liquescenti il quale nella M e nella N più manifestamente appare, comunque a due tocchi diversi dell’organo stomoideo vadan tali lettere riferite, quella alle labiali, questa alle linguali palatine.
Della N disse Mauro Terenziano:
sonitus fugitur usque sub palato
Quo spiritus anceps coeat naris et oris;
e disse che la M
clauso quasi mugit intus ore.
L’aspirazione nasale della N da noi scolpitamente non si avverte quando la pronunzia è battuta, ma è notabilissima in combinazione, spezialmente nella profferenza de’ nostri Calabresi. Ma allora indubitata cosa è che di tal voce propria non manchi e un dittongo venga quasi a formare con la vocale che le precede. E però semivocale fu a giusta ragione dagli antichi denominata: nel quale ufizio del suo consonante tocco palatino quasi viene a dismettersi, perché assai sottilmente si attenua come nelle articolazioni delle vocali. Ed ecco una quarta classe per dir così di articolazioni che come semplici vocali nasali non già come consonanti vengono al di là delle Alpi dal Beauzée in poi considerate. Ma perché mai tutti quei valentuomini che dopo quel sottilissimo gramatico la vocalizzazione comunque alquanto oscuretta della N riconobbero e l’àn, l’in, l’on, l’un, come vocali mere nel francese idioma van considerando, hanno poi tanto ribrezzo a chiamar semivocali quelle lettere liquescenti che semivocali gli antichi denominarono? Cile che ne sia, nel nostro dialetto non solo, ma nelle regioni ancora di profferenza e di ortografia del comune italico linguaggio, dii una tal classificazione abbiam d’uopo.
Se nel napoletano non v’ha sillaba la qual non si conchiuda con vocale, e la N, dopo la modificazione della vocale che precede, alla sillaba seguente si trasporta; non altrimenti avviene nel Vallo d’Arno, dove, per accostarsi al vezzo di quel volgo, la I rimuovesi dalle parole che hanno l’iniziativa dall’IN. Cosi abbiamo già veduto che ’ncontro invece d’incontro compiacevasi il Salviati di scrivere; e sé chiamò ’nfarinato, e l’amico suo ’nferigno. Non è adunque da berteggiarsi il volgo napoletano se l’aferesi della IN è per esso costante, anche quando questa preposizione è isolata; e se, per seguire il suo analogico andamento, la N, la R, ec. anche dalle altre preposizioni rimuova, e non pronunzi e scriva giammai con, per, e le apocopate N, R, ec. faccia finire e tramutare nella consonante della seguente parola se ve n’abbia, o le trasformi nella D paragogica, more maiorum, come cenneremo più giù e nel vocabolario alla lettera D sarà più ampiamente disviluppato.
La M come semivocale altro non importa se non un’attenuazione della N, quando al tocco palatino l’espressione d’una labiale succede. E in questo solo ufizio, non insolito ne’ Latini, può la M considerarsi come una delle lettere semivocali e liquescenti. Che anzi, nel napoletano dialetto, quando pel comune italico non dee considerarsi la M se non come una N attenuata perché seguita da una debole labiale; questa ultima è quella che si attenua e dispare, rimanendo la M non solo in tutta la sua interezza, ma con maggior vigore espressa nella pronunzia, e conseguentemente addoppiata nella scrittura; cosi in vece di mbruoglio, non voglio, ec. dicesi e scrivesi mmruoglio, no mmoglio, ec., comunque sia stato e sia nel costume di alcuni scrivere il non come nel latino letterato e nel comune italiano.
La L nella fine di una sillaba il dialetto napoletano non comporta, ed in U o nell’affine R la va sempremai trasformando. Così ALtare, ALto, ALtro, diviene AUtaro, AUto, AUtro e conseguentemente se la vocale cui la L si lega è un O, dispare anche il dittongo e nella semplice O ovvero in U si ristrigne, secondo che l’O sia aperto o chiuso; così pOLtrone, vOLta, mOLto si cangia in pOtrone, vOta, mUto.
Questa fusione della L fa sentirsi ancora nel Vallo d’Arno; se non che la trasformazione è quasi una mezza I, come disse il Salviati: Altra vOIta, Almo sole, Olmo, vUlgo, in vece di ALtra vOLta, ALmo sole, OLmo, vULgo: esempi da quell’illustre gramatico prodotti.
E se quelle I dell’Alta vOIta toscano nemmen come mezze lettere vai considerando, ma come voci di più in più attenuate; ecco spiccante l’Ata vOta del napoletano dialetto.
E i Napoletani del pari che i Toscani tramutano la L in R. E ci piace dallo stesso illustre gramatico trarre questi esempi: Esempro, G. Villani, Livio M, Maesro Aldobrandino. Asembro, G. Villani, Pistole di Seneca, Giudice Albergano. Compressione (complessione ), tuttavia G. Villani, Giudice Àlbertrano. Affligge (affligge), anche G. Villani, Pistole di Seneca. Obrianza, sempre G. Villani, Ammaestramento degli antichi. Semprice, altresì G. Villani, Maestro Aldobrandino, Vita di Gesù Cristo. E Obbligato… Fragello… Nigrigenza… Sopperire…. E basti cosi.
Nulla diremmo su la F se dell’analogia di questo sibilo labiale con la sibilante palatina S il nostro dialetto non ci offrisse occasione di estendere anche più il novero delle lettere che a buon diritto addimandar si dovrebbero semivocali.
Ogni qualvolta s’incontra quell’articolazione che i Latini esprimevano per FL e nel comune italico si tramuta in Fi, dal volgo di Napoli non altrimenti si pronunzia se non come se dicesse SCI. Intanto non è precisamente uno SCI, e lo Scoppa credè ben fatto esprimerlo per XI, e dal Cortese sino al Pagano fu renduto per SHI.
Cosi si ha
| da | FLamma | si ha | Fiamma | SCIamma |
| FLato | Fiato | SCiato | ||
| FLocco | Fiocco | SCIocco | ||
| FLore | Fiore | SCIore | ||
| FLumine | Fiume | SCIummo |
si noti in quest’ultima parola l’attenuazione della desinenza, quasi da Fiumane, con la M doppia nel napoletano ad espressione della N svanita nell’ingentilirsi dall’antico linguaggio.
Togliete l’aspirazione alla F, ed abbiamo P. Intanto l’articolazione da’ Latini espressa per PL e che nella favella nobile suona PI i nostri volgari pronunziar non sanno, e dicono CHI schiacciato.
Così
| da | PLaga | si ha | Piaga, | CHIaia |
| PLumbo | Piombo | CHIummo | ||
| PLatea | Piazza | CHIazza | ||
| PLuere | Piovere | CHIovere |
E in CHI schiacciato da tutti gl’Italici si risolve quell’articolazione che i Latini notavano per CL: come da CLAro, CHIaro, da CLAve, CHIave; da CLauso (o CLuso come gli antichi dicevano), CHiuso, ec.
Ma questo CHI schiacciato che in bocca di tutti gl’Italici cisappennini si rinviene, donde provenne? Da quell’italico C appunto del quale faticosissima per non dire impossibile ad alcuni popoli è la profferenza: testimonio il noto aneddotto per distinguere i forestieri da’ nazionali ne’ celebri vespri della Sicilia insolare.
E perché quella sì bella parte de’ domini del nostro RE or Sicilia or Cicilia, quando avventata ed oscillante ancora era l’italica ortografia, variamente scrivessi? E fistio stiena, stiavo pronunziarsi e scriversi da volgari nel Vallo d’Arno, quel che nel dir gentile va scritto e pronunziato fischio, schiena, schiavo? A queste interrogazioni sarà agevole il rispondere quando avrem veduto le varie industrie ortografiche da’ Francesi, dagl’Inglesi e da’ Tedeschi adoperate per accostarsi, senza mai giugnervi, a notare la profferenza del nostro C che un sol tocco e gentilissimo tocco articolare riputiamo, scrivendolo nelle per noi ispidissime forme di tsh, tch, tsch, stsh, stch, stsch. E non maraviglieremo se nella morbidissima pronunzia ellenica troviamo al cominciar d’una sillaba certe articolazioni espresse con lettere aggiogate in modo che assai dure per noi sembrano, e quasi impronunziabili, come:
ec.
E forse a quelle apparenti durezze dovremmo scendere ancor noi se ortograficamente a notar ci facessimo il nostro SB, SC, SF, SG, SM; perciocché, dovendosi per vezzo del dialetto pronunziare la S quando precede una di quelle cinque lettere non già seccamente sibilante ma mollemente strisciante, come lo scin ebreo, come lo ch francese, come se in somma esprimer si dovesse quell’articolazione che nel comune italico rendono le due lettere SC avanti l’E e l’I, e strisciando connetterle in un solo suono con quelle mute consonanti, con le quali si accoppiano; ad un ispido accozzamento di lettere ben saremmo obbligati. Ed un esempio ne abbiamo nell’ortografia adottata da uno de’ no6tri scrittori, il quale credè indispensabile scrivere SCPasso, SCBracciato, ec. V. nel Vocabolario Piano (Mattia del).
E qui non taceremo che dai nostri Abruzzesi con inversa vicenda pronunziasi la S come scin solo innanzi alle dentali.
Pe’ quali fatti, che potrebbero ben moltiplicarsi, non maraviglieremo se gli antichi grama tiri anche la X tra le semivocali registrassero. È dessa una lettera, dicesi nelle scuole, doppia, e il suo nome è icchesi, e componesi di CS o GS. Ma non ci si dice che i Romani, adottando quel greco carattere, il quale nella patria natia avea ben altro che l’ispida profferenza dell’icchesi, non con le C e G gutturali univano la sibilante, caratteristica per essi di tutti i loro nominativi maschili; e che costantemente negli altri casi sciogliendo le C e G da quella sibilante per seguire il loro sistema lessigrafico nella inflessione degli altri casi; nelle sole C e G palatino-linguali le scioglievano. Non ci si dice, che, astrazion fatta dal romano vallone (nel qual solo le PL, CL, ec. per gli altri romani idiomi se non impronunciabili, almeno di spiacevole e dura profferenza), fu sempre la X addolcita: e tra noi trasformata o nella grecizzante X veneziana, o nello SCI dolcemente attenuato della Sicilia insolare e di tante altre italiche regioni, non escluso il Vallo d’Arno: o nello SCI alquanto più aspirato de’ Casigliani e de’ Portoghesi: o in aspirazione mera gutturale alla sibilante aggiogala in modo da potersi rendere ortograficamente con una o due S.
Se di nuovi caratteri da aggiugnersi al nostro alfabeto sentesi comunemente il bisogno; spiccantissimo si mostra per le varie profferenze delle sibilanti S e Z: pel nostro napolitano dialetto specialmente, non che per altre italiche profferenze, dopo le acute ma giustissime osservazioni del sagacissimo Salvia ti, al quale per altro anche mancò l’avvertire che per l’italiano alfabeto era indispensabile lo scin. Lo Scoppa pel napoletano credè supplirvi come abbiamo cennato, appunto con la X; e scrisse xaccato, xarra, xuliare quel che ora scriviamo sciaccato, sciarpa; sciuliare. Il Cortese scrisse Shiore, Shiato ciò che ora scriviamo sciore, sciato. Questi valentuomini seguivano nella loro ortografia le ragioni etimologiche piuttosto che la vera profferenza; pure alla vera profferenza con bella industria ingegnosamente si accostavano. —Ma basti il fin qui detto su le semivocali.
LETTERE MUTE
Torniamo ai Salviati. Per le varie profferenze della Z egli avrebbe desiderato quattro elementi. Di due soli sentiva il Trissino il bisogno; e da lui non dissenti poscia il Buonmattei. Intanto, ne’ bisogni di averne intera la profferenza, questi elementi ben troviamo nel solo alfabeto degli Arabi:
sin, scin, sain, ssad, dsad, Dal, Dhal, Tda, Thda, Te, The; ai quali elementi, che in combinazione e nella introduzione di parole da linguaggio a linguaggio tutte più o meno spiccatamente in sibilanti si risolvono, se aggiungeremo le sibilazioni della sola uccellisona lingua britanica, ad un numero opprimente ghigneremmo. Nella volubilità dei moti. linguali per tutta l’estensione interna dell’organo stomoideo, dal gorgozzule ai denti, appena gli estremi notar potremo con prerisione e dichiarare inflessibili, come il tocco gutturale ed il dentale; ma dalle gutturali battute nella radice della lingua, come Ca e Ga, insensibile è il passaggio in ragione di profferenza sino alle stesse lettere accoppiate colla terza classe delle vocali, o con la mezza vocale I dopo la H, schiacciate, o con la N, infrante. E perciò come semplice attenuazione della linguale L va considerata la G che le si fa precedere nelle articolazioni italiane che si esprimono con le lettere GLI; e come semplice rinforzo della J l’articolazione espressa con le lettere GHI schiacciate in tutti que’ casi ne’ quali per lessigrafia o per posizione una consonante vuol essere con più forte vibrazione pronunziata, e che per l’adottato sistema ortografico scrivesi doppia.
E perciò nelle altre labiali altresì il dialetto napoletano dall’una all’altra fa non di rado passaggio; e non solo per mera eufonia, quando l’ebbe, il piobbe cangia in appe e chioppe; ma, per le testé cennate ragioni di lessigrafia e di posizione, quando cangia la debole V nella robusta B tutte le volte che la pronunzia semplice vuol essere rafforzata.
Credè il Muratori che fosse costume pe’ Napoletani il cangiare costantemente la V in B; ed un verso riferiva di certo Tedesco:
Felices quibus vivere est libere.
Dovea dire il contrario. Nel dialetto napoletano la B è quella che si cangia in V; la quale, se trovasi poi nella orte vibrazione di B trasformata, ciò avviene per legge gramaticale del dialetto. Del quale l’attenuazione del tocco articolare forma la condizione caratteristica; e siccome la gentile G non gutturale trasforma costantemente nella tenue J, ambo tocchi lingualo palatini; del pari la sonora B nella V, debolissimo tocco labiale, costantemente rammorbidisce: non altrimenti, negli ultimi anni della civiltà greca, il secondo elemento dell’alfabeto vita denominavasi: ed è naturai cosa che poi per più robusta vibrazione quella vita in bita o beta si rafforzi, come appunto lo stesso addiviene della J, la quale per più forte vibrazione, accostar dovendosi la lingua più prossimamente al palato, in GHI schiaccialo si trasforma.
Non progrediremo più innanzi nell’analisi delle lettere, della notazione cioè ai quelle prime vibrazioni articolari delle quali l’umana voce ha bisogno per trasformare un grido vago in una prolazione sillabale espressiva di un pensiere o di un affetto. Lettera per lettera nel Vocabolario può rinvenirsene lo sviluppamento.
LE SILLABE
Oziose e di utili conseguenze infeconde non sono queste minute ricerche per chi della volubilità delle voci umane fissar voglia quelle determinabili prolazioni le quali passar possono nella scrittura. Si è ben detto che con qualunque moltiplicazione di lettere ed altri segni diacritici non si giugnerà mai a tutte poter esprimere le minute differenziali della pronunzia non sol di nazione a nazione, ma di luogo a luogo, ed anche d’individuo ad individuo. Ottimo adunque sarà quell’ortografico sistema che ad un certo limite si arresti: ed ottima fu l’industria de’ nostri maggiori che alle sedici lettere carmentali, che poi con attenuazione alla greca si dissero cadmee e con maggiore attenuazione alla italica casmee, pochissime altre ne andarono aggiugnendo. Ma intanto di quelle attenuazioni appunto è indispensabile la ricerca per la storia delle voci umane ridotte a scrittura, non solo come rappresentatrice del fonismo della parola, ma come enunciativa di pensieri e di affetti senza tema di equivoco comunicabili. E sotto tal riguardo, ben dalle lettere vocali era da instituirsene la disamina, non perché mere voci, ma perché voci con diverso tocco articolare, benché lievissimo, pronunziate, e perciò capaci di formare da per sé una parola bastantemente caratterizzata e distinguibile, e rendersi di un tal pensiere, di un tale affetto, da un altro tal pensiero, da un altro tale affetto, una espressione differenziata.
Ma di ulteriori differenze abbiam d’uopo; e le vocali altre ne sommistrano da sé sole, sia nella loro combinazione, sia nelle semplici condizioni dalle quali non può prescindersi di tempo, di tuono, di vibrazione più o meno spiccanti. La comprensione di tutte queste parti integranti di una voce è ciò che i gramatici dissero sillaba.
Ed una sillaba, una comprensione tutt’insieme di articolazione, di voce, di tempo, di vibrazione o tempra più o meno spiccatamente pronunziata, non mai alla unicità di quelle parti integranti della sillabazione si riduce. Fate oscillare una corda armonica, e la prolungazione decrescente di quel tuono medesimo ascolterete: e nella emissione della voce umana sempre mai quella progressione decrescente non manca. Perciò i popoli rozzi, e conseguentemente le antiche scritture, sillabe precisamente monocrone e monotone non hanno, ed invece di A dicono e scrivono AE; FUE in vece di FU; e così vie via. Ma quell’AE, quello UE ben può considerarsi in una sola comprensione di tempo, in una sillaba sola. Ed ecco il dittongo.
11 quale non già nella sola voce, ma nell’articolazione altresì vuol essere considerato. Per quella J più o meno spiccante, per quella lieve articolazione della V che vi si unisce, vuol riguardarsi come un polittongo articolare; e nell’esempio a disegno per noi scelto, l’iniziativa quasi presentasi di un polittongo articolare, non esprimendo altro la F se non la fusione del tocco aspirante con la forte labiale in un sol carattere espresso: carattere di tarda data che i due primitivi caratteri comprende P, H; e quasi doppia aspirazione che digamma eolico fu dapprima denominato, riguardo alla figura; ma in sostanza lieve tocco del Ãáììá gutturale che fluisce nella sua profferenza toccando le labra, e con quella V si confonde per la quale sentì Claudio il bisogno di un nuovo carattere per l’alfabeto latino e con la doppia Ã, quasi F rovesciata,, volle espresso.
Per queste medesime considerazioni dai dittonghi ai trittonghi si fa passaggio, sia di voci, sia di articolazioni, con un solo o più d’un carattere esibite, ed in una sola comprensione, in una sola sillaba pronunciabili. Ed è da notarsi che dittongo alcuno non v’abbia del quale una delle vocali più attenuate I o U, che il Salviati a ragione denominava mezze lettere, non faccia parte.
Ma dalle condizioni, come dicevamo, non si può prescindere altresì di tempo e di tuono: condizioni che i graffiatici enunciarono con le parole di quantità’ e di accanto. I moderni ideologisti queste condizioni van riguardando ne’ soli rapporti tra sillaba e sillaba, mentre importantissimo è l’esame da instituirsene in una sola comprensione, in una sillaba sola.
LA QUANTITÀ E L’ACCENTO
Due sole condizioni nelle sillabe riguardo alla quantità li antichi gramatici distinguevano, quella di lunga e di breve: e tre soli accenti, il grave, l’acuto, il circonflesso. Perché quest’ultimo? dicono i moderni ideologi.
» Dal momento che il tuono, siccome ogni altra qualità, cangia in un suono, esso non è più il medesimo: e infatti gliene succede un altro, cioè gli succede un’altra sillaba fisica la quale aneli’ essa ha la sua articolazione, la sua voce e la sua durata, cose che tutte debbono essere specificate». Tracv. Ma qui non trattasi di sillaba fisica, ma gramaticale: e che voglia intendersi l’ideologo francese per sillaba fisica io non comprendo.
Come inopportune a me sembrano quelle cinque notazioni di tempo oltre alla sceva la quale per altro può venire anch’essa sempre di più in più ad abbreviarsi: e per quelle abbreviazioni di tempo precisamente la ragion degli acmi e dei gravi tuoni è stabilita e calcolata. Sono ormai nozioni trite e volgari che dalle 32 alle 16384 vibrazioni in un minuto secondo dal più grave al più acuto tuono si ascende in ragion musica valutabili, senza tener computo delle più lente oscillazioni che un rumor cupo ed invalutabile costituiscono come le più rapide uno stridore acutissimo fischiarne. Eppure, anche quel rumore, quelle strida, possono far parte della voce umana parlante: e, il ripetiamo, della voce umana in ragione di gramatica, non nella voce umana in ragion musica dobbiamo occuparci.
E bastano in ragion gramaticale le due sole condizioni di tempo e di tuono che gli antichi ponevano: pel primo, di lunghezza e brevità; pel secondo di acuto o grave accento: idee convertibili, e perciò con un solo seguo diacritico nell’italica ortografia espresso, e il quale per buona ragione non accento tonico ma bensì accento metrico venir dovrebbe denominato.
E qui non sembra inopportuno il ricordo della differenza che il bealo Agostino poneva tra la prosodia delle scuole e la prosodia della natura: la qual differenza darà ragione del perché molte sillabe che già furono lunghe or come brevi van pronunziale, e viceversa lunghe alcune altre che come brevi nell’artifiziato sistema delle scuole si stabilivano; del perché due o più sillabe antiche in una sola or si raggruppino, ed una sillaba breve non venga più inflessibilmente come a metà di una sillaba lunga a considerarsi. Brevità e lunghezza nella emissione della voce umana son parole prive di significato se quello non contengano altresì di più tenue o di più vibrata prolazione; e la parola accento negli odierni idiomi non altro che una profferenza esprime di maggiore vivacità al paragone delle altre. E tal forse n’era il vero concetto anche presso gli antichi per condizione necessaria de’ nostri organi della parola.
Due tempi, due tuoni, e sempre disuguali, in qualunque emissione della voce umana voglion considerarsi, quantunque fisicamente e musicalmente disuguali non sieno; e ciò dalla più semplice alla più complicata, dalla monosillabica alla sesquipedale, ed in tutte quante le combinazioni di essa, sempre mai alle ragioni dell’arsi e della tesi aggiogata: vale a dire, sia che una sola parola, sia che più parole, sia che più come, Aia che più versi comprenda l’espressione di un pensièro, d’un affetto, con emissione di voce più o meno complicata; si avranno sempre due condizioni valutabili per durata e per vigore, e sempre l’una ali’ altra subordinata, sempre l’una dall’altra diversa per energia di profferenza.
Per le quali considerazioni la ragion metrica si ristabilisce nell’italian verseggiare che comunemente vien riputato sillabico. E ci è grato rinvenire anche su di ciò nell’acutissimo Salviati analogia di pensieri.
» Tanti dittongi, ei disse, se l’uso della lingua posti gli avesse in opera, nel volgar nostro si possono pronunziare, quanti de’ suoni delle vocali fieno gli accoppiamenti, che a quarantanove aggiungono, s’io non sono ingannato… Ma che vero sia ciò che io dico di tanto numero di dittongi, può ciascuno accertarsene per se medesimo ne’ versi de7 poeti per entro alla parola, dove vedrà, che ad ogni suono di vocale un altro suono di altra vocale si può aggiugnere, senza che delle sillabe si venga a crescere il novero. E abbiam detto per entro alla parola: perciocché quelli che per dittongi tra voce a voce dal Trissino sono proposti, dittongi, per mio avviso, non son da riputare, posciaché in una sillaba non si pronunziano, come al dittongo è richiesto. Ma comporta la natura del nostro verso, quantunque d’undici sillabe, quanto alla regola, la sua misura sia, quasi per entro il suo corpo, il trascorso delle vocali, in guisa che dicendo:
Voi che ascoltate in rime sparse il suono,
non solamente non si pronunzia.
Vo’ ch’ascoltate ‘n rime sparse ‘l suono;
ma non è vero che il voi in una sillaba si raccolga, come alcuni hanno detto: ed a cui caglia di chiarirsene, pruovi a mandarlo fuori con ogni maggior lentezza in due sillabe, e mandatolo, fermisi eziandio con la voce, e faccia una lunga posa, e altrettanto adoperi nell’ascoltate in, e nello sparse il, e vedrà che non pure il suon del verso danno non patisce, ma ne divien migliore e più robusto e più bello».
L’applicazione di questi principi è da vedersi nel Vocabolario alle parole Quantità’, Accento, Versificazione, Periodo. Quello che ora importa al nostro scopo è l’osservare:
1.° Che con tante modificazioni che ricever può la voce umana nella sua più o meno complicata comprensione in una o più sillabe, si ha quanto basta per costituire un segno fonico enunciativo di pensieri e di affetti anche nelle più lievi minutezze differenziati;
2.° Che un sistema alfabetico qualunque sempre considerar dobbiamo come mera tachigrafia; e che nessuna industria ortografica provveder può ad esattamente esprimere la vera pronunzia del tale o tale altro popolo nella volubilità de’ dialetti, anche moltiplicando i tanti segni diacritici della vecchia e della nuova masora.
3.° Che conseguentemente, di nulla alterando il sistema ortografico adottato per la lingua nobile d’Italia, ad esprimere le differenze foniche del nostro dialetto è più che sufficiente l’ortografica industria adoperata dal Cortese, dal Capasso, dal Lombardi: con le sole avvertenze che la S avanti alle lettere mute, escluse le dentali, vuol pronunziarsi come uno scin; che nelle sillabe brevi, e mollo più nella fine delle parole, le vocali addivengono alquanto oscurette, e, non di rado nell’ultimo caso, precisamente una sceva; e che l’accento prosodiaco, ai modo latino, i Napoletani non protraggono al di là dell’antipenultima sillaba.
LESSIGRAFIA E SINTASSI
Dall’esame instituito sinora abbiasi veduto come mai le voci umane venir possano ad esser significative non di sole passioni o volontà vagamente enunciate, ma rendersi abili altresì, nella combinazione dalle varie articolazioni e modificazioni della voce, a variare notabilmente l’una dal1 altra profferenza in modo che, nelle sue numerosissime ma ben diffinite varietà, enuuciative si rendano delle più minute manifestazioni de’ pensieri e degli affetti umani. Or dalla possibilità ai fatti.
Quando l’acre ingegno del nostro Vico una lingua ideale eterna iva rintracciando alla quale tutte le umane lingue, antiche e nuove, si adagiassero; quella generosa strada rompea primiero che modernamente i più acuti ingegni della nostra età con piii o meno felice buona riuscita van calcando e ricalcando. Da prima lo studio delle lingue era opera, quasi direbbesi, di pedagogico dogmatismo: ora affrontar tali studi non è dato se non con tutta la forza dell’analisi alla vastità sublimata delle più sottili speculazioni. Ma tutta quest’opera dell’intelletto, che soltanto per novità di nomenclatura addivenir può astrusa e disamabile, è la più agevole, la più naturale, la più spontanea delle opere umane. La scienza del linguaggio da’ più rozzi popoli è con tanta felicità posseduta; tanta sublimità ed armonia di metodo, tanta industria e finezza di pensieri nel sistema gramaticale de’ più agresti parlari si rinviene: che i più acuti filosofi il più diffidi problema sempremai riputarono delle loro speculazioni quello di metterlo in accordo con la rozzezza e grossolanità de’ popoli che pur si dicouo di questo o di quel tale altro linguaggio inventori; e il loro stupore diminuir tentano, ora più antichi sapientissimi popoli fantasticando che dei volgari idiomi a que’ rozzi ed inesperti esser potessero in segna tori; ed ora, da insegnato » ad insegnato» sempreppiù addietro invan procedendo, nella necessità si quetano al fine di pur proclamare il primo tipo di qualunque linguaggio come miracol divino.
E al certo divin miracolo è quello che ci fa vedere nella più tenera età tutto ciò che forma la più sottile metafisica del linguaggio da’ più teneri fanciullini fra pochi anni nella lingua della nutrice simmetrizzato.
Or qual è questo amorevole modo che insegna ai teneri fanciullini il materno linguaggio? — Con troppa leggerezza si è detto esser l’uomo animai mero imitativo. No: egli è assai più di quel che si pensi e inventivo e ragionatore. La stessa ripugnanza che i fanciulli dimostrano nel seguire un insegnamento che sol si riduce a far loro apprendere una filza di parole cui legar non possono una distinta idea, quella stessa ripugnanza è il più valido argomento che l’intelligenza, suprema forza regolatrice di tutte le opere umane, con più o meno di energia sibbene, ma in ogn’istante della vita non manca giammai di esercitare il suo potere. La autrice indica al fanciullo un’azione, un obbietto; e poi dà loro il nome: e non avverrà giammai che la parola la quale il ricordo esprime di quell’azione o di quell’obbietto venga dal fanciullo dimenticata o invertita, comeché soventemente ad obbietti ed azioni analoghe la trasporti. Quindi è costante che, nella precision vera de’ significati, parlare e ragionare son la cosa medesima. Ma quel ragionamento esser non può da prima se non vagamente e nella sua generalità interpetrato. Quando divien determinabile e speciale, allora il parlare incomincia. Seguiamo la genesi di queste determinazioni: e tutta la teorica dell’umano linguaggio verrà spontanea a mostrarsi. a Distinguono i grammatici le parole in variabili ed invariabili; e quelle poi in declinabili ed in coniugabili: son declinabili i nomi, essi dicono, e coniugabili i verbi: invariabili le preposizioni, gli avverbi, ec. Noi tutte variabili le rinverremo, almeno per accidenti armonici di profferenza; e coniugazione poi rinverremo in tutte le parole polissilabe, e nelle monosillabe altresì non di rado inflessione, non già per mero eufemismo, ma non di rado per accidenti dilucidativi di significanza. Intanto, nel nostro proposito di non dipartirci dalla nomenclatura de’ gramatici antichi, seguiremo per lo sviluppameli to di questi nostri pensieri la serie da essi data delle varie parti dell1 orazione, permettendoci solo invertirne l’ordinamento.
PARTI DELL’ORAZIONE
INTERPOSTI. Delle primitive espressioni della voce umana di pensieri e di affetti vagamente enunciati, un residuo rimane in ciò che i gramatici chiamano interposti. E in molti di questi benanche i gridi primitivi si conservano e quel mormorar primitivo che il balbettar compongono e il gridacchiar degli individui e de’ popoli fanciulli. Ecco perché dagl’interposti incominciamo. Ma non intendiamo con ciò concorrere ne’ pensieri de’ recenti ideologisti; e non sembra che ben si apponesse chi volle definirlo essere l’interposto quella parola la quale esprime una proposizione compiuta. Perciocché, una proposizione ben compiuta esprimono le parole amo, leggo, seggo: e non sono interposti.
E a nostro credere, non sembra ben detto che gl’interposti non danno veruna regola di costruzione e di sintassi. Sono molto bene nella costruzione e nella sintassi di tutto il genere umano questi o altri modi simili: Ahimè ahi di te! ahi la coscia! E in quell’ahi v’ha l’espressione, sebben vaga, di una sensazion dolorosa nel suo generale e primordiale concetto, da potersi poi limitare ed attribuire ad alcune persone, ad alcuna parte di una persona, e ricevere vievia tutte quante le modificazioni possibili che ad un linguaggio è dato di somministrare ne’ diversi stadi del suo incivilimento.
E quelle limitazioni, quelle modificazioni non altrove che in alcune altre interiezioni si rinvengono che alle prime interiezioni si £congiungono, e che, sia isolatamente, sia fuse tra loro, tante parole significative vengono a comporre, le quali poi con certo metodo ordinate, un discorso esprimono agevolmente comunicabile ed intelligibile da uomo ad uomo.
Che importa adunque ciò che intender dobbiamo per una interiezione? Non altro che l’espressione di essere una persona o un soggetto qualunque nel tale o tale altro stato di passione, della quale sarà poi da limitarsi e definirsi il suggetto che il soffre, e poi tutte le altre circostanze di luogo, di tempo, e di modalità qualunque, con più o meno innoltrata analisi….
Ma la principal determinazione da farsi sta in quella di stabilire qual sia quel suggetto, quale la persona cui quel tale o tale altro stato attribuir si deggia.
PERSONE. E tre sono in tutti i linguaggi umani i suggetti,. le persone cui qualunque modificazione di essere nel tale o tale altro stato si attribuisce: 1.° la persona che parla, 2.° la persona alla quale si parla, 3.° la persona o la cosa di chi o ai che si parla: nomi primordiali ed eminentemente sostantivi in tutti gli umani linguaggi. Anzi unici sostantivi veri, de’ quali tutte le altre parole che diconsi nomi a mere più o meno ampie modificazioni sono da riferirsi. E l’inerenza di tali sostantivilà è tanto necessaria in una parola per esser nome» quanto necessaria è l’inerenza del sostantivo essere in una parola per esser verbo, come sarem per vedere.
E queste tre persone, sono le tre prime sostantività del discorso che PRENOMI direi non pronomi, come da’ nostri antichi vennero denominate. E ciò per la loro preeminenza e precedenza, nella genesi de’ pensieri, a qualunque altra determinazione di subbietto od obbietto al quale ai nome può darsi la significanza.
Naon è dell’attuale argomento l’andar viemaggiormente intrattenendoci su queste idee e tutta disvilupparne la teorica. Ma un cenno, a nostro avviso, non era da trascurarne per dar ragione del perché ne’ moderni idiomi, mentre delle declinazioni per casi manca la consuetudine, i pronomi se l’abbiano per designare con una parola sola il loro essere nelle condizioni di subbietto di abbietto, di rapporto in un’azione passione qualunque dalla interiezione (come da noi diffinita) ovvero sia da un tema di verbo designata. E ne avremmo anche fatto a meno se ci fosse noto che ne avesse altri sinora instituito ricerca.
NOMI. Ma perché gl Italici declinazione pei nomi non hanno? Sia un antico gramatico dilucidatore de7nostri pensieri.
» Le inflessioni possibili di ogni parola primigenia, dicea Varrone, sono nel dir latino intorno alle cinquecento: e questo novero potrebbe pur crescere al decuplo, al centuplo, all’infinito, se di tutti quegli affissi terrem cómputo quali al principio aggiungonsi delle parole. Utile e necessaria cosa fu al certo l’introdurre nel discorso le inflessioni: perciocché senza quegli amminicoli che danno tante diverse signifìcanze ad una voce primigenia, né tutte le parole che infinite pur sorgono in una favella avrem potuto rattenere, né delle rattenute le relazioni discernere e le dipendenze. Ma non ogni voce di tutte quelle cinquecento inflessioni è fornita: ché alcuna di esse porta col nascere originaria sterilezza, ed altra esser dee, secondo la varia indole dell’idioma al qual si appartiene, più o meno feconda. Chepperò diversa, e inegualmente copiosa esser dovea la guisa d’infletter le voci alla greca, alla latina ed alla ‘vernacola. Pertanto ottimo riputar si vuole quel gramaticale andamento, che ha lucide regole e brevi. E P infletter delle voci piii da natura che da arte si compone. Fa pur d’introdurre vocaboli nuovi: essi non cangeranno l’indole del linguaggio; il popolo darà loro tutte le inflessioni che potran ricevere, e cittadini diverranno. E noi veggiamo che de’ servi nuovamente introdotti in numerosa famiglia se fai conoscere il nome, comunque esso sia strano, già su le labbra di tutti quanti i conservi, con le inflessioni di consuetudine, il vedrai propagato. E se fallan talora, non è da far le maraviglie: forse i primi trovatori delle voci fallavano. Tenace è il”£opolo nelle sue antiche consuetudini di favella: e i nuovi ardimenti de’ poeti non lo sviano dal suo costante andamento. Si cerchi pure nella storia il nascimento e l’introduzione delle voci straniere: ma non si abbandonino le inchieste su i modi natii del linguaggio che quelle voci nuove adagiar fanno al sistema eterno delle analogie dal quale il popolo non si discosta giammai. » Cosi ragionava quel sagace: e i vari tratti che qui riuniti ne offrimmo alla meditazione de’ nostri leggitori, ci serabran bastanti a tutta comprendere la teorica dell’umano linguaggio ne’ diversi ordinamenti gramaticali che i vari popoli adottarono.
Dal vago delle prime enunciazioni di pensieri e di affetti non può giugnersi ad una determinazione senza che si vadano di mano in mano apgiugnendo altri segni, altre enunciazioni, altre parole in somma che nel progresso de’ linguaggi disviluppati si diranno aggettivi, si diranno particelle, si diranno inflessioni; ma che in origine non altro che tanti nomi esser doveano con un altro nome aggiogati. Stabiliti appena questi nomi differenziali, e determinati questi necessari amminicoli il linguaggio è formato, e co’ suoi caratteri specifici un gramaticale andamento procede. Altro non rimane che accrescerne il glossàrio.
E se lucide regole e brevi aver dee, per essere ottimo, un gramaticale andamento; a che que’ cinque casi de’ Greci, a che que’ sei casi de’ Latini? E prescindendo che, nella gran classe de’ nomi neutri, al bisogno di distinguere il subbietto dall’obbietto dell’azion del verbo non provvedevano; non di rado, nelle desinenze de’ casi di rapporto, inflessioni simili si adoperavano per esprimere idee diverse non solo ma opposte. Erano adunque quelle desinenze un lusso per dir così, una vana pompa del linguaggio: e conseguentemente i volgari adottar non le doveano. Ed adottar dico non conservare: perciocché nel sesto caso appunto, nel caso delle preposizioni, e sempre vocalizzante, per testimonio dello stesso Varrone le condizioni consistevano di tutti quanti i nomi dell’italico linguaggio. E tutta quanta la lessigrafia e conseguentemente la sintassi de’ popoli italici nelle coniugazioni si stabiliscono, vai dire in quelle particelle significative che ai verbi si congiungono ed ai nomi, e che tanto a proposito da Varrone denominavansi amminicoli del linguaggio.
Le quali particelle furon da prima parole intere, interiezioni nel senso da noi diffinite, per vievia andar manifestando e più o meno specificamente distinguendo il vario stato, le varie passioni o azioni, le varie apparenze delle tre personalità sostantive alle quali quello stato, quelle azioni, quelle passioni, que1 fenomeni sono da rapportarsi.
Si è detto molto a proposito avvenir delle parole come delle monete, le quali quanto più sono in uso e corrón frequenti nel commercio tanto più quell’impronta vengono a perdere che nell’uscir dalla zecca le Iacea spiccatamente distinguere. Ma v’ha dippiù. Nelle monete ‘rimane tuttavia la qualità del metallo da contraddistinguersi, la quantità del fino, il peso, e sempre qualche traccia dell’impronta; ma nelle parole la significanza di una inflessione, a una desinenza o d’un affisso in un elemento è da cercarsi talmente attenuato che non di rado ad una lettera, ad una maggiore o minor forza nel profferirla, al semplice spostamento dall’accento prosodiaco si riduce. Così appo i Greci bastò per caratteristica della designazione de’ tempi, nel loro complicato sistema della coniugazione de’ verbi, aspirar nel passato, sibilar futuro.
Ma prima d’innoltrarci alla speciale disamina di queste attenuate parole che in segni declinativi e coniugativi si trasformarono., è d’importanza determinare quelle condizioni di subordinazione e di legame senza le quali esser non vi può ordinamento, sintassi, nell’uman favellare.
L’ATTIVO E IL PASSIVO
Allorché l’antesignano della scuola Lochiana la sua sensiente statua al solo organo dell’odorato limitava, ed accostantola all’atmosfera odorosa di un fiore facea che sciamasse: Io odor di rosa; per la buona via nelle ricerche ideologiche si drizzava, ma il suo scopo non raggiunse. Non Io odor di rosa, ma IO dir può un essere pensante limitato alla sua prima sensazione: e alla seconda, non altro che io il qual sento, in relazione dell’io il qual sentiva.
La qual seconda sensazione ben della prima riproduce l’idea, ma dallo stato di attività a stato di passività trasformata: perciocché dell’io che allor sente, dell’io attivo, subbietto della sensazione, essere allora non può quell’io che sentiva se non un obbietto di paragone.
Ed in ciò e non altro è la sintassi., l’ordinamento necessario di tutti i linguaggi de’ figliuoli di Adamo. E non so comprendere come i filosofi del secolo decimottavo da questa ingenita condizione dell’uman genere ricedevano; e come, e mentre per essi tutto all’intorno della mente umana operava, questa sola a passività mera ridur volessero. Alla seconda sensazione, già può la mente nostra rentrar con sé stessa a parlamento, e la seconda persona alla quale i suoi pensieri rivolge spiccatamente si mostra; ed alla quale, a vicenda, la qualificazione di ’ attività può trasportare e la passività a sé stessa.
Ma se più oltre procede, non altro che di una terza sostantività può sorgere l’idea, e questa terza persona che il compimento a formar viene di un’azione qualunque, d’un qualunque pensiere, è quel massimo agente che ne’ linguaggi primitivi il tema determina di tutte le parole, e che del mondo fenomeno la più o meno complessiva immagine racchiude e la più o meno specificata determinazione, in tutte le grama ti che, in tutti i sistemi possibili di segni comunicativi.
Questa tripla personificazione, e non altra, la prima, la imprescindibile condizione a stabilir viene dell’umano linguaggio, e l’inerenza conseguentemente d’una specifica inflessione delle parole eminentemente significative di una nostra qualunque idea. Nella quale tripla personalità è l’inerenza del verbo essere, a buon diritto denominato verbo sostantivo, il quale inerente con quella tripla personalità si rimane in tutte le forme verbali, a buon diritto da1 nostri antichi denominate coniugazioni. E però nel solo verbo è il necessario legame di ogni umano discorso: tutte le altre parole a mere semplicissime modificazioni ulteriori vanno a riferirsi.
TEORICA. DEL VERBO
Molte idee la forma del verbo in una parola sola racchiude; ed è strano che i più perspicaci sieno incorsi nel difetto di non tutte andarle ravvisando, e molto più di non averne andato subordinando progressivamente l’importanza.
Con una stessa parola tre distinti attributi ha il verbo; 1.° di determinare una certa qualità di essere una persona o un obbietto qualunque f nel tale o tale altro stato; 2.° di esservi nel tale o tale altro tempo; 3.° di esservi o la persona che parla, o la persona a cui si parla, o la persona o altra cosa della quale o di che si parla.
Ma queste tre considerazioni non sono speciali ed esclusive dal verbo: perciocché al primo ufizio adempir possono tutti gli adiettivi; al secondo gli adiettivi stessi in alcuni sistemi di linguaggio; ed al terzo i prenomi personali. Sarebbe egli mai che nella sola riunione di questi tre requisiti consistesse la natura del verbo? Ma qualunque verbo al modo infinito manca del secondo e del terzo. Or perché mai i verbi al modo infinito non si confondono con gli aggettivi?—L’essenza, la caratteristica speciale del verbo è conseguentemente in quella qualità che gli aggettivi non hanno, nel formare cioè l’affermativa dell’esistenza, e il legame del discorso.
Per la qual cosa qualunque verbo si risolve nella comprensione tutt’intera delle seguenti idee:
1.° Affermazione di una esistenza;
2.° Indicazione di una esistenza nel tale o tale altro modo modificata;
3.° Indicazione di quella tale esistenza e di quella tale modificazione ne’ rapporti di tempo ed anche talora di spazio;
4.0 E modificazione in fine di tutto ciò nelle relazioni di chi parla, di chi ascolta, e della persona o della cosa su la quale o su di che il discorso si versa.
Noi abbiam notato tutte le considerazioni che in una espressione del verbo possono riunirsi; ma è agevole il vedere che non tutte queste qualità si riuniscono sempre in qualunque espressione del verbo. Le abbiam notate nella subordinazione d’importanza che hanno, e di che andar possono di mano in mano a sceverarsi, finché alla sola prima si riduca; la quale sola se venisse a mancare, la parola cesserebbe affatto di poter essere riputata come verbo.
E però, siccome nel concetto di qualunque parola, per divenir nome, includer si dee il concetto di sostantività di una delle tre personalità eminentemente sostantive ed uniche vere sostantive; cosi dal comprendere nel verbo l’inerenza del sostantivo essere non si può prescindere.
Dopo le quali considerazioni, non si cerchi che qui da noi si vadano raggruppando le varie nozioni di fatto che del sistema di espressione nelle varie lingue intorno a ciascuno de’ sopra classificati attributi del verbo ci fanno accorti. Assistiamo all’amorosa industria della nutrice per venire a parlamento col suo bambino; e limitandoci a quel tipo italico che tutte le lingue romane adottarono; semplicissima delle condizioni del verbo apparir vedremo la teorica, e spontanee le differenze si mostreranno che nelle inflessioni verbali dal comune aulico linguaggio il nostro dialetto caratterizzano} per sole condizioni di pronunzia determinate.
GLI ÀMMINICOLI DEL LINGUAGGIO
Per lungo tempo il colloquio infantile sarà un misto di cenni e monosillabi: ma in que’ cenni vi sarà la comprensiva tutta intera e P espressione del verbo che primitivo ne’ bambini è volere. E però il primo modo verbale non altro esser può se non quello che nelle scuole si denomina imperativo e che in tutti i linguaggi in espressione monosillabica si rinviene o a’ monosillabi inchinante.
Ma quella volontà aver dee uno scopo, un obbietto: come indicarlo? Ed ecco che il bambino sporge l’indice della sua manina: e lo scopo, l’obbietto del suo desiderio manifesta. Così scorge 1’articolo precedente e qualunque nome; originario e primordiale segno comunicativo ai tutti i linguaggi, ed unico indispensabil mezzo per dare un nome agli obbietti.
Torniamo al contillachiàno Io odor di rosa Indubitatamente quella statua sensiente non sarà affetta dalla sensazione di odor di giacinto; ma quella sensazione di odor di rosa, comunque dalia rosa occasionata, per trasformarsi in prima idea e divenire un segno rammentativo, dal tutto insieme del suo sentire la mente umana può trarlo e dal sentimento di piacere o di dispiacere sarà caratterizzato; e se un nome vuol dargli, dirà un nome qualunque; ma il qual dica: Io piacevole o dispiacevole odore: ed anche più genericamente io bene, io male. Queste parole che poi si diranno astratte, son le primitive e direttamente formate.
In gruppo, e non altrimenti sorgono i concetti umani; e quel gruppo di concetti render non si possono comunicabili se non con quelle vaghe ed indeterminate espressioni che la poetica costituiscono di tutti i linguaggi primitivi. Di qui tutta la ragion de’ traslati. V. nel Vocabolario questa voce. E di qui la vera analisi delle varie parti dell’orazione, e il loro ordinamento, la loro sintassi.
Tornino il bambino e la nutrice a parlamento: — Voglio, — Che vuoi? — Là… No… là… più là… più qua… Così e non altrimenti un bambino si esprime. Sarà diverso da idioma ad idioma il fonismo delle parole: ma il concetto sarà sempre lo stesso: ma sempre saranno quelle parole le prime ad appararsi.
E se dalla semplicità delle coniugazioni l’antichità dei linguaggi desumer si volesse; antichissime dobbiamo riputar quelle lingue nelle quali troviamo tre sole notazioni stabilirsi per la distinzione de’ tempi, il passato, il presente, il futuro: e un solo movimento pel presente e pel futuro dal passato, d’onde il tema del verbo: perciocché, dare un nome non si può ad un’azione, ad un obbietto imporlo, se prima nel passato non siasene determinata l’idea. Avrà i numeri duali, quanti appunto ne bisognano tra i due che concorrono a formarsi un linguaggio, un sistema comunicativo di pensieri e di affetti nella tale o tale altra maniera. E per mezzo di affissi e terminazioni non solo le tre distinzioni personali vorrà esprimere, ma nelle prime e seconde persone il mascolino dal femminile distinguere, ed alle sole condizioni di attività, di passività e d’intransitività non restarsi, ma le qualità comprendervi altresì di luogo e di strumento.
Tutte queste cose ben connetter si possono nella infanzia del linguaggio degl’individui e delle nazioni. E non altrimenti nel linguaggio infantile tra la nutrice e il suo bambino succede. Tutte le parole son generiche: qualunque cibo è pappa: qualunque bevanda è Lobo; qualunque cosa che piaccia o che dispaccia, è una bella, una brutta cosa. E ben disse il Vico quando disse che in questa sola parola cosa è tutto intero il vocabolario dell’infanzia degl’individui e de’ popoli. Sintetizzante nasce ogni umano linguaggio: vengono assai tardi le analisi.
E non sembra regolare quel procedere analitico che tutto il discorso umano vorrebbe far consistere nell’espressione di un’esistenza che si afferma negli obbietti esteriori, ed in relazione quasi esclusiva degli obbietti reali del mondo fisico. Tutta l’opera interna dell’intelletto e del cuore è ciò che forma l’essenzial parte della favella; e tutti gli oggetti esterni altro rappresentar non possono nel discorso se non occasioni di connettere il mondo fenomeno colle leggi invariabili della intelligenza e della volontà secondo le norme che l’Eterno prescrisse per qualunque operazione de’ figliuoli di Adamo. Ecco perché tutti gli umani linguaggi nel loro gramatical procedere presentano analogia non solo, ma identità. Ed ecco perché in tutta la verità della espressione fece l’Alighieri che quel primo padre dicesse;
Opera naturale è ch’uom favella; intanto con tutta verità faceagli poscia soggiugnere:
Ma così 0 così natura lascia.
Poi fare a voi siccome che vi abbella.
Le forme gramaticali, tutta la sintassi del discorso, sono necessaria cosa e da natura fluente; è poi umana cosa e variabile che le parole rappresentative di quelle forme vadan diversificando da popolo a popolo.
Ma se legge del pensiero è ravvisar gli oggetti nelle condizioni di tempo e. di spazio; di connessione o isolamento; e nell’imprescindibile legame di cagioni e di effetto, e conseguentemente di possibilità, di similitudine o dissimilitudine: e tuttociò nelle considerazioni di maggioranza o minoranza più o meno ravvicinate; è legge altresì del cuore determinare la volontà pel bello o pel buono; di espandere il proprio essere, con generoso desiderio di connettere col proprio l’altrui bene, e di rimuovere da sé e da’ suoi tutto ciò che render si possa cagione di odio e di spregio.
Tutte queste condizioni in quelle particelle si rinvengono, le quali sia per affissi, sia per desinenze, sia anche per parole distaccate, in preposizioni, avverbi, congiunzioni, desinenze significative si cangiano nel dottrinale andamento delle scuole, e parti subordinate dell’orazione vengon considerate, mentre al contrario non altrimenti che principali e primarie determinazioni considerar si vogliono, e, come tanto a proposito le denominò Varròne, veri amminicoli del linguaggio. Quando di tali amminicoli si possiede l’integrità; il linguaggio è formato: altro non rimane se non la nomenclatura: e questa non è più opera di gramatica ed appartiene tutta intera al glossario.
Ora, prescindendo dagl’idiomi troppo da noi lontani, se la maggior parte di tali amminicoli è fusa quasi nelle lingue romane; nelle germaniche ne appaiono evidentissime le commessure: ed affatto isolati si mostrano nella lingua inglese, nella quale quasi tatti il loro significato intiero ne presentano. Son pregevoli gli antichi linguaggi per quelle industriose fusioni; ma nella disviluppata civiltà, come far che una parola sola tanti elementi contenga per quante diverse significanze esprimer si vorrebbero? Quegli affissi, quelle desinenze di più in più sempre mai si andranno a contrarre, e a trasformarsi in quelle erose monete che non hanno più corso: e però limitar sen dee quanto più ristrettamente sen possa la circolazione. Ed ecco il complicato schema degli antichi verbi greci, ai meri bisogni ricondotto nel greco moderno: ecco lo schema latino negli odierni romapi idiomi a semplicità prodigiosissima armonizzato. La quale semplicità non apporremo a difetto: non diremo per quella men lucide ed efficaci le odierne loquele. Nella semplicità della lessigrafia inglese armonizzava un Newton un Dryden i più sublimi concepimenti dell’intelletto, le più soavi emozioni del cuore.
Ma dall’altro canto, quella simmetrica disposizione delle parole, quel ritmico andamento, quella musica del linguaggio che tanto più si mostra quanto più sono men culle e disviluppate le loquele, certe giunte e sottrazioni e permutazioni nelle parole introdusse le quali a mera insignificante prolazione si riducono, e non di rado a certe lussureggianti sillabazioni che molto a proposito ripieni i nostri gramatici denominarono. Non son questi da considerarsi tra que’ varroniani amminicoli del linguaggio in ragione di significanza, ma semplicemente in ragione di mera eufonia; e per ciò che riguarda differenze tra il comun linguaggio e il dialetto napoletano e gli altri italici dialetti, gli esempi ne abbiam raccolto agli articoli AFERESI, SINCOPE, APOCOPE, PROTESI, EPENTESI, PARAGOGE, E METASTESI, ché se in tali eufoniche diminuzioni ed aumenti e spostamenti articolari tutta le ragioni si determinano delle anomalie che nelle coniugazioni do verbi il dialetto presenta, ed in tutte le desinenze lessigrafiche de’ nomi e delle altre particelle significative che il dir napoletano compongono; per doppia cagione dobbiam di esse più studiosamente occuparci, onde tutti insieme diffinirne l’individua caratterisca, e spianar la via onde più agevolmente ricondurlo alla nobiltà di quell’aulico linguaggio del quale ben può dirsi l’origin prima e dal quale tanto poco e per sole condizioni di profferenza si discosta. Perciocché, cóme sarem per vedere, se mai facciasi astrazione dalle varie industrie ortografiche in vari tempi adottate per esprimere con la scrittura quelle minute diversità di suoni che qua e là si ascoltano ‘iiel profferire articolazioni similari; non solo tanta diversità di dialetti verranno a disparire, ma un modulo comune verrà quasi spontaneo a presentarsi cui tutti i dialetti adagiar si potrebbero.
Giunti a questo termine della nostra analisi, parrebbe che tutto ciò che credevamo premettere al nostro Vocabolario, per quel che importa pronunzia, ortografia, lessigrafia e sintassi, bastar potesse, rimettendone lo sviluppamento alle parole gramatica li nel Vocabolario inserite, tanto maggiormente perché ci abbiam fatta la legge di esibirle come appunto comunemente si adoperano ne’ rudimenti. Nulla di meno el sembra pur d’uopo che dalle generiche riflessioni a qualche cosa di speciale si discenda. Ma per ciò fare con minor dispendio di parole, vengano i soli fatti a presentarsi: e ben pare che non più pel già corso e ricorso campo delle generalità ci convenga tuttavia raggirarci.
BELLA FORMA MATERIALE DEL DIALETTO NAPOLETANO
Dà quegli amminicoli varroniani della favella è d’importanza iniziare la nostra ricerca; e lo stesso Varrone, il qual ci fece testimonio della esistenza di una lingua vernacola contemporanea al greco ed al latino, venga egli stesso insegnatore della caratteristica differenziale di quel ch’ei disse vernacolo linguaggio.
» Le fondamenta delle analogie, diceva egli, o dalla volontà degli uomini, o dalla natura delle parole si a voglion ripetere, o dall’una e dall’altra cosa insieme. E volontà dico essere la imposizione delle voci; natura, la declinazione alla quale senza dottrina si discorre… E con tale industria dai retti casi gli obliqui dagli obliqui i retti, e dai singolari le moltitudini e dalle moltitudini i singolari non di rado ricuperar si possono. Quella via pertanto precipuamente è da seguirsi nella quale n sia fondamento da natura; ché là, nelle declinazioni, ii la ragione è più trita. Perciocché di leggieri si scorge ii potersi andare in fallo viemaggiormente in quelle imposizioni che per lo più nei retti casi singolari si fanno da imperiti uomini e dispersi i quali parole impongono i alle cose comunque non ragionata volontà invitolli. Natura però e di ordinario per sé fluente quando non sia che ignoranza di consuetudine la depravi. Per la qual cosa se nei naturali casi piuttosto che negl’impositivi il principio di analogia si riponga parecchie cose nelle consuetudini si chiariranno, e quasi da natura le inconsiderate volontà dell’uomo verran corrette, non da queste quella; chepperò per la mala strada si rivolgono quei che a seguire imprendono le imposizioni. E dai singolari avviandosi, dal SESTO CASO convien prendere le mosse, perocché quello è caso proprio: E I LATINI ALTRO CASO NON HANNO. Conosciute che avrai quelle differenze delle lettere, più facilmente la varietà delle altre apparar potrai; perii ciocche quelle differenze alle uscite si riducono o in A come ab hac terra; o in E, come ab hoc lance; o in I, come ab hoc levi; o in O, come ab hoc caelo; ii ovvero in V, come ab hoc versu. Per lo che, a chiarir le declinazioni, questa una strada te ne dà due.»
Quella cioè del latin letterato e del latino vernacolo.
Che un tal latino vernacolo sia quel medesimo che ne’ ludi istrionici e negli esodi atellani faceva la delizia del popolo romano anche ne’ più bei giorni di sua floridezza vedremo in appresso. Per ora basti averne ravvisato la caratteristica in quel caso eminentemente latino che i Greci non ebbero, che si disse e fu caso delle preposizioni con le quali all’uffizio di tutti gli altri casi si suppliva, e che indifferentemente anche dagli elegantissimi scrittori nel dir letterato si adoperava, come nella sua acroasi il dotto Ciampi fece dimostrazione nel proposito di provare che almeno dal sesto secolo della nostra Era la lingua italiana fosse già bell’e formata. Ma con le trascritte parole di Vairone, non so come da altri non avvertite, l’esistenza dell’italico idioma vuol ritrarsi ad epoca più assai lontana. Ed in fatti, riducete al caso delle preposizioni il latin letterato; e l’italiano sorgerà tutto intero senza que’ contorcimenti che il dotto scrittoi’ pisano andava con somma dottrina ed ingegno proponendo.
Or la condizione di conchiudere ogni parola con una vocale, si estende nel dialetto napoletano ad ogni sillaba, come abbiam cennato di già, e come andrem vedendo vie via. il che vieppiù si dimostra nel giuoco delle particelle, e nel sistema lessigrafico de’ verbi.
Del quale, a legge della profferenza napoletana, è come segue lo schema.
ANNOTAZIONI
(a) Ecco forme semplici, ecco forme composte: ma ecco insiememente evidentissima nella forma del futuro la composizione dell’infinito con l’ausiliario avere, il che è comune a tutte le lingue sorelle del mezzogiorno di Europa co’ dialetti loro. Ed è notabile che anche nel latino letterato manifeste di una tal composizione appaiono le vestigie. jémabo, docebo son mere contrazioni di AMAre haBeO, DOCEre haBeO: e che l’altra forma de futuri latini in AM ed IAM sieno mere attenuazioni delle età più gentili, gli arcaismi il dimostrano che il gramatico Nonio Marcello trasse dai primi poeti Nevio, Pacuvio, Ennio, Afranio, ed anche Plauto, come ad esempio expedibo, audibo, aperibo, dìcebo, obedibo, redibo, venibo, ec.
Le desinenze che qui appaiono manifestamente parole intere, nelle altre forme che diconsi semplici vengono ad essere alquanto oscure per sole attenuazioni, delle quali la stessa forma del futuro dà incontrovertibile esempio nella prima e seconda persona del plurale: ed è chiaro che immo ed ite altro non sono che aferesi di avimmo, acuite: aferesi precedute dalla sincope della V, essendo tuttavia in bocca de’ nostri volgari le parole aimmo, aite, come dagli. esempi da vedersi nel Vocabolario alla parola avere.
É qui da notarsi altresì la costanza nell’infletter dell’infinito sempre in ARR benanche nel modo desiderativo amARRia, diciARRia, sentARRia; il che ad altro genere di ricerche ci condurrebbe se ci fosse dato più ampiamente dilungarci. Giova intanto colla maggiore brevità possibile enunciarle.
È noto che nella greca lessigrafia i verbi cosi detti meri ii, e i passivi, hanno una special forma. Ben può dirsi dall’altro canto che le inflessioni latine de’ verbi in ARE esser potevano applicabili ai soli attivi, ed ai neutri o neutri passivi le altre. Certo è che nell’italiano se un verbo prende le varie forme all’infinito di ARE e di IRE, risvegliasi l’idea dell’attivo nelle prima, di neutralità o intransitività nella seconda. Prescindo dall’eccezioni. Or quella forma in EMI, cui la desinenza de’ futuri in AM tanto prossimamente si accosta, darebbe ragione della sostituzione dell’ausiliario essere che all’ausiliario avere si sostituisce nel passaggio dall’attivo all’intransitivo.
Ma v’ha di più delle forme verbali greche e latine, con le forme degl’idiomi orientali non è da tacersi l’analogia.
Disse Varrone:
» Quod aiunt analogias non servare in temporibus, cum dicunt lego, legi, legam, et sic mille alla (nam quae sunt ut legi Perfectum significare, duo reliqua legam et lego Inchoatum) iniuria reprehendunt. Nam, ex eodem Genere et Divisione idem verbum quod sumptum et per tempora traduci p€test: ut discebam, disco discant, et eadem PerfecU eie didiceram, didici didicero; ex quo licet scire verborum rationem constare. Sed eos qui Trium Temporum verba pronuntiare velint, scienter id facere scire licet. De L. L. VIII, 54. Non solo da nessuno de’ nostri gramatici questo passo venne illustrato, ma ne’ lessici altresì le parole gramaticali che qui si producono non ancora ebber sede nel loro tecnico significato.
Intanto ecco la teorica de’ verbi latini presentata da Varrone nel modo identico che la presentano gli orientali, gli arabi ad esempio, Perfectum et Inchoatum
(ma’ zin va moza iron); e son mozarei ii futuro e il presente. Del che agevole è l’intelligenza.
Per considerazioni ideologiche: la designazione di un’azione, di uno stato, dì ciò in somma che può venirci indicato da un segno verbale, potrà sibbene riferirsi al presente e al futuro; ma il suo concetto raggirar non si può se non sopra un’idea, una sensazione se così vuoisi, già rii {finita, e perciò preesistente alla formazione o alla comunicazione del segno indicatore di quella tale idea, di quella tale sensazione. Ed ecco perché tutti i temi gli orientali trassero dal passato, Perfectum,
Or le applicazioni di quel segno al presente, al futuro, altrimenti concepir non si possono se non come un trasferimento del primo concetto, un moto all’attività. Inchoatum,
(b) Ordinariamente tutte le forme verbali all’infinito sono apocopate. E perché per indole del dialetto la parola col chiuder si dee in vocale; non la sola R, ma l’intiera sillaba RE si tronca. È notabile che i Latini anche io tal modo abbreviavano l’infinito del verbo sostantivo, e dissero esse j prodesse ec. E per rafforzare le riflessioni da noi prodotte nella nota precedente, e da notare che tutti i verni della seconda classe non di rado prendono la forma apocopata dell’infinito in ire, come metti, remmanì, tenì, ec in vece di mettere remmanere, tenore.
(c) L’uso de’ partecipi in -ante e molto più in-ente, è rarissimo nel giaietto,,..
(d) Oltre alla desinenza nella 2. p. del sing. Dell’indic. v’ha un’attenuazione nella penultima vocale con questa legge: L’E si cangia in IE: L’O si cangia in U. Come da prEgo, prIEghe: da tOrno, tUrne, ec.
(e) Si notino le desinenze MO, TE, NO, le quali rimangono costanti per designare i plurali quando la parola è piana. Ma nelle desinenze sdrucciole ricevono un cangiamento nelle seconde e terze persone, tramutandosi la TE m UO, e la NO in RO; comunque quest’ultimo, cangiamento sia più volontario che necessario.
(f) Oltre al modo d’inflettere i verbi nelle 1. e 2. p. del pi. dell’imp., è notabile l’inflessione del verbo essere la qual varia in modo da avvicinarsi quasi a quella del verbo andare (annare), anch’esso ausiliario ad esprimere un’azione contemporanea. Di qui le frasi di andar facendo, dicendo, ec.
(g) Come nel latino, come nei comune italiano, le inflessioni de’ preteriti sono spesso eccezionali dalle ordinane che qui si notano: il che andremo ne luoghi opportuni indicando nel vocabolario. Or basti qui avvertire che delle due desinenze delle prime e terze persone al singolare (da estendersi anche al plurale con le aggiunte caratteristiche segnate in corsivo), più elegantemente quella in te appartiene alla 1. coni, e l’altra in ite alla 2. La quale, mentre dal comune italico più si scosta, riunisce viemaggiormcnle il dialetto napoletano al latin letterato la cui caratteristica nelle 3. p. (primo tema de Verbi orientali) era la T.
(h) Negli imperativi le attenuazioni dispaiono di che e parola nella nota (d)….
(i) La costanza delle desinenze nel modo potenzia si ha benanche nel comune italico; v’ha intanto questa attenuazione nella desinenza dell’infinito, che qui entra evidentemente in composizione, cangiandosi l’A in E. Ma cosi non fecero gli scrittori antichi i quali, non solo ritennero l’A nella 1. coni., ma seguirono non di rado la pronunzia dorizante napoletana eziandio nelle altre. Ed anche ora scrivesi e pronunziasi sarei e non aerei..
(k) V. le note (a) (i). E vuol notarsi che anche il greco moderno, dismettendo l’antica forma verbale ne futuri, adopera l’ausiliario
(volere), uniformemente al modo teutonico e non alieno dal fraseggiare di alcune plebi delle nostre provincia. Il che per altro non era modo inusitato anche appo gli antichi eleganti scrittori; e basti rammentare per tutti l’elegantissimo Anacreonte.
(l) Non molto a proposito alcuni gramatici queste forme composte chiamano aoristi; V. queste voce nel Vocabolario. Alle considerazioni di tempo ne’ suoi primi concetti, anche quelle aggiugner conveniva de’ tempi relativi. Ed ecco l’industria di esprimere tali relazioni or con affissi, or con sopraddizioni, ora con troncamenti, appo gli antichi; e ne’ moderni, con particelle ed ausiliari. – Del resto l’uso degli ausiliari non era insolito nel bel dire del latin letterato. Per ausiliare avere, prescindendo dai comici, ecco nel solo Cicerone: De Caesare satis dictum habeo (Phil. V, c. pen.) Habeo domita- libidines (de Orat. c. 43, Ad Brut. ep. I. t. IV) Bellum habere indictum Diis (Verr. VII, sub fin.); ec. E per l’ausiliare essere, oltre alla doppia maniera nel dir letterato per esprimere la stessa idea, amor, amatus, sum; amabar, amatus eram; antabor, amatus èro; tutti i perfetti non aveano inflessione e col solo soccorso dell’ausiliario si componevano.
ALTRE INFLESSIONI LESSIGRAFICHE
Del pari che nel comune italico idioma ritiene il dia letto napoletano quasi la totalità degli affissi e di quelle desinenze significative le quali aggiunte a un tema ne modificano variamente il valore. Degli affissi sarà discorso ne7 luoghi opportuni del vocabolario: l’ordine alfabetico ne rende agevole la ricerca. Delle desinenze diremo qui ciò che v’ha di più essenziale.
E noteremo dapprima che sono esse non solo quelle medesime che nel dir latino letterato si ritennero, ma identiche quasi alle altre ancora che ne’ monumenti si mostrano delle antiche lingue d’Italia.
– EIARE
– IARE. Con questa forma qualunque nome diviene un verbo, e qualunque verbo un frequentativo. Il nostro popolo è ingegnosissimo in tali formazioni, come da tabbacco, Posilleco, ec. tabbaccheiare, posillecheiare, ec. Si noti che l’-eiare e l’-iare non hanno altra differenza se non nel dittongo si che talora si pronunzia col suono delle due lettere, talora colla semplice attenuazione della. Mentre nel napoletano si ha un avvicinamento maggiore alla desinenza de latini, “nel comune italico si rinforza in – eggiare, o alla greca in – izzare.
– iscere. Questa forma verbale si ha, del pari che nel comune italico, nelle sole desinenze de’ presenti de’ verbi di doppia uscita. Ed era da dismettersi per gli altri tempi perché il significato di tal desinenza vien dritta mente dall’antico verbo – hiscere che importava principiare un’azione; e perciò molto a proposito i verbi latini in – iscere, escere, ascere, scere si dissero incoativi dagli antichi gramatici.
Le altre inflessioni de’ verbi come – icchiìare, – illare ec. sono assai rari nel dialetto, e quasi italianismi introdotti da pochi scrittori. Certo è che non si rinviene nelle costumanze del popolo.
– ale. Antichissima è in Italia una tal desinenza, com’è manifesto ne’ monumenti osci ed etrusci; ed importa costantemente un’appartenenza, una derivazione, e certamente in origine la qualità di figlio del tema al quale si aggiugne.
– orio. È notabile questa desinenza nel dialetto perché, distaccandosi dal significato antico che indicava sempre un’idea d’istrumento, di mezzo, altro or non esprime se non quantità grande del tema al quale si unisce, come ventorio, abbaiatorio, ec. importa il molto soffiare de venti, il molto abbaiare de’ cani.
– uro. Questa desinenza che nel latino formava la serie de’ participi futuri, nelle lingue volgari dismessa, si conserva tuttavia nel dialetto, ad indicare la qualificazione d’un’azione futura, di un’istrumento da poter servire a ciò che nel tema viene indicato. Cosi adoperò il Basile la parola nzoraturo, scrissero i nostri cronisti apreturo; ed è in bocca del popolo stregneturo, torceturo, pesaturo ec….
Delle altre desinenze con picciola varietà di attenuazione sillabica, ma del resto non dissimili da quelle ritenute nel comune italico linguaggio, facciam di buon grado reticenza. Ma non è da tacere la varietà delle desinenze de’ plurali, con le quali anche quelle connetteremo della formazione de’ feminini.
Desinenza costante nella formazione de1 plurali è l’ultima vocale E: le variazioni sono nella penultima.
| – ATA f. |
pl. ATE |
Desinenze de’ partecipi passati |
| – ATO m. | ||
| – UTA f. |
pl. UTE |
|
| – UTO m. |
o passivi. La regola lessigrafica è costante anche pei nomi che non sono partecipi, come annata, prato, asciata, futa, ec.
| – ANTE | Desinenze de’ participi attivi, comuni ad |
| – ENTE |
ambo i generi: la prima è indeclinabile nel dialetto anche per numero; la seconda è indeclinabile nel plurale anche pe’ nomi feminili, ma pei maschili si cangia in – iente.
Questa regola lessigrafica è costante per que’ nomi altresì che non sono partecipi come fante, gente, dente, ec. come anche pe’ maschili con la desinenza in – entq. E perciò da commento, argomento, ec. commiente, argomiente, ec.
– ESE. Indeclinabile pe’ feminili. Ne’ maschili il plurale è ise, come toscanese, calavrese, ngrese, nel plurale toscanise, calavrise, ngrise ec.
– ONE; nel plurale — une. Cosi da raggiane, briccone, ec. raggiune, briccune, ec.
– OCCOLO: nel plurale — uoccole. E perciò da vroccolo, sproccolo, ngnoccolo ec. uruoccole, spruoccole, ngnuoccole ec.
– USO, nel feminile OSA. Si cangia nei mascolino in uso, nel feminile in OSE. Come da aanciuso, cianciuse, e nel feminile da cianciosa, cianciose. Questa desinenza ordinariamente riceve il vezzeggiativo in ilio ed ella, che nel plurale divengano ielle ed elle. E perciò da cianciosillo, e cianciosella si ha clanciosielle, e ciancioselle.
– ETTO, nel plurale IETTE come da sonetto, pozonetto, ec. soniette, pozoniette. ec. — Questa desinenza riputar si vuole nella formazione dei diminutivi rarissima non solo, ma inusitata nel dialetto, nel quale si adopera in vece il vezzeggiativo in illo ed ella, o coll’attenuazione in ielo né mascolini. I quali vezzeggiativi si legano ai sostantivi ed ai participi passati; e perciò prendono d’ordinario nel primo caso anche la T o la C; come da scanno, scannetiello; da limone; limonciello; ec.
– ORE. Si cangia nel plurale in URE come jelore, ammore, cosetore, ec. danno Jelure, ammure, coseture. ec.
È da notare che nella formazione de’ plurali feminili accompagnati dall’articolo le, se la parola comincia da consonante, questa lettera vuol essere rafforzata; se da vocale vuol rafforzarsi l’articolo. Regola costante ed invariabile. Così la varca, e le barche la jolla, e le ghiotte; la casa e le ccase; la devozione, le ddevoziune.
E da notare che la stessa regola osservar si dee quando si adoperino gl’infiniti de’ verbi per nomi sostantivi: come lo bedè, lo ghiurà, lo ccontà, lo ddà, ec.
Ed è da notare finalmente che nel dialetto v’ha due modi per distinguere l’obbietto della proposizione del subbietto: 1.° col far uso della preposizione A nel modo stesso che l’adoperavano i Latini quando alternavano indifferentemente o il terzo o il quarto caso con quella preposizione; 2.° col rafforzare la prima lettera del verbo, o l’articolo quando la prima lettera fosse vocale; com’è da vedere nel Vocabolario agli articoli si, Segnacaso, sé doppiamente delle consonanti.
E questo è ciò che credevamo premettere al nostro vocabolario relativamente all’indole speciale del dialetto napoletano. Rimane ora a considerarne le vicende, ed esporre insiememente lo scopo del nostro lavoro.
DELLE VARIE FASI DEL LINGUAGGIO ITALIANO E DE’ SUOI DIALETTI
Non fu al certo mio divisamento nel dare opera alla compilazione di un Vocabolario Napoletano quello di arrotarmi sotto l’errata bandiera che il Galiani inalberava tra noi nel proposito di far dimostrazione che la loquela del nostro popolo sia di tale venustà e lindura da gareggiare non solo ma primeggiare di qualunque altra al paragone. No; non entrava giammai ne’ miei pensieri tanta insania: e, comeché sempre care pur sieno ed esser deggiano le patrie cose, e il non averle in pregio, e molto l’invilirle, sia sempre di non generoso animo argomento; pure fermo è il mio proponimento nel credere di ogni orgogliosa gara incivil cosa le improntitudini, e nelle idee del Galiani non solo impossibile, ma disastrosa benanche se mai sen conseguisse la vittoria. Perciocché non vi ha tra le loquele delle varie razze italiane tal vezzo natio,
Tra quei che un muro ed una fossa serra,
il qual manchi di speciali grazie e leggiadrie, e di certo indefinibile non so che, del quale invano andresti altrove a ricercar l’equivalente (1).
Ma in tanta varietà di tutte belle, di tutte care familiari loquele, tutte d’una stessa madre riproducono il sembiante; vario sì, ma non diverso, e quale a sorelle si addice.
Onore all’Italia ed alle sue cento città! In esse, nessuna esclusa, vagheggiava quel santo petto dell’Alighieri l’ideale di quel comune italico linguaggio che fu e sarà in eterno il distintivo delle nostre regioni: e ci è grato il rammentare che al grande animo del nostro Federigo Ruggieri, sen dee assai più che l’iniziativa. Scopo di un vocabolario di dialetto esser dee la popolare istruzione; della quale non ultima parte vuol riputarsi l’addestrare le varie plebi all’unità di un idioma renduto illustre dal concorso del più bel fiore degl’italici ingegni e che si scrive non solo ma si parla nelle oneste brigate, per ben otto secoli, dal primo sasso delle Alpi sino all’ultimo scoglio di Sicilia.
E di questa comune favella io mi propongo richiamare l’attenzione de’ leggitori alle origini prime, alla ingenuità di filiazione de nostri dialetti, onde più agevolmente rannodare, per dir così, quasi d’una smagliata catena le sparse anella.
Tipo primitivo degli umani linguaggi
Dopo le dotte cure de molti e laboriosi scrittori che le tracce seguirono dell’eruditissimo Bochart, agevole ormai sarebbe il raggruppare ad un tronco unico i vari sistemi di loquela delle umane generazioni. Il primo germe e l’embrione quasi di tutte le granitiche è nella legge del pensiere e del primitivo modo di comunicarlo, unica nella sua iniziativa per tutti i figliuoli di Adamo.
Non credo che v’abbia giammai chi si persuada essersi potuto degradare a tal segno l’umana razza da ridursi a muto e turpe bestiume (mutum et turpe pecus) Anche nelle classi più basse l’animai broglia; e non mai tanto coverto da non venire inteso dagli altri della stessa specie ed anche abbastanza interpetrato da quelli di specie diversa;
Sì che l’affetto convien che si paia
Per lo seguir che face a lui la’nvoglia (2).
Ma progredendo di mano in mano, alcune voci spedali hanno anche i bruti. Perché, giunti all’uomo, essere eminentemente sociale, obliterar si potrebbe la più squisita delle sue sodali facoltà, quel dire articolato che a lui solo il Creatore concesse? Adamo dava il nome a tutti i prodotti della creazione: ma la legge d’imporre que’ nomi, la legge delle onomatopee, era nelle condizioni con che il Divino Artefice l’aveva organizzato: era sibbene nella indicazione fisica di oggetti materiali, iqp subordinata ed ubbidiente a quella legge del pensiere che contemporaneo col Divin Soffio inspirogli nel dargli Anima d’intelligenza e di vita. Così tutto materiale è il foniamo dell’umano linguaggio, e perciò variabile sempre e variato; ma uniforme, identico è il modo di adagiare la risultante di quelle materiali impressioni: perché una è la legge del pensiere: perché unico è il modo col quale la mente umana la volubilità delle fisiche vicende nel suo intelletto spiritualizza.
La lessigrafia è il glossario
La lessigrafia nel linguaggio umano io distinguo dal glossario, ed intendo per lessigrafia non solo le varie condizioni che a compor concorrono un tale e tale altro sistema gramaticale, ma quelle prolazioni altresì che sono speciali al tale e tale altro idioma per render fonico l’ideale di quel sistema, per esprimere così o così quelle cardinali condizioni dalle quali prescindere non si può perché uom favelli (3); e per glossario intendo i vari temi di qualunque provvenienza le quali con le forme di quella speciale lessigrafia vengano a modificarsi. Or nella lessigrafia, non già nel glossario io mi penso doversi andar rintracciando le fraternità e le filiazioni delle varie loquele più o meno distanti per posizione di tempo o di luogo. Così, ad esempio, un Inglese più agevolmente con un Tedesco che con un italiano verrà a parlamento, perché, comunque il glossario inglese presenti almeno i tre quarti di temi romanici, pure teutonica mera n’è la lessigrafia. Cosi del pari, se a computo del Bibliander (4), di mille parole radicali nel tedesco le ottocento son comuni al greco ed al latino; tra le dugento appunto che non son tali par che le differenze sien da ricercarsi che il lessigrafico sistema teutonico caratterizzano, e dall’ellenico il distinguono e dal laziale, comunque da un comun tronco tutte tre diramati, sia qualunque il nome con che voglia quello designarsi e pel quale non entro in briga.
Gran forza d’ingegno riconoscer dobbiamo nell’Alighieri quando la differenziale di vari idiomi nella particella d’affermazione andava determinando. Certo: in questi che un’ideologo francese denominava frammenti d’idee (5), ma che una mente italiana ben da molti secoli proclamava ammìnicoli del linguaggio (6), i veri dati ricercar bisogna per condurci con minor timore d’inganno a stabilire la filiazione e la fraternità delle umane loquele. Così nella lessigrafia, unica in tutti i dialetti d’Italia, la fratellanza delle varie razze italiche viene a mostrarsi, e l’antichità insieme d’una lingua madre, d’un italico linguaggio primitivo nella iniziativa dell’italica civiltà.
É danno che tanti benemeriti cultori delle antichità, patrie nel ragionare de’ venerandi monumenti che da per ogni dove l’italico suolo somministra, di varietà piuttosto che di analogie sieno andati in cerca, e del glossario piuttosto che della lessigrafia siensi studiati d’indagar le ragioni; prescindendo dal non aver voluto quanto basta portar luce su le diverse industrie paleografiche nella tale o tale altra regione immaginate o nella tale o tale altra età; le quali industrie forse un identico dire presentar potrebbero da sole condizioni di profferenza varialo. Certo è che l’uniformità di lessigrafia negli attuali dialetti d Italia, ad un sistema uniforme ci conduce d’un linguaggio primitivo nelle varie valli d’Italia diramato, e che inalterato quasi ri troviamo ne’ monti (7). E sebbene la lessigrafia di un dialetto, altra esser non possa nella sua essenzial parte se non quella di un comune idioma al quale con altri dialetti appartiene: e quell’idioma, con vedute più larghe, voglia considerarsi come un dialetto anch’esso: e così vie via, fin che si giunga, sempre più di mano in mano differenziando, a quel lessigrafico sistema in che consiste la comun gramatica di tutti gli umani linguaggi; senza spingerci tanto in là, e quasi andar iantastiqando qual mai esser potesse l’adamitica o noachica lessigrafia (8); concentriamoci in limiti più brevi; eseguendo i varroniam avvertimenti, veggiamo di rintracciar nella storia le prime vicende della umanità; e cosi, non già nella genesi delle umane loquele, ma nelle analogie di quelle della veracità o almeno probabilità di un primitivo italico linguaggio instituir quasi una contro pruova.
Origini italiane
Nel più antico e venerato codice delle vecchie tradizioni, le famiglie superstiti dell’uom salvato dal memorabile generai cataclismo nelle tre note razze si diramano; e discendenti siam noi dell’audace progenie di Giapeto (9). E di andar giapetizzando fu la distintiva caratteristica di questa razza, e infine ridursi a stanza ne’ tabernacoli dell’uomo della pastorizia e dell’agricoltura (10). E con le tradizioni dell’oriente, le nostre occidentali son di accordo. Mentre per la cresta de’ monti i protoparenti e legislatori insieme di una civil comunanza, che anzi le patrie divinità, la tale o tale altra tradizione uniformemente ri addita; di un popolo navigatore del pari che con gl’indigeni si fuse non tace ancora nel nostro bacino del mediterraneo costantemente il ricordo. Ma chi furono quelle genti di mare, que’ traversa tori del pelago, que’ Pclasgi in somma, e se ancor si vuole Fallègici (11)?… Arrestiamoci per un momento; e ad altri dati delle antiche memorie rivolgiamo il pensiere.
E le antiche memorie ci additano un Atlantide sommersa, quà monti sopraccavallati, là infranti, e poi le catastrofi di Gige e di Pirra, Delo che sorge dal mare, il soggiorno di Proteo addossato ora al continente, a quel Delta che comunque monumenti ci mostri di altissima antichità, pure è formazione manifestissima di recenti alluvioni.
La geologia trasforma in verità scientifiche le battaglie de’ Giganti con Giove; la dilatata fisiologia un linguaggio sacro nell’ultimo confine dell’Asia ci fa conoscere che il germanico, l’ellenico, l’italico linguaggio con una sola catena rannoda… Saran sempre vane le nostre inchieste quando nella geografia de’ secoli che or corrono della età degli uomini, la geografia non venga pria’ diffinita della età degli eroi, della età degli Dei. E se l’astronomia interroghiamo su le cagioni della obliquità dell’asse della terra; forse l’immensa massa delle acque additar ci potrebbe dal settentrione all’antartico rifluita e gravitante, e forse la condizione insólare dell’odierna Oceanica paragonabile alla condizione de’ nostri monti nella per noi sempremai tenebrosissima età degli Dei.
E l’Arca Noetica su le alture dell’Ararath si arrestava. Ma che all’attual livello allor le acque si abbassassero immediatamente dopo il gran cataclismo, non dicono le sacre pagine. Cosi le alture de’ monti della nostra Europa nella prima età de’ figli dell’uom salvato tante isolate prominenze presentar potevano quante or l’Oceanica ne presenta: e le più prossime per consiglio, e le distantissime per impeto de’ venti, venir potevano dalle successive generazioni de’ patriarchi occupate. Certo è che come altrettante isole le regioni occidentali del mediterraneo vengono ne’ santi libri indicate: certo e che nella eminenza de’ monti, come nell’Arcadia i Greci, nell’Umbria e nella Sabina gl’Italici, le sedi de’ loro progenitori additavano Di qui la costante tradizione delle antichissime origini loro assegnate, e tanto lontane, che quasi originari ed indigeni di quelle or mediterranee regioni vennero a riputarsi. L’antichità degli Arcadi, per boriosa enfasi greca, precedente all’antichità della luna fu proclamata: e dalla sobria maturità de’ pensieri gl’Italiani non dechinando, dissero gli Umbri così denominati quasi i superstiti dalle distruzioni del diluvio, e i montanari della Sabina indogeniti, indigeni, aborigìni: denominazioni che agli oscurissimi progenitori, ai casci delle altre nazioni del pari applicarono. Vana quistione, sterile disputa è quella ai voler determinare se dagli Arcadi in Italia, se dagli Umbri in Grecia i primi abitatori trasmigrassero. Nelle tenebre di antichità sì remota, e nella promiscuità di origine, sarebbe piuttosto da meravigliare se nell’Arcadia del pari che negli elevati monti dell’Appennino uniformità di costumi e di arti non si rinvenisse (12).
Or se dai nostri monti farem discendere i progenitori delle italiche razze, le vedrem tutte a quelle denomina rioni adagiarsi che le memorie antiche ci tramandarono e della comune origine del pari che delle varietà di profferenza del comune linguaggio le vicende manifestarci e le cagioni.
Linguaggio italico primitivo
Lingua Osca
Una lingua vernacola ci additava Varrone contemporanea e paragonabile alle lingue letterate di Grecia e di Roma. Noi la diremo preesistente; perciocché se della lingua del SI è caratteristica distintiva il conchiudere ogni parola con vocale; caratteristica di quel vernacolo linguaggio era quello di avere per unico caso l’ablativo, e un luogo d’oro di Varrone cen dà insegnamento (13).
È caratteristica del dialetto napoletano, che di quel vernacolo linguaggio ritiene più tenacemente le consuetudini, è il conchiudere non le sole parole, ma tutte le sillabe ancora in vocale. Che un tal dialetto sia di tipo, non già greco, ma osco, è di tanta evidenza che mera iattura di tempo sarebbe l’andarne qui ripetendo gli argomenti (14). Del pari che indubitata cosa è non altro essere stato che osco quel vernacolo del quale nel più bel fiore della ialina civiltà tanto i Romani si compiacevano, come osche altresì le canzoni che i ludi istrionici accompagnavano. I Logii, gli antichi italici scienziati che Aristotile consultò, non altrimenti che osci gl’italici primitivi denominavano (15).
Della diramazione della razza osca giovi ora discorrere la latitudine. «Osci furono i Sicoli (16), i più antichi Italici rammentati nelle storie, distesi nell’una e nell’altra gronda della penisola, fissati alfine la più gran parte nella Trinacria cui danno il nome.
Osci furono gli Umbri (17). Perché non Osci anche i Tusci e gli Etruscil Ci piace far distendere sino ai confini genovesi, come facea l’Alighieri per la lingua del Si, la diramazione della famiglia da quel che denominò il Miceli principal tronco del grande stipite italiano primitivo (18); e leggiam con piacere ed adottiamo con piena esultanza questi pensieri del Fabroni (19):
» Aggiungete alla parala Ose non altro che l’articolo The; ed ecco the-osc, Tosco, Tusco: aggiungetevi la qualificatone di AITER, padre; ed ecco l’Aiter-osc, gli Etrusci, o Padri Osci; e se vi porrete la qualificazione di Vol, battagliere, avrete VOL-osc, i Volosci, i Volsci, gli Osci battaglieri».
Ed a conforto di queste per me care etimologie, aggi aggiugneremo che Welsci è il nome dato dai Germanici agl’Italiani, i quali non altrimenti che come battaglieri nel primo incontro dovean loro presentarsi e rendersi memorabili, e i quali al primo tronco natio le sparse genti dell’italica stirpe nella gran valle del Po ed oltremonti diramale ricongiungono.
Le migrazioni e le commistioni de’ popoli per doppie vie procedono, sia per terra, sia per acqua; e son pacifiche o guerriere; opere del senno o della mano; colonizzazioni e federazioni, piraterie e conquiste. Il tipo ideale di questo doppio procedimento col nome generico di padre o di battagliere van designando tutù gl’idiomi, con parole di suono diverso bensì, ma sempre mai quelle primitive idee rappresentando; e nella nostra Italia i primi padri e i primi guerrieri, i saggi e i prodi, col nome di Etrusci e di Volsci indicarono: parole che poi alla designazione specifica si rimasero di quelle popolazioni che maggiormente nella età degli storici su le altre in prudenza o coraggio prevalsero.
Cosi nella gran valle del Po la dominazione de’ Padri Osci, la dominazione degli Etrusci la memoria delle avite origini nelle tradizioni passarono. E Welsci battaglieri Osci ben doveano dagli Alpigiani e dai Transalpini denominarsi que’ prodi che dall’occidente all’oriente della gran siepe, tribù salvatiche o predatrici orde combattevano, o al civile progresso delle patrie instituzioni più o men ridussero; e di là i Liguri e dall’altra banda gli Euganei, gli Eneti, gli Orobi affratellarono. Così la dominazione de Padri Osci oltre l’Appennino si propagava, e i Liguri, gli Euganei, gli Eneti, gli Orobi alla Italia Cisappennina si ricongiunsero, e le instituzioni e i monumenti de’ Padri Osci alle seguenti generazioni tramandarono, ed indigeni della Transappennina Italia vanno a giusta ragione riputati.
E nessuna escludendo delle rimotissime tradizioni, anche de’ Celti e degli Arcadi non ai vuol fare reticenza. Certo: razze italiche o a dir meno con le italiche razze fraternizzanti diremo que’ Celti, quegli Arcadi primitivi che ne’ tempi antistorici nelle nostre regioni e per le nostre prode stanziarono; ma que’ Celti non erano i Galli che poi braccati o druidici si dissero, e quegli Arcadi non erano gli Ellenici, comunque in età di molto inferiore il nome di Galli e di Ellenici assumessero. Ma v’ha dippiù. Volsci erano i Galli di Belloveso, come della stessa razza le seguenti tribù che tanta parte della settentrionale Italia occuparono, e di tante illustri e care città italiche gittarono le fondamenta. Ed un dotto oltramontano venga qui a farci incolpabili di smodata propensione alle patrie origini.
» I Volgi, scrive il chiarissimo Buat, passati dal Lazio in antica età oltre le Alpi, tenevano la meridional regione delle Gallie, ubertosissima al dir di Livio, ma per la cresciuta popolazione già divenuta angusta. Ambigato adunque commise a Belloveso ed a Sigoveso, fervidi giovani figliuoli di sua sorella, di andar con qualunque numero di uomini in cerca di nuove sedi che gli auguri degli Dei avrebbero loro concedute. Le sorti assegnarono a Sigoveso la selva che poi si disse Ericina; altre più liete accennarono a Belloveso l’Italia. E co’ Volgi Laziali anche i Volgi Lectosagi e i Volgi Arecomici si unirono. E Volgi erano altresì que’ Centumani che non guari tempo dopo seguirono le bandiere di Belloveso, e ne’ luoghi di Verona e Brescia si fissarono (20)».
Fin qui il dotto Francese. Che della stessa razza fossero gli altri Galli che nelle seguenti età varcarono le Alpi, è storica verità.
E se le storie il tacessero, l’identità degli idiomi di Provenza e di Lombardia bea basterebbero a farne limpidissima la dimostrazione. Che cosa e mai la lingua d’OC se non la lingua italica con accento lombardo pronunziata?
Idiomi Ellenici e Labiali
Col ritorno degli Osci-battaglieri nella gran valle del Po, ai primi barlumi possiam penetrare della storia d’Italia e di Grecia, perciocché pei tempi anteriori di queste due Nazioni tutto è miticismo, tutto tradizionali avventure qua e là da’ rapsodi con più o meno d’arte pennelleggiate. Al sesto secolo anteriore alla nostra era possiam ritrarre tutto al più quell1 avvenimento, ed alla età semimitologica del legislatore di Atene, del legislatore di Roma. Ma per ben diciotto secoli di buio dobbiam tuttavia raggirarci per giugnere all’italico Giano Sabazio, all’arcadico Licaone ne’ quali i popoli più civili dell’antichità i loro progenitori nelle patrie tradizioni vagheggiarono. E quali erano secondo quelle tradizioni le condizioni geografiche dell’Arcadia e ella Sabina? Navigavano i figliuoli di Licaone; e ne’ momenti e nelle tradizioni più remote non altrimenti Giano ci si rappresenta se non col simbolo della nave. -Più o meno guaste, più o meno obliterate, ma tutte più o meno similari sono le antiche memorie che le tradizioni occidentali con le tradizioni orientali ricongiungono (21).
I primi barlumi dicemmo apparire della età degli uomini nel sesto secolo innanzi la nostra era: ma non e da dimenticare come quasi di ugual passo una identità di procedimento nella vita civile nella nostra e nella penisola ellenica ci van dipingendogli scrittori delle seguenti età che lo. vecchie tradizioni in racconti storici trasformarono. La, dopo Solone un Pisistrato: quà dopo Servio Tullio un Tarquinio. Ma quel Tarquinio delle Ferie Latine addice a Roma le indizioni e con esse del diritto pubblico italiano la potenza morale; mentre quel Pisistrato con raccogliere le sparse canzoni de’ rapsodi di Grecia, dà l’impronta di nazionale impresa ad un avvenimento incerto ancora se storia o mito, e tutti i popoli dell’Ellenia omerizzando affratella. Delle tante erudite dispute su le migrazioni de’ popoli dopo i fati di Troia si otterrebbe forse il sincretismo se ne’ poemi di Omero con quelle intenzioni si facesse studio che l’acre ingegno del nostro Vico iniziava (22). E forse in qual sesto secolo appunto innanzi alla nostra era del greco e del latin letterato emergerebbero le prime origini, là ne’ poemi di Omero, quà nelle concioni laziali ad unità simmetrizzate.
Carattere speciale della lingua latina
Gran diversità presentano le vicende degl’idiomi d’Italia e di Grecia. La lingua ellenica non veggiamo già sorgere ma sorta, appena i più remoti monumenti appaiono di greca impronta: e se differenze vi si scorgono; son mere differenze di dialetto, merissime varietà ortografiche. Ma nell’Ausonia non dai un passo senza imbatterti in differenze cardinali; e del latino idioma assisti quasi alla culla, il balbettar ne ascolti, e poi l’infantil cinguettio, le giovanili arditezze, la maestosa virilità!
Mentre delle tavole della federazione commerciale tra i Fenici e i Tirreni a grave stento nella età di Polibio s’interpetravano piuttosto che si leggevano le condizioni; mentre dei carmi arvali e saliari passò ne’ sacri tripudi indicifrabile il mero formato; un linguaggio di legislazione prendeva inalterato il suo andamento, e la maestà di quell’idioma n’emerse che non romano ma latino fu detto, nelle Ferie Latine armonizzato: e come linguaggio eminentemente di legislazione nelle tavole de decemviri si trasfuse (23).
E che mero linguaggio di legislazione considerar si deggia quello che poi di Latino ebbe il nome, basterebbe a rendere manifesto il solo dismettere degli articoli, esempio unico in tutte le umane loquele. Il bisogno degli adiettivi dimostrativi fa tanto maggiormente sentirsi quanto meno i vocaboli son determinati. Ma le parole legittime delle leggi appunto nel determinato e rigido senso della loro significanza dovean costituirà. Poi, coll’ergersi arbitri nelle contese tra popolo e popolo, e sempre sotto la maschera di sostenitori del diritto feciale, estendevano i Romani il loro imperio e le loro depredazioni. E il loro linguaggio fu quello del comando: la loro virtù, inflessibile costanza. E però le parole altro esser non potevano se non l’enunciato di rigidi pensieri.
Ma il linguaggio del Campidoglio era forse il linguaggio dell’Aventino? Era il linguaggio delle antiche concioni di Laurento e poi dell’asilo di Romolo, de’ comizi per centurie, e poi di quelle ove le tribù italiche convenivano, ove il dritto pubblico popolare sorgeva? La lingua vera de’ Latini non fu al certo quella che poi di latina portò il nome: e la lingua dell’Aventino e del Monte Sacro assai poco avea di comune colla decemvirale, e vernacola si rimase (24).
Vero è che dopo le pubblicazioni di Gneo Flavio e di Sesto Elio Cato la lingua delle convenute leggi non fu più pel popolo un mistero, e alle disputazioni del Foro, come di mano in mano a tutte le civiche magistrature, la plebe romana ebbe parte. Ma linguaggio dottrinale era quello non la lingua del comun conversare.
Cosi col linguaggio della legislazione la lingua italica primitiva fu ingentilita ad imitazione della greca. I nomi ebbero inflessioni per casi, ma oltre ai cinque casi greci ritennesi il sesto, vero nazionale e solo latino; ma le inflessioni desinenziali in m ed in s sfumavano nella pronunzia, disparivano ne’ versi. E che tutto ciò fosse di straniera o almeno di recente provvenienza, l’autorità venerabile di Cicerone cen persuade (25).
I verbi ebbero anch’essi maggior numero d’inflessioni; ma non quante ne ammettevano i Greci; ma non eliminando affatto gli ausiliari. Cosi un linguaggio illustre sorgeva ad emulazione della più bella lingua del mondo: ma su le basi della nazionale. E come d’ordinario addiviene che nelle gare al di là de’ giusti limiti si trascorra; i Latini non l’uso soltanto degli articoli dismettevano, ma i più eleganti delle stesse preposizioni e delle particelle di legame aborrivano la frequenza (26). In tal maniera col divenir più gentile, men popolare quel linguaggio illustre si rendeva: e la bella letteratura de’ Latini fu veduta acquistar sembianza di straniera ne’ più bei tempi della sua floridezza.
Lettere Latine poco gustate da’ volgari
L’epica poesia venne coltivata con fortuna: che la tenuità rifuggono di volgar loquela quegli animosi ingegni i quali a descrivere imprendono le alte gesta de generosi e l’arcano collegamento delle vicende di quaggiù col consiglio de’ Celesti Pure razionai poema non fu l’Eneide: né la plebe di Roma ricantava le furie di Turno e l’abbandono di Elisa, come i rapsodi di Grecia ridicevan di città in città l’ira di Achille; come ripete nel suo burchio il gondolier di Venezia, vuoi lo sdegno della ragion feroce di Rinaldo, vuoi la dolente istoria e il pietoso lagrimare di Erminia.
La lirica ebbe il suo Fiacco: ma oltre le soglie de’ grandi quelle sue canzoni forse non furono ascoltate: ed unico stett’egli co’ Greci al paragone: e dopo la sua età ai modi più italici i begl’ingegni si rivolgevano dietro le tracce di Catullo (27).
Che diremo della grammatica, poesia veramente da popolo? Oltre a’ primi tentativi nella età degli Scipioni, i Romani nell’aringo teatrale si tacquero, e sol di qualche debole e svisata imitazione dal greco ad ora ad ora davan rado e mal gradito spettacolo, mentre degli esodi atellani non mai si dismise la voga (28).
Chepperò la lingua illustre de’ Romani alle giornaliere consuetudini della vita non provvedeva: ne canti popolareschi forse nemmen si ascoltava: forse a solo linguaggio di corte venne ne’ più begli anni del principato a limitarsi. Di solecismi ridondano le vecchie iscrizioni fin ne’ colombari della casa augusta: e in solecismi non è possibile che incorra un popolo il qual parli il materno linguaggio (29).
Industria per render popolare il latino idioma
Diversa dai famigliar conversare fu adunque la lingua degli eleganti dicitori, e conseguentemente la scrittura: ma non diversa tanto che il linguaggio del latino illustre non fosse inteso da’ volgari, quando spezialmente a quella industria gli scrittori si piegavano della quale non man cano autentiche pruove. Basti rammentarne una sola.
» Pronta e fluente, scrisse Svetonio, e quale a principe si con» veniva era di Augusto l’eloquenza: elegante fu il suo scrivere, ma non di quella eleganza rimescolata e smaniosa che il dir semplice malmena ed abbrunisce; facile, temperata era l’eloquenza alla quale aspirava, le inettezze evitando del discorrere per sentenze, e il puzzo, com’ei diceva, di rugginosi e reconditi vocaboli. Apertissimamente espressi ei voleva i pensieri suoi; e a questo scopo le precipue sue cure rivolse; ed a maggiormente conseguirlo, e acciocché il lettore o l’ascoltatore non incontrasse inciampo o ritardo, non dubitò di aggiugnere le preposizioni alle parole e le congiunzioni frequentemente ripetere: le quali tolte, un non so che di oscuro apportano al discorso, sebben grazia vi accrescano (30)».
Ed è notabile che, con tale industria, dal latino classico ad un latino italianizzato v1 ha non solo convergenza, ma identità.
Intanto non valse l’esempio di Augusto a frenar l’intemperanza degli scrittori: non valse la sua disapprovazione alla troppo studiata dicitura di Tiberio Cesare: già Sotto Caligola vagheggia vasi il pensiere di abbandonare alle fiamme i poemi di Marone e le deche di Tito Livio; e indarno sudavano gramatici e retori per ricondurre i Romani alla semplicità del dire e alla piana eloquenza dell’oratore d’Arpino. La mania di distaccarsi da modi volgari fu sempre, pur troppo, la mala febbre de’ letterati ogni età.
Decadenza del latino letterato
Col quale distaccarsi di-soverchio dal dir popolare, il dir per gramatica sompreppiù disagevole si rendeva, nel tempo stesso che sempreppiù viziato diveniva e disadorno. E fin da quando Tiberio ebbe trasferito dal Foro alla Curia le pubbliche concioni, tutta la vita del dir latino era spenta, ed imitatori più o men felici de’ morti i seguenti scrittori divennero: ma sempre con la legge che l’Eterno impose alle imitazioni d’ogni sorta, di rimanersi tuttavia e molto all’ingiù dei modelli…..
Costantino trasportava la sede, dell’imperio in una città della Tracia: e le due lingue letterate dell’orberomano si rimescolarono allora un’altra volta e vicendevolmente si alterarono: mentre le volgari, donde quelle eran sorte, nel primitivo sistema di gramaticale andamento si consolidavano; pel quale, più da natura che da arte derivando, alle vecchie consuetudini e alla natia indole dell’antica favella le nuove generazioni viemaggiormente si videro così ravvicinate (31).
Ben riconobbero gli scrittori che allo studio della linguistica con alacre animo or si rivolgono, propendere ad italianismo piuttosto che a latinismo gli scroni che il moderno dir greco distinguono dall’antico; ma non pare che la vera cagione ne rinvenissero quando nelle fattorie la vanno additando de’ Genovesi e de’ Veneziani che nell’Oriente in etadi assai basse si stabilirono. Alla identità della comune origine bisogna risalire per iscorgerne la cagion vera, ed alla semplicità di quella gramatica primitiva su la quale gl’idiomi letterari si affazzonarono della Grecia e di Roma. Del resto, ben sette secoli prima degli stabilimenti delle picciole colonie venete. e genovesi, non altra fu la Città di Costantino che una vasta colonia di tutta quanta l’Italia (32).
Nascimento de moderni: linguaggi romani
La quale Italia risguardava il vecchio Plinio come eletta da Dio per raunare gl’imperii sparsi, addolcire i costumi, e le, discordi ed efferate lingue di tanti popoli ridurre col commercio del parlare a concordia con un solo idioma (33). Ma questo tale idioma, non altrimenti che per la gramatica vuol riguardarsi unico e per la comunità delle parole del civil consorzio; non sempre pel domestico glossario e non mai per uniformità identica di profferenza, L’Italia stessa laute offro varietà di dialetti quanti sono i suoi grandi bacini, e forse tanti accenti quanti sono i volghi di ciascuna città. Po quali riguardi tanta moltiplicità di scrittura osserviamo nelle vecchie carte e negli antichi monumenti dell’età remotissima e del medio evo, per tutta quella stagione nella quale tipi di modello non erano ancor sorti, e nella quale, se mai dell’arte etimologica vera ti è in diletto il soccorso, le varietà mere di dialetto con le differenze scambierai da idioma ad idioma (34). Nobilissima e curiosa inchiesta sarebbe quella di andar determinando e classificando su le condizioni dell’attuai pronunzia de popoli italici quegli antichi idiomi i cui monumenti tanta diversità di scrittura ci presentano: e forse un tipo unico gramaticale vi scorgeremmo e quella unità d’idioma insiememente il quale, come per l’attual lingua nobile d’Italia disse l’Alighieri, da per tutto appare e in nessuna città si rinviene. Perciocché, se una qualche influenza nel linguaggio escluder non possiamo affatto dalle antichissime genti che in età di molto precedenti alla storia nelle vecchie tradizioni si accennano di un Saturno, di un Ercole, di un Enea, e di altrettali mitiche personalità nella età degli Dei e degli Eroi; già veggiamo, nelle tradizioni più prossime alla età degli uomini, de Patri Osci e degli Osci Battaglieri diffuse e radicate la lingua e le consuetudini sino alla gran siepe la quale, se non sempre ai Barbari, oppose sempre insuperabile argine alla barbarie; e perciò adottarsi da quelli una lingua italica dominante, come mera italica è quella de’ popoli nuovi che le provincie romane occuparono e con gl’indigeni si fusero; e, posta sempre la distinzione da noi prodotta di lessigrafia e di glossario, diverse parole sibbene in quelle monumentali scritture vedremmo qua e là introdotte, ma non mai cangiato il gramatical sistema, il lessigrafico andamento.
Arrestiamoci intanto a cose oggimai non più controvertibili. Rinvenuto il caso che Varrone disse latino, e che nella sua caratteristica desinenza in vocale la caratteristica impronta del linguaggio italico a tempi ben remoti trasportando suggella, qualunque ulteriore inchiesta su l’antichità del nostro nazionale idioma, e molto più su l’anteriorità del provenziale o dell’italico dialetto, e su le origini delle lingue sorelle del mezzogiorno di Europa, senza vanissimo scapito di tempo non è più da istituirsi: che dalle sole ragioni di più o meno vibrata profferenza, tutte scorger le possiamo dall’antico tipo naturalmente fluenti.
E non già dalle conquiste; ma dal solo sistema delle federazioni e poi delle colonie de’ veterani l’origin prima vuol ripetersi delle odierne lingue romane. E se ad un romano accampamento trasporteremo il pensiere, agevole di quelle rinvenir potremo l’inizjante spontaneo impasto e le differenze.
Lingua castrense
Ed ecco col loro accento rotondamente sonante ed aspirato gl’lberi, primi che al di là delle Alpi fosser soci de’ Romani, preferir tra le affini le più sonore consonanti, aspirar le più tenui, rinvigorir le vocali, e certa imperiosa maestà conservar nelle parole col rattenere del latino letterato le desinenziali per caratteristica del numero del più. Del resto: tutti i loro nomi nel singolare a legge del caso latino inflettere: seguir sintassi italiana; all’italiana coniugare i loro verbi; e de’ troncamenti delle parole quelli soltanto ammettere che ad italiano orecchio nondan noia(35).
Ed ecco i Galli, più restii nel deporre le loro celtiche squame (36), piegarsi a disagio alla romana favella, ma pur piegarvicisi; l’integrità abbracciare dell’italico linguaggio, ma con deprimere la forza delle consonanti (37), tacerle in gran parte; render volubili oscure le vocali; e tutta languiticela render della loro favella l’attillatura (38). Che ultimi que’ Galli cingevan brando romano, e quando ne tappeti dell’Asia eran già per poltrire i vincitori di Cartagine. Pure altra ma non diversa veggiam la sembianza della francese e della italiana favella, come figliuole della stessa madre, e l’una dell’altra spesso alternar le maniere (39).
Ma tra i Galli ecco gli Àquitani, e de’ Romani e degli lberi seguir più fianchi le consuetudini, e i più veterani l’aspetto quasi affatto deporre di straniera origine, di linguaggio alte italiane razze promiscui come di stanza (40). Se non che, quel tacere delle vocali alla fine delle parole, e certo incontro d’aspre lettere duramente accoppiate, lo stento trasparir lasciano della imitazione, e dell’indole natia dalla qual divergono ti fanno accorto.
E lo stesso dir dovremo di quegli altri linguaggi che si dicono di sarmato-romana promiscuità, come tra i Vaiacela e i Bulgari lungo il Danubio, stazione importantissima delle legioni e di que’ Barbari i quali, ora promiscuamente con esse, ora nella condizione di stipendiar! o ausiliari, ad argine di quella più che mai combattuta frontiera dell’imperio ebbero stanza. –Ma estendiamo ad orizzonte più largo il nostro sguardo.
Influenza de‘ Barbari nel volgare romano
Fu ed è tuttavia opinione da molti sostenuta e vagheggiata quella di supporre che dalla presenza de’ Barbari tosse determinato quel rivolgimento di cose, il quale tanto le moderne nazioni dalle auliche distinguono; tra le quali l’abolizione dell’antico idioma, e la formazione delle lingue morelle del Mezzogiorno di Europa. Per ben valutare la forza di una tale opinione, pilliamo un rapido sguardo 6u le irruzioni denari popoli, che il gran colosso rovesciarono dell’imperio romano, e sen divisero i rottami: nella quale ricerca, stretti al nostro argomento, gioverà esaminare qual mai esser potesse il linguaggio di quelle orde, e conseguentemente quali modificazioni introdur potesse nel linguaggio de’ vinti. Ed a ciò fare più dalla corrente siam trascinati dalla vigente voga di considerar la linguistica come un elemento di primo bisogno nello studio delle genealogie e delle fratellanze delle nazioni, quanto dalla persuasione determinati di potere non che raggiungere ma avvicinarci all’arduo scopo. Intanto, se la Cardinal riflessione non si perda di veduta di distinguere le incursioni dalle permanenze, i Barbari affatto nuovi e peregrini dagli stipendiati e colonizzati; forse non mancherà di balenare qualche solco di luce che l’addensato buio sino ad un certo punto ci diradi.
La lingua castrense de’ Goti
Un’opera superiore a qualunque elogio si va vievia pubblicando dal eh. Carlo Trota, la cui soave amicizia si lega co’ più cari ricordi della nostra gioventù; e la sua Storia dell’Italia del Medio-evo ci porge lucidissima fiaccola per condurci con minor tema di smarrimento entro tenebre che tuttora involgono l’etnografiche ricerche cui quasi tutto il mondo letterato or si rivolge. Quasi un Orazio sul ponte a tutù i battaglieri ci si oppone del sistema lodo-germanico. E noi nella loro integrità adottiamo i suoi pensieri su la differenza cardinale delle due razze getica e germanica, e su l’identità di quella con la gotica dalla germanica sempre mai diversa, sebbene avesse incorporata in sé molle germaniche tribù nella successione de’ tempi, e soprattutto le tribù de Vandali e de’ Borgognoni (41). Or posta l’ormai dimostrala differenza tra i popoli germani o germanizzanti, e i popoli gotici o guizzanti, qualunque mai fossero le loro originarie razze; in due larghe partizioni tutti i popoli barbari van distinti: in quelli cioè che nelle loro abitudini e nella nalìa loquela si rimasero, ed in quegli altri che, men tenaci, alle abitudini romane si piegarono e la volgar lingua castrense apparando adottarono (42).
Ed ecco ben chiaro il come tutti i Barbari che poi nelle provincie romane presero stanza e che nella gran famiglia de’ Goti si fusero, di quella lingua volgare romana, 0 vogliam dire castrense, venivano istruiti, e della qual poi agevolmente ai loro conterranei, per usar qui aneli’ io un vocabolo castrense, divenivano inscenatori. La qual riflessione acquista gran forza dall’osservarsi che uniforme poi lu il sistema gramaticale che le lingue romane adottarono; uniforme il trasmuta mento delle desinenze latine l’adottar che fecero e la scelta degli stessi articoli e degli ausiliari; e il gioco delle particelle: e tutto quello in una parola che distingue dalla latina le lingue sorelle del mezzogiorno di Europa. E tanta uniformità succedeva tra popoli già isolati e distanti tra loro per lungo tratto di paese; e per profferenze dissimili: e per governo e per costumi e per maniere non al certo somiglianti. Quando nella età delle crociale il linguaggio de’ volgari fu ridotto a scrittura, una e nella Francia e nella Spagna e nell’Italia ne fu la sembianza: tutti gli scrittori calcarono le stesse vestigio: e sol tardi s’accorsero che le circostanze di cui abbiam fatto cenno inchinar li doveano a seguire andamento diverso. Ciascun dialetto acquistò allora forme speziali ed individue: e il francese, lo spagnuolo, l’italiano ebber notabili differenze. Or come mai queste varietà sorgevano allora appunto che avrebber dovuto sparire? E come mai quelle circostanze ebber tanto potere allora appunto che molte di esse cessavano, e nuove relazioni di commercio, di parentele, di governo e d’ogni maniera tra i riuniti popoli si rassodavano? Le incursioni e le permanenze.
La prima impulsione fu data a que’ popoli dagli Unni nazione tatara la quale discacciata da’ suoi lari e precipitandosi dall’oriente all’occidente. dell’Asia, impresse il movimento ai popoli vicini. L’impulso si propagò di mano in mano con prodigiosa rapidità, comunicandosi dal mar Caspio al mar Baltico, e stendendosi poi da questo al Mediterraneo (43).
Ma la momentanea apparizione degli Unni al di qua delle Alpi altro non produsse che la desolazione della Venezia, e la determinazione ai più agiati di rifuggirsi in quelle isolette dalle quali si vide poi sorgere una delle più belle città della moderna Italia. Valente permise poi che gli Unni occupassero la sponda meridionale del Danubio: e la Pannonia fu così la loro preda.
Varcarono il Reno i Vandali, gli Svevi, gli Alani: si sparsero nelle Gallie, si spinsero nella Spagna: ma poco dopo combattuti dai Visigoti, ch’erano agli stipendi de’ Romani, son confinati nella Galizia: donde poi movevano i Vandali per fondare in Africa un imperio che doveva a capo di novantasei anni essere annientato da Belisario: e dove gli Svevi e gli Alani, dopo nuove sconfitte, furono riuniti al reame gotico da Leovigildo, fondendosi co natii ed apparando piuttosto da essi un linguaggio che pe’ tanti gerghi che parlavano, ancora forse non si avevano formato (44). I Visigoti ebbero allora l’Aquitania; e dopo varie vicende tutta la dominarono co’ natii.
I Borgognoni intanto s’impossessavano della parte occidentale della Svizzera e delle provincie orientali della Gallia.
Dobbiamo credere che ai Visigoti e ai Borgognoni si debba il nascimento della lingua d’oc? di quel Latino volgare cioè che con picciolissime differenze formò il linguaggio quasi uniforme de Trovatori del secolo XI nelle Gallie non solo ma nella Spagna eziandio e nell’Italia? Ma noi abbiam già veduto come una lingua analoga si formasse di già nella Dacia, nella quale è tuttavia vivente. E nella Dacia di Traiano, dove già sorgeva la regia di Decchalo, dopo l’abbandono di Aureliano, tutte le razze barbare nella gotica si fusero; e per insigne testimonianza di Valafrido Strattone, la lingua gotica era già comune er le regioni del Reno e del Danubio anche tra i Barbari i varia denominazione, e se così vuoisi, di razze affatto dissimili. E la lingua gotica fin dal terzo secolo era già romanizzala, e il goto metropolita parlamentava co’ Padri del Concilio di Micea (45).
Del resto giovi qui riprodurre una osservazione, comune a tutte le pretese trasformazioni della lingua latina per l’incontro che le genti romane si ebbero con le barbariche, lo non so come dalla mistura del duro linguaggio vandalo-germanico (46) con la non dolcissima lingua latina, abbia potuto questa ingentilirsi piuttosto che innasprirsi ne’ suoi tre grandi dialetti, diceva il Maffei (47). Era la lingua latina un onesto temperamento di vocali e di consonanti, prevalendo alquanto queste. L’alemanno e le moderne romane posson considerarsi come le due estremità opposte. Or come mai, invece di moltiplicarsi, si diminuirono Je consonanti; e anzi che scemare, crebbero le sillabe di soverchio vocalizzate? E non si creda eccezione quel lusso, direni cosi, di consonanti che nelle scritture appaiono del provenzale e del romano-vallone; egli è ben noto che in quest’ultimo idioma un quarto almeno delle lettere scritte non van pronunziale; cd è notabile, riguardo al provenzale, ed è agevole il vederlo) come con la pronunzia risorgono molte vocali che nella scrittura si deideravano (48). Ma che che ne sia delle conseguenze da trarsi da tale argomento, le difficoltà rimangono sempre insolubili che su le differenze si fondano dal sistema gramaticale, e di quei che con tanto acume d’ingegno Vairone considerò amminicoli del linguaggio. Or che diremo di tali differenze? Oli re alla introduzione di parecchi nuovi vocaboli, non pare che altro dalle nuove razze le lingue romane ricevessero. Ma proseguiamo le nostre inchieste.
I Teutonici
I Cauci, i Cheruscr e i Catti, co’ quali nomi molte altre nazioni ancora si comprendevano, stabiliscono una possente federazione, si danno il comun nome di Franchi: inondano le Gallie: saccheggiano la Spagna: e parte di essi penetra anche nell’Africa. Nel tempo medesimo gli Alamanni, altra federazione germanica di varie tribù, si gettavano nell’Italia. Ma quel movimento altro non fu che scorreria. I Franchi poco dopo lo stabilimento de’ Borgognoni nel centro dalle Gallie, vi si fissano al settentrione, nella Belgica: poi, capitanati da Clodoveo, stendono la dominazione, in tutte le vaste provincie che or son chiamale Francia dal loro nome.
Ma i vincitori dapprima non comunicano co’ vinti, come nella Spagna e nella Gallia meridionale. I natii non sono ammessi all’onor della milizia; servi della gleba, rimangono affatto distaccati dalle faccende de’ conquistatori; c, sino al principio della seconda razza, altro era il linguaggio della nobiltà, altro quello del popolo. Carlo-Magno parlava il tedesco (49), e il tedesco s’impiegava ne canti guerrieri e storici di quella età.
L’influenza della lingua germanica dovrebbe risentirsi viemaggiormente nel francese; tanto per promiscuità di confini, quanto per relazioni intime che aver doveano sudditi dello stesso padrone; giacché lungo il corso e alla destra sponda del Reno i vassalli di Carlomagno eran tutti germani. E pure non v’ha forse linguaggio che più del francese dal tedesco si allontani. Due diverse lingue parlavano. non ne fecero una miscela: e l’un popolo non intendea l’altro, come sarem per vedere. E ripeto, che qui non è quistione di numero maggiore o minore di vocaboli comuni; ma del sistema gramaticale; ma della prolazion delle voci.
Intanto la lingua romana rustica era in bocca del popolo; e tanto diversa dal latin chericale che ne’ concilii di Tursi e di Arles (50) convenne ordinare ai vescovi che traducessero le loro omilie in tedesco e in latin volgare: come del pari non altrimenti che in tedesco ed in latin volgare si solennizzarono i giuramenti de’ successori di Carlo magno nella pace fermata a Strasburgo (51). Ma l’età di Carlo Magno segna un’epoca di pieno progresso nel civile andamento europeo: del quale per ben ravvisarne le fasi, a quelle vedute generali dobbiam ritorcere il pensiere dalle quali la rassegna de’ popoli barbari che irruppero nel dechinanle imperio ci ha distratti alquanto; e sol per un momento ci arresteremo ancora sugli ultimi confini della romana dominazione per tutte raggruppare le sparse fila della tela ordita sinora.
I Sassoni e gli Angli chiamati dai Britanni in soccorso contro gli Scozzesi, temuti allora sotto il nome di Pitti, abbandonano le coste germaniche dell’Oceano settentrionale, penetrano nella Gran-Bretagna, e soggiogano quel paese che dovean difendere.
Quest’ultima frontiera però dell’imperio romano non arca latin volgare: le sole legioni, e sempre isolatamente ed in diffidenza co natii, vi stazionarono. Se P inglese che quivi si formò prese poi molto dal francese, ciò si dee alle cure patriottiche di Guglielmo il Conquistatore, alla preparazione forse più del linguaggio guelscio che tre milioni d’anime vi parlavano da 300 anni prima che Cesare discendesse in quell’isola; del qual linguaggio guelscio nota è l’analogia col romano vallone. E perciò le britanniche loquele conservano quell’ibridismo che alle lingue romane le accosta si, ma lor non comunica sembianze di famiglia (52).
Le quali pur si scorgono in quelle che si dicono di sarmato-roinana promiscuità, come tra i Valacchi ci Bulgari lungo il Danubio, stazione importantissima delle legioni e di que’ Barbari i quali ora promiscuamente con?sse, ora nella condizione di stipendiai, ora da’ loro stessi capi condotti, ad argine di quell’altra più che mai combattuta frontiera accampavano. E qui la nostra ipotesi sempre più si conforta su quel tipo di linguaggio che denominammo castrense. E danno che sinora su quelle lingue non siasi rivolta la diligenza degli eruditi ricercatori, e che radi e sparsi rottami sol di tratto in tratto qua e là sen rinvengano: ché forse maggior luce vedremmo sparsa su le origini delle lingue romane, se come il provenziale vantar potesse il valacco un Reynuardo!—Riepiloghiamo.
Un linguaggio da popolo con le legioni romane sino al muro di Agrippa nella Britania, e dalle frontiere del Reno e del Danubio giù sino al mare col romano governo, coi cangiati costumi, e con la religione del Lazio erasi già radicato. Indubitatamente all’adozione di quell’idioma le comuni origini, l’analogia delle materne loquele confortavano le occidentali regioni dell’orbe romano. Ma vieppiù alla semplicità di fai modi le confortavano i vangelizzatori di quelle auguste dottrine le quali distrugger doveano le ingiuste disuguaglianze di fortuna, affratellar tutti i ceti, e formar di tutti i popoli dell’universo una famiglia sola.
La lingua clericale
I fasti della religion cristiana rammentano qua e là illustri personaggi di allo grado che. ne’ primi tempi la professarono: ma la gran massa de’ credenti dalla più umile condizione della società si vuol ripetere. Que’ poveri di spirito non volevano non ambivano sostenere splendidi onori sociali, anche dopoché Costantino ebbe inalberala la Croce in Campidoglio. I personaggi d’importanza, come mai sempre nella età delle corruzioni sociali addiviene, per vezzo adulatorio alla famiglia regnante, e i più con ipocrito dispetto alle assemblee si univano de’ credenti: e mentre gli ambiziosi e svelti ingegni che vi s’ intrudevano traean cagione dalla semplicità de’ loro confratelli per disunirli e dominare; i begli spiriti dall’altro canto formavano di quelle dissensioni argomento di riso e di dilegio, e i più zelatori della vigna del Signore trovavano occasione di scandalo ne dettati di que’ padri che troppo di ciceroniano sentivano (53).
Sopraggiunsero nell’occidente le incursioni barbariche, e tutta quella zizania grandeggiante fu svelta dalla chiesa di Dio e le umili piante soltanto inosservate si rimasero o neglette dal mietitor superbo che passava.
Medio evo
Se non tornarono negli antri, nella solitudine de’ boschi si raccolsero allora i più pii. Ma dal fondo di que’ boschi di mano in mano la fierezza mansuefacevano de’ guerrieri indomabili: dalla scuola di que’ solitari sorgevano i fondatori di tutte le moderne monarchie: e que’ solitari poi, alla corte dei Re trabalzati, divenivano i consiglieri più rispettati ne’ dubbi eventi, e i promulgatoci delle tregue di Dio nelle civili contese. Così al volgar latino tutte le nuove genti si piegavano, e le varie lingue de’ vincitori o al romano tipo erano li già adagiate o di mano in mano vi si piegarono, e ben tosto le antiche vennero affatto dimentiche da que’ pochi che, più tenaci alle loro consuetudini, delle provincie romane occupavano isolati ed a cincischi la signoria (54).
Gli Arabi
In quella stagione l’araba scimitarra cominciò a balenare in Oriente. Ma non per la sola forza del brando affollavasi la calea sotto il vessillo dell’islamismo. Tutti i dissidenti dalla Fede di Nicea ne invocavano o provocavano protezione o vendetta: e la prepotenza dell’audace impostore fu al suo colmo allor che tutta quanta ebbe adita l’eredità degli ardimenti ariani.
Qual parte attribuir dovremo agli Arabi su le vicende del nostro popolar linguaggio?-Nessuna. Ne feci di già obbietto di minute ricerche (55): la compilazione del Pocabolario Napoletano nell’esame etimologico di quelle voci che agli Arabi è piaciuto a qualche dotto ai attribuire ne dà limI udissima la dimostrazione. Sol poche parole che all’astroogia ed all’alchimia si riferiscono son di forma arabesca, ma veruna forse di arabesca originaria derivazione. E se ci faremo a ricercare il perché quelle parole nell’astrologia e nella chimica passarono; l’origine ne rinverremo negli spacciatori di quelle arti che si dissero occulte, e nel cui gergo piuttosto che nella dottrina si ebbero alternativamente entusiasti ammiratori e nemici acerbi, onorificenze e roghi.
Si evitino intanto le esagerazioni. Non sempre come depredatori e nemici furibondi gli Arabi scendevano tra noi, ma non di rado come guerrieri alleati e commercianti (56); e malgrado la diversa indole del cristianesimo e dell’islamismo e l’antipatia di religione che divideva i due popoli ad intervalli immensurabili, tale avvicendamento di costumi e di maniere si stabilì nelle classi superiori, che fa sorpresa in chi non riflette quanto possa l’emulazione tra rivali. Il clero cristiano cinse la spada e guerreggiò per la fede alla musulmana: i saracini professarono moderazione e tolleranza di religione alla cristiana: mentre i guerrieri delle due credenze gareggiavano tra loro in valore ed in cortesia. Ed è questa la vera influenza degli Arabi nella brillante epoca della cavalleria, nella età vale a dire de’ semidei del medio evo (57). Ma il basso popolo, ma il basso clero, tutt’i cronisti di quella età, non altrimenti che come figli dell’inferno i settatori dell’islamismo aborrivano e con colori abominandi li dipinsero, sia che di Ario li riputassero ultrasettatori, come piacque all’Alighieri definir Maometto giù tra gli eretici promotore di scandalo e di scisma, sia che con colori anche più neri venissero tratteggiati. La qual peste, se in occidente non mancò di andar quà e là nel primo concetto serpeggiando tra quei guerrieri che di stipendiati del signor di Bizanzio in dominatori si trasformarono, dalla chiesa latina fu sempre avuta in orrore. E quell’orrore nella classe de’ volgari tenacemente abbarbicato, sol tardi videsi alquanto infievolire, svelto affano non mai.
Gl’Iconoclasti
E acerbissima fu pei cuori italiani la temerità di quei semisettatori dell’islamismo i quali delle sacre imagini spogliar voleauo le nostre chiese: onde le ultime aneli a s’infransero che ai bizantini ci legavano, e di un imperio latino sorger fece il pensiero di ristabilire la dignità (58).
A quest’epoca, del volgare idioma frequentissimi appaiono i vestigi e non rari i documenti. Solenne testimonio ne fa il giuramento de’ figli di Carlo nella pace fermata a Strasburgo (59): l’elogio di un Papa per addestrare i popoli alla perizia nelle tre lingue allor vigenti, la volgare, la tedesca, la latina (60) e Te più antiche scritture delle lingue romane ad un comune sistema, gramaticale non solo ma ortografico, modellate in guisa, che assai di sovente nel dubbio ti rimani se pronunziar si deggiano coll’accento del romano vallone o ibero o occitanico, ovvero nella compressa o spianata profferenza del bel paese che Apennin parte il mar circonda e l’Alpe; perciocché due realmente sono lo differenze spiccanti delle italiche profferenze, dalla flessione degli Apennini determinate, al di là tronca cd energicamente compressa, al di qua sempre attenuata e vocalizzante (61).
Divisione geografica delle lingue romane
La qual condizione non è della sola Italia, ma delle Galli e benanche e della Spagna; ed è notabile come siffatte suddivisioni geografiche, non solo delle fasi dell’antica della media e della moderna storia rendan ragione, ma eziandio delle diversità de’ dialetti le quali con prodigiosa costanza vegliamo quasi da naturali limili circoscritte, e quasi dalla conformazione del suolo e dai diversi gradi delle latitudini definite (62).
Per tre zone corrono da Pirenei al mezzogiorno i tre principali dialetti della penisola lbera, il gallese all’occidente, all’oriente il catalano, il castigliano nel centro, cd è notabile, che non solo i Portoghesi, gli Aragonesi, i Casigliani tre diverse separate centralizzazioni politiche ci mostrino, ma benanche certa diversità nell’indole e nelle consuetudini popolari che la gran potenza della Monarchia Spagnuola non valse a far disparire (63).
E dalla Francia settentrionale alla meridionale facendo passaggio, il romano vallone dal romano occitanico veggia in distinto per quegli stessi confini che già divisero il regno di Parigi dal regno di Àrles, e più innanzi i Galli togati dai braccati.
Ma quel che per noi principalmente formar dee obbietto di ricerca si è la gran divisione de dialetti d Italia per la flessione degli Appennini, e le divisioni successive delle varie italiche provinciale da certo particolare accento determinate, le quali con mirabile uniformità quelle partizioni rammentano da regione a regione che alle antichissime tribù italiane si attribuiscono. Il dottissimo B. Biondelli una bella dimostrazione comunicavane al sesto congresso degli scienziati d’Italia per quel che riguarda l’Italia traspadana (64). Or col rivolgerci all’Italia cisappennina, le medesime tracce si ravvisano.
Una influenza de’ Longobardi ben potrebbe a primo aspetto supporsi in modo generico ne’ popoli dell’Italia settentrionale determinata. Ma ciò non ravvisiamo in quelle regioni cisappennine le quali nel governo longobardico anche più lungamente si rimasero, come ne Marchesati di Toscana e di Spoleti e in quel gran tratto che formò il Ducato Beneventano. Come mai, poste le circostanze non sol medesime ma più continuate, la stessa influenza mancava di effetti? A più lontani tempi dobbiam rivolgere il pensiere, ed a quella federazione italica della quale Roma fu centro, dall’Appennino limitata e dal Rubicone.
E il popolare accento dell’Italia meridionale possiam distinguere in romagnuolo, pugliese, siciliano; perciocché, se non pretto siciliano, molto a quel dialetto inchinante riconoscer dobbiamo il dialetto calabrese; e forse, se lo studio linguistico fosse stato in voga fin dagli antichi tempi, forse nell’isola del pari che nelle prode della penisola che si ebber nome di Magna Grecia quelle differenze si sarebbero ravvisate le quali non senza minuto esame nella nostra età si scorgono.
E romagnuolo dir dobbiamo il toscano del pari che il campano linguaggio, per larghe vedute risguardati: perciocché identico è l’idioma nel quale vegliamo i dettati de’ primi autori volgari, e ben identico e l’idioma de’ Diurnali dello Spinelli, e della Vita del celebre Cola da Rienzo.
Se non che quelle prime scritture, come molte altre posteriori, un idioma esibir ben potevano a’ dialetti inchinante ma il mero dialetto non mai. Quando una lingua popolare si mette in iscritto, sempre ad un sistema ortografico di convenzione si adagia. E il sistema ortografico in que primi tempi convenuto era il latino. Poi un più o meno innoltrato distaccamento si scorge da quell’unico tipo. Viene assai tardi un’adozione speciale di scrittura, e ciò per due divergenti sentieri; l’uno per serbare le tracce delle derivazioni; l’altro per adagiarsi al vezzo di alcune più vagheggiate profferenze (65), Ma sia che l’uno, sia che l’altro pensiere si scelga; rimane sempre fra quegli estremi una larga zona entro la quale dechinando si oscilla, finché non sorgano scritture di modello delle quali le seguenti generazioni si rendano imitatrici. E scrittori di modello prima della grand’epoca delle crociate non sorsero.
La cavalleria e i passaggi oltre mare
La Grecia cominciava a dirozzarsi ed a formare un sol popolo sotto le mura di Troia; e le nazioni europee scossero il giogo dell’ignoranza e le basi fondarono dell’odierna civiltà con le guerre di Troia. Questi due grandi avvenimenti dell’antica e della nuova rigenerazione dell’umana razza formeranno sempre due epoche memorabili da esercitare le meditazioni del filosofo, accendere vivamente l’immaginazione del poeta, ed ogni anima scuotere per alle e care rimembranze.
Non è già che un’idea di risorgimento della italica civiltà dopo il mille sia nei nostri pensieri (66); ma che allora fosse la brillante manifestazione de’ suoi molto innoltrati progressi è óggimai noti più controversa ma istorica tesi.
Quando Alboino corse sino all’ultima punta della penisola, e spingendo il cavallo tra i flutti percuoter della sua lanciata colonna, e questa, disse, sia il confine del regno longobarde; tutte le scintille non si estinguevano dell’antico sapete. Intime relazioni con la corte bizantina si conservarono anche presso il centro della longobardica dominazione; mentre dall’altro canto sempreppiù disvelavasi e propagava quella viva luce che a pensieri di solida prosperità riconduceva l’intelletto umano, forse di soverchio allegarti frivole ed al lusso direm cosi de’ civili raffinamenti deviato.
E nemmeno quelle arti frivole, quel lusso della vecchia civiltà vennero giammai in quell’abbandono che si esagera da chi altro bello non vagheggia oltre a quello che con moderno vocabolo dicesi il bello classico. Certo, non erano più in Costantinopoli le forme gramaticali della lingua d’Omero e di Demostene. Ma i rifuggiti in Italia su la fine del secolo XV, gareggianti co’ nostri, e confortatori di quel bello classicismo che allora tra noi era in pieno progresso, fan testimonio che appo i Greci le buone discipline, se non il valore e la prudenza, del sgoverno, si mantennero sempre in onore.
E del pari, nella nostra Italia ed in tutta la chiesa cristiana, delle eleganze del dir latino non eran dismesse le cure né lo sgramaticar crescente delle carte notariali dopo la ristauraaione dell’imperio d’occidente può fame testimonio, come dagli scrittori della pàtria letteratura, nessuno escluso, si assume. Di quello sgramaticar de’ notai non si fecero ad indagar le cagioni.
Col ristabilirsi d’un imperio latino, il ricordo delle avite grandezze pose in fermentazione per dir così le italiane menti, e co’ pensieri alla ròmana sorse lo studio di rinnovarne l’eleganti forme, di espressione (67). Un latino di molto al dir volgare inchinante era stato quello de’ propagatori del vangelo: e quasi uniforme si sostenne nella liturgia ecclesiastica dei pari che nelle più solenni transazioni della vita civile:. identico è il linguaggio di tutte le leggi barbariche, di tutti gli antichi diplomi del medio;evo. Ma col tornarsi alla imitazione de’ classici, la lingua parlata si trovò di mano. in mano a gran distanza dal migliorato latin chericale, in modo che il popolo non più intendeva il clero ne’ suoi sermoni, e bisognò che le omelie de’ vescovi fosser tradotte nella lingua delle loro plebi (68). Quindi una doppia serie di scrittori ci offrono i secoli che seguono l’età di Carlo Magno. E la prima è quella sempre più elegante degli scrittori nel latino gramaticale; l’altra sempre più barbarizzante e sgramaticata de’ notai i quali un idioma scriveano che né parlavano né imparavano. Ma trasportiamoci a più solide considerazioni, e dalle stesse, vicende che per alcuni è argomento di scandalo, vedrem sorgere quel sistema di ragione universale che forma il diritto delle genti, e la bilancia politica delle rincivilite nazioni, e che gli antichi non conobbero: e son questi i beni reali per l’umanità i quali, sempre per le stesse. cagioni, in quella età s’iniziarono, e di che ora godiamo le felici conseguenze nella età nostra perfezionate. In quel rimescolamento della forza morale e della forza fisica l’equilibrio, di mano in mano si fondava adagiando di quella organizzazione vitale che nel consenso delle varietà il beato Agostino rinveniva, e che con tant’animo vagheggiava Dante, e dipinse in quelle immortali cantiche, nelle quali tutta quanta la biblioteca intellettuale del medio evo trasfuse, e nelle varie fasi pennelleggiò,. d’infortunio, di ammendamento, di pace. Che non altrimenti la civiltà, vera delle nazioni può sorgere se non dall’armonia delle divergenti passioni degli nomini, tutti attenuti alle loro privale utilità (69). Al vedere nelle adunanze di Roncaglia seder giudici i giurisperiti italiani per discutere, e gittar le basi della pubblica felicità nella concordia del Sacerdozio e dell’. Imperio, ed emergerne alfine la famosa pace di Costanza; applauda chi ha fior di senno ai progressi della civiltà vera, ed ascolti col sorriso della compassione i clamori, di qualche retore il qual non fina di lamentare all’ignoranza, perché assai povera vede quella étà di eleganti elegie, e di epigrammi spiritosi.» Nella età delle crociate questa civiltà vera scorgasi in luminoso disviluppamento nella Italia; e quando di Francia, di Germania, d’Inghilterra i crocesegnati la transitarono, le ricchezze vi ammiravano d’una civiltà di molto innoltrata, il lusso, il governo, gli studi (70) e soprattutto quel fuoco centrale delle celesti dottrine che nella fede, nella lealtà, nell’amore animava i petti de’ cavalieri della Croce (71).
La Corte di Sicilia
Tali erano gl’Italiani quando il testamento di Costanza (72) affidava al bai iato d’Innocenzo III il giovinetto Federico Ruggieri, erede della gloria e de’ dritti della più illustre e potente casa di Germania, e successore al trono dei Normanni in tanta e si bella parte delle provincie italiche lo tiro un velo su i delitti politici di questo principe (73): lo stesso Dante, il più calda forse, il più passionato encomiator di lui, dovi pure cacciarlo negli avelli e tra le fiamme sparte dello, città dolente (74) Risguardiamolo soltanto dal lato delle sue virtù, e d giovi vagheggiarne il ritratto rise ne tramandarono gli stessi suoi nemici. a Federico, dice un zelante guelfo (75), fu uomo di gran valore e di grande affaire: savio di scrittura e di natural senno: universale in tutte le cose: seppe la lingua latina e la nostra volgare, e ’l tedesco, francese, greco e saracinesco. fu di tutte virtù copioso s largo e cortese in donare: e savio in arme: e fu molto temuto.
» E lo s te sto avea detto Rico Alano Malespina (76). E lo stesso ripetevano altri cronisti non al certo solleciti della sua fama (77). Per le quali testimoniarne l’elogio si conforta che ne intesseva uno scrittor ghibellino alla corte del di lui figliuolo Manfredi (78). »
Federico, ei dice (79), fu uomo di gran cuore: ma la somma sua sapienza ne moderava la magnanimità; di modo che le azioni di lui non procedevano giammai da impetuosa passione, ma sempre da maturità di giudizio,.. Amò la filosofia, della quale fu studioso e propagatore negli stati suoi. Apri scuola per le scienze e per le arti liberali tutte; chiamando con isplendidi premi da ogni parte del mondo i più rinomati professori. Né a questi soli accordava generosi stipendi; ma dal proprio tesoro prendeva di che pagare il mantenimento de’ poveri scolari, acciò nessun uomo, di qualunque condizione si fosse, per povertà venisse costretto a lasciare lo studio della filosofia. E diede egli stesso non dubbie pruove delle sue letterarie occupazioni, rivolte principalmente alla storia naturale, avendo scritto un libro della natura e della cura degli uccelli (80). Amò la giustizia; e la rispettò talmente, che tutti i sudditi suoi potevano liberamente piatire centro di lui, senza che vantaggio alcuno il suo grado gli desse appo i tribunali o avvocato qualunque facesse difficoltà di patrocinare contro l’imperatore la ragione de’ sudditi: malgrado però tanto amore per la giustizia, non lasciava egli di temperarne talvolta il rigore con la clemenza». E un tal genere di encomi rende cara insiememente la memoria del lodato e del lodatore e della età che lodi di tal fatta sol comportava.
All’ombra del santo albero della 3rasfiia e della filosofia ricoverano le muse: ed è bello il rammentare che i pastori. di Capoa, di Troia, di Palermo e di Monreale, sotto la direzione di un Papa, ne fossero stati i coltivatori (81). Dopo aver veduto per opera del clero ristabilito il fervore per le scienze e per l’eleganza del bel dire dei secolo di Angusto, per opera dello stesso clero or reggiamo la lingua volgare trasportata nella più brillante corte d’Italia per divenire, su le rovine del comun romano, il più energico e insiememente gentil linguaggio della moderna civiltà europea» Delle varie preferenze del comun romano, la provenzale era in voga al declinare del secolo XII; e la predicazione della prima crociata in Chiaro»ente, e lo zelo che per quella e per le posteriori spiegarono i principi e i granai baroni della lingua d’oc, ne furono la principal cagione (82). L’educazione cavalleresca non era compiuta se alla bravura e alla destrezza nell’armeggiare non si fosse unita l’arte di trovar gentilmente in versi: E gli educatori di Federico non trascurarono di aggiugnere quest’altro frégio alle qualità eminenti che in lui disvilupparono. Ma per rendere quel principe affatto nazionale, per legarlo agl’interessi della comun patria, e per fare dall’altro canto che a lui si’ rivolgessero tutti gli animi che l’odio antico de natii pe’ teutonici (83) e le crudeltà di Arrigo (84) avean tenuto fino allora divisi; anche quel non so che di strano in lui non vollero che dall’accento occitanico avrebbe potute contrarre; e al linguaggio del si, già da lunga stagione in Roma dirozzato (85), il grande alunno educarono.
Carattere della lingua e della poesia aulica
Ed emula, non imitatrice della provenzale fa la lingua e la poesia italiana alla corte di Federico: chè nel vigore ai maschia gioventù scendeva allora con quella al paragone, e le vergini muse fra que’ boschetti ritornavano e pressa quelle limpide acque e Sotto quella serenità di cielo che i gentili pensieri inspirati aveano al cantor di Aretusa ne’ più soavi de’ numeri. Chepperò nella Corte di Sicilia, non già gli esordi, com’è comune dettato, della lingua e della poesia italiana si vuol ripetere, ma l’iniziativa al miglioramento dello stile, e il primo germe di quel parlare cortigiano che fruttò poi all’Italia la sua lingua letterata. Perciocché tutti coloro ch’erano d’alto cuore e di grazie dotati, di aderir si sforzavano alla maestà di Federico Cesare e del ben nato suo figliuolo Manfredi, e tutto ciò che in quel tempo gli eccellenti Italiani componevano tutto usciva dalla Corte di si alti monarchi (86)». La quale ogni maniera di gentilezze flettendo in cima. e il più bel fiore accogliendo dell’ingegno e del sapere italico, sola sceverar potea di mano in mano la volgar favella da’ rozzi vocaboli, dalle perplesse costruzioni, dalle difettive pronunzie, dagli accenti plebei e contadineschi ed a magistero alzarla ed a potenza. Imperciocché, uso di volgo non ridurrà giammai le umane loquele a certa ed ordinata ragione (87); e dall’altro canto, senza il. gentil conversare, di certa ruggine accademica gl’isolati scrittori difficilmente si tergono (88). Ma alla corte de’ principi siciliani, com’era il desiderio di Platone, i filosofi convenivano nel tempio delle Grazie: e però il primo tipo di quella lingua aulica e illustre emergeva, la quale è di tutte le città italiche e non pare che sia di niuna, con la quale i nostri volgari tutti s’hanno a misurare, ponderare, paragonare (89). Per la qual cosa, comecchè il volgare siciliano acquistasse fama sopra gli altri, e tutti i poemi che si produssero sino al trecento dagl’italici si chiamassero poi siciliani (90); non ai soli Trovatori di quell’isola, ma a tutta quanta la famiglia italica attribuir si vuole la gloria di aver cooperato alla magnanima impresa di spingere a grandezza ed a venustà il comune materno idioma. Non altrimenti del nobile dir lattino, fra quanti scrittori concorsero a sublimarne e confortarne il decoro, il solo Cesare ebbe in Roma i natali.
Pier Francesco Giambullari (91) recita un sonetto di un Agatone Drusi a Cino da Pistoia del quale son questi i primi versi:
» Se il grande avolo mio che fu il primiero;
Che il parlar sicilian giunse col nostro,
Lasciato avesse un’opera d’inchiostro
Come sempre ch’ei visse ebbe in pensiero;
Non sarebbe oggi in pregio il buon Romeo, ec.
Quel grande avolo di Agatone dice il Giambullari, come si rileva da antiche memorie si chiamò Lucio Drusi, uomo faceto e dotto, il quale scrisse in rima un libro delle virtù ed un alito della vita amorosa, t quali portando egli in Sicilia al Re» per fortuna gli porse in mare: cu che dolendosi fuori di modo» poco dopo morì. Quel Re di Sicilia esser dovea Guglielmo IL, splendido protettore de’ dotti, ei prosegue, e quel giugnere il parlare siciliano al dialetto consisteva nel terminare con una vocale, all’usanza de’ Siciliani, le voci che prima latinamente terminavansi per lo più con una consonante. Della quale mferpetraziotie si è fatto poi. propugnatore anche il Perticar! (92). Ma noi abbiam già veduto che non già nella sola Sicilia; ma per tutta quanta l’Italia cisappennma, e fin dalla età precedente alla formazione del latin letterato, tutte le parole in vocale si conchiudevano. E se non a’ tempi di Guglielmo II, protrar si volesse; indubitatamente a quelli di Federico o di Manfredi vuoisi riferire l’aneddoto che da quelle antiche memorie il Giambullari ritrasse, e del quale impugnar non mi piace l’autenticità, malgrado quel che ne disse il Tiratoseli? (93) dopo il Crescimbeni e il Salvini (94). In Sicilia i Pisani faceano scala per le loro fattorie m Levatole: e limpidissima è la storia che depone le loro intime relazioni con la nostra Corte e come più di qualunque altro popolo le cose siciliane e il partito imperiale caldeggiassero. Chepperò, non già per apprendere a vocalizzar le parole i begl’ingegni d’Italia alla corte di Sicilia convenivano, ma per educarsi a quel dir gentile che di già sopra tutti i dialetti plebei soprastava non escluso il plebeo dialetto siciliano anch’esso, comunque al vezzo dell’accento Sicilia-, no tutti i nostri scrittori manifestamente si veggano inchinati. Del resto manifesta cosa è che non avea bisogno un Toscano di andare in Sicilia per cpochiudere le sue parole in vocale.
I trovatori siciliani
In una edizione delle poesie del XIII e XIV secolo fatta in Palermo non si registrano quelle de primi poeti di Sicilia, con la protesta di volerne fare osa pubblicazione a parte per restituirle alla vera lezione secondo le leggi del patrio dialetto. Non altrimenti al nostro Galiani mancò poco che non volesse napolitanizzare, e non sarebbe stato difficile, e Fra Guittone e ser Brunetto. No: non v’ha autore antico il qual dettasse le sue prose et le sue canzoni nel pretto linguaggio del volgo. Si scorge indubitatamente in esse più o meno di pendenza al patrio dialetto: il mero dialetto non mai (95).
Quel Ciullo d’Alcamo che si proclama tuttavia come il più antico tra i poeti d’Italia, e pe’ rimproveri dell’Alighieri creder si potrebbe che avesse adoperato il basso dialetto di Sicilia, mostra evidentissimi argomenti di aver fatto studio di elevarsi anch’egli. al dir cortigiano, comunque dalla umiltà del dire popolaresco non mai si, sollevi. Egli nel suo celebre amebeo altro non si appalesa che un Giullare alla Corte di Federico (96). Ma facciamoci ad ascoltare cantori non plebei.
RINALDO D AQUINO (97).
Oramai quando flore
E mostrano verdura
Le prata e la rivera;
Gli augei fanno sbaldore.
Dentro’ de la frondura
Cantando in lor manera.
La dolce primavera
Vene presente
E frescamente
E si frondita….
Ciascuno invita – ad aver gioia intera.
Confortami ad amare.
L’aulimento de’ fiori
E ’l canto degli augelli.
Quando lo giorno appare.
Sento li dolci ancori.
E li versi novelli
Che fan sì dolci e belli
E divisati.
Ne’ lor trovati,
A provagione,
A gran tenzone – su per gli arboscelli.
Quando l’alloda intendo
E ’l rusignuol vernare,
D’amor lo cor m’affina.
E maggiormente intendo
Che ‘l legno del truffare
E7 d’arder non rifina.
Vedendo quell’ombrina.
Del fresco bosco,.
Bene conosco
Che certamente,
Sarà gaudente – l’amor che m’inchina.
Nchina, ch’co sono amata
E giammai non amai;
Ma il tempo m’innammora;
E fammi star pensata
D’aver mercede omai
D’un fante che m’adora.
E saccio che tuttora
Per me sostene ‘Di grandi pene.
L’un cor mi dice.
Che si disdice e l’altro mi rincora.
Però io prego Amore
Che m intenda e mi svoglia
Come foglia lo vento.
Che non mi faccia fore
Quel ch’è preso mi taglia,
E stia di me contento.
Quegli che ha intendimento,
Or che inavanza
Gioia e ha certanza
De lo mio amore,
Senza rumore – men dea compimento.
Udiamone un altro de’ più antichi.
ODO DELLE COLONNE (98).
Oi lassa innammorata!
Contar vò la mia vita,
E dire ogni fiata
Come l’amor m’invita:
Ch’io son senza peccata
Co’ assai pene guernita
Per uno ch’amo e voglio
E non aggio in mia baglia
Sì come avere soglio;
Però pato travaglia:
Ed or mi mena orgoglio,
Lo cor mi tende e taglia.
Oi lassa tapinella!
Come r amor m’ha prisa!
Che lo mio amor m’appella
Quello che m’ha conquisa;
La sua persona bella
Tolto m’ha gioco e risa
Ed barai messa in pena
Ed in tormento forte:
Mai non credo aver bene
Se non m’accorre morte:
E sperala che vene,
Traggami d està sorte.
Lassa! che mi dicia
Tenendomi in, celalo!
» Di tene, vita mia,
» Mi tegno più pagato.
» Che s io avessi in balia
» Lo mondo assignorato.
E dormo à disdegnanza
E fami conoscenza.
Ch’aggia d’altra amanza…
O Dio, chi lo mìintenza
Mora di mala lanza
E senza penitenza.
O ria ventura e fera!
Trami d’esto penare:
Fa tosto, fa ch’io pera,
Se non mi degna amare;
Ho mio sire: che m’era
Dolce lo suo parlare!
Ed hami innammorata
Di sene oltre misura.
Ora s’e’ m’ ha cangiata,
Sacciate, s’e mi dura,
Siccome disperata
Mi metto alla ventura.
Va, canzonetta fina,
Al bono avventuroso.
Ferilo alla corina
Se il trovi disdegnoso.
Noi ferir di rapina
Che sia troppo gravoso.
Ma feri lei che ’l tene,
Ancidela san’ fallo.
Poi fa che torni a mene
Lo viso di cristallo;
E sarò fuor di pene
E avrò, allegrezza e gallo.
E che altro manca in queste due dilicatissime cosettine, fuorché maggiore sveltezza nella dizione? Che v’ha di simile tra i Provenzali? Chi non vuole illudersi con immaginose fantasie, non dirà giammai che un linguaggio nascer possa perfettissimo e giugner d’un salto all’apogeo della sua gentilezza, come Fallacie di tutt arme armata sorgea dal cervello di Giove. Esser non poteano i Virgili, e gli Orazi, se gli Enni e i Pacuvi non li precedevano, preceduti anch’essi dagli autori dall’orrido numero saturnio (99) i senza i settanta che prima dell’Omero di Licurgo dissero i fatti di Troia non avremmo l’Iliade (100). E venga egli stesso a mostrarsi
L’imperador Federico (101).
Poiché ti piace, Amore,
Che aneli’ io deggia trovare.
Farò ogni mia possanza
Ch’io venga a compimento.
Dato aggio lo mio core
In voi, Madonna, amare,
E tutta mia speranza
In vostro piacimento.
E non mi partiraggio
Da voi, Donna piacente:
ché i’ v’amo dolcemente
E piace a voi ch’io aggia intendimento.
Valimento mi date, Donna fina,
ché lo mio core adesso a voi s’inchina.
S’eo nchino, ragion aggio.
Di sì amoroso bene:
ché spero e vo sperando
Che ancora eo deggia avire
Allegro mio coraggio
E tutta la mia spene.
Fui dato in voi amando
Ed in vostro volire.
E veggio a li sembianti.
Di voi, chiarita spera,
Che aspetto gioia intera:
Ed ho fidanza che lo mio servire.
Aggia a piàcire a voi che siete fiore
Su l’altre donne e avete più valore.
Valor su l’altre avete
E tutta conoscenza.
Null’uomo non potrìa
Vostro pregio contare,
Dì tanto nella siete!
Secondo mia credenza,
Donna non è che sia
Alta e sì bella a pare.
Or ch’aggio insegnamento.
Di voi, Donna sovrana,
La vostra cera umana
Mi dà conforto e facemi allegrare.
Allegrare mi posso, Donna mia:
Più conto me ne legno tuttavia.
Tale e non altra era la gentilezza che nel dir volgare s introduceva: tale e non altro lo stile di que’ Siciliani che fur già primi; e se poi eran da sezzo (102), nelle necessarie condizioni delle cose umane son da cercarsene le cagioni, ed in quella legge dì perfettibilità che l’Eterno stabili nel crear l’uomo, primo essere e dominatore della natura sublunare.
Quando le muse italiane ebber seggio nella corte di Federico, daj più chiari ingegni di quella età vennero festeggiate: i quali, da’ puri fonti del greco e del latino attignendo, di quella belletta vievia le tergevano di che pel lungo conversar con le plebi eran lorde o pel mal vezzo di affettar fogge straniere di soverchio azzimate. A purgarle però di quelle macchie lunga esser dovea l’opera e faticosa: e lo stesso Dante, lo stesso Petrarca non tornarono felici affatto da tanta impresa. Era necessario che prima fosse sorto il secolo XVI; che tutta intera si adisse prima la preziosa eredità degli antichi; che le forme visibili del bello fosser poste in chiara luce ed emulate; che la ragione riconquistasse i suoi diritti ed allo levasse la fronte sii le infrante catene della scolastica: per vedere finalmente le muse italiane in tutto lo splendore di loro venustà assidersi a fianco delle greche e delle latine, a contender con quelle i primi onori. Ma per giugnerc a tanta altezza i Trovatori del secolo XIII di già s’ addestravano alla corte di Federico.
La lingua aulica del dugento
La gran differenza che distingue e distinguerà mai sempre una lingua gentile da’ dialetti plebei, non tanto in quelle guaste voci è da cercarsi che il volgo ignorante, non conoscendene i temi, andò e andrà sempre sfigurane do e tramutando in allusioni a parole note; quanto nella formazione di quelle parole e di que’ modi che. soltanto ad abbiette costumanze alludono ed a vili mestieri (103). Non è possibil cosa che il linguaggio umano di tante parole si componga per quanti sono gli obbietti da indicare, per quante le relazioni che tra obbietto ed obbietto si ravvisano, e molto più pei progressi della intelligenza che quegli obbietti e quelle relazioni variamente concepisce e va poi di mano in mano analizzando. Ora sceverate da un linguaggio popolare tutto ciò che v’ha di bastardume per le parole di origine ignota; sceveratelo da tutta la feccia delle allusioni alle arti sordide ed a costumi di più o meno radicate turpitudini; ed un linguaggio nobile, gentile ed eminentemente cortigiano ne emergerà da se stesso in bocca di quei generosi, che di quel bastardume e di quelle sordidezze lenendosi a guardia, quando Natura spira notano, ed a quel modo che detta dentro van significando. Così sorge un linguaggio non più circoscritto tra i confini d’un chiassuolo o di un mercato, e sia pure popoloso e vecchio; ma sibbene al concorso adagiabile di quanti all1 unico scopo di gareggiare per nobili sentimenti e cortesi maniere convengono, sia nelle signorili sale de’ grandi, sia nelle amene società delle gentili persone a nobiltà ed elevatezza di animo e di pensieri educate. E così e non altrimenti sorse la buona lingua italiana alla corte di Federico e del suo figliuolo Manfredi. Così per tutte le corti bandite d’Italia venne di mano in mano adottata. E così, dopo l’abbassamento della fortuna sveva, ebbe in tutta quanta la penisola, ed eminentemente nella università di Bologna, dove il più bel fiore dell’italica regione concorreva a studio di scienze e di squisiti costumi, sviluppamene non solo, ma quasi dir potrebbesi perfezionamento intero. E così finalmente quel linguaggio si ottenne vagheggiato dall’Alighieri, che mentre in tutte le città italiche appariva, non rinvenivasi in alcuna.
Inchinantissimì al dir siciliano, ed anche più delle or trascritte canzoni, sono i trovati de’ primi scrittori del secolo XII (104); ma nel secolo stesso a mirabile miglioramento il dir gentile di tutta quanta l’Italia progrediva: delle diverse municipali profferenze in l’uno, all’altro di mano correggitrice; cd in tutta quanta l’Italia vuol cercarsi del gentile aulico linguaggio il perfezionamento.
Il provenzale e il latino
E se nella scelta del dir gentile molle parole si rinvengono e molte locuzioni de’ trovatori provenzali le quali, dismesse in seguito, s incontrar! di frequente nei primi scrittori della buona lingua italiana; è da riflettere che non come di origine esclusiva della lingua d’oc, ma come parole dettate dallo spirito di cavalleria e di galanteria dominante in quella età voglian considerarsi: le quali e comuni si scorgono in tutte le lingue romane tra le alte classi gentili, e non sono al certo plebee parole e nemmen da giullari. Che se da questo lato soltanto riguardar si voglia l’influenza del provenzale; converremo pienamente col Bembo e con gli altri scrittori che ai pensieri di quej porporato aderirono. E però far non dee maraviglia se parole e modi del gentil conversare si rendesser comuni ai trovatori provenzali e nostri. Ma è notabile che tutto quello che di tal provenzalismo ne primi nostri scrittori s’incontra andasse poi di mano in mano a mancare, ed allora precisamente che di più in più avrebbe dovuto andarsi radicando, allora appunto che un principe di Provenza venne in Italia non solo Re delle Sicilie, ma senator di Roma e signor di Toscana e di tutte quante le città guelfe guelfizzate sapremo moderatore e sostegno: mentre dall’altro canto anche la sede pontificia fu in Avignone trasportata. E pure ogni provenzalismo dalla venuta di Carlo in poi nell’Italia si estinse; e se qualche traccia ne veggiam tuttavia nel Petrarca, sempre a raffinamento di gentilezza attribuir si dee, come nelle Ciento novelle che la designazione meritò di conservatrici del dir gentile (105).
Intanto, un altro elemento di perfezione nel bel dire italiano s’introduceva. Quando i gentili scrittori nel volgare italiano o latini dettati traslatavano o non soli sospiri di amore esprimer volevano, era natural cosa che non solo per analogia e legittimità di famiglia molte parole dal latino riproducessero, ma tentassero altresi d imitarne il fraseggio e la costruzione. Nel correre il quale aringo era ben da attendersi che dapprima non infrequentemente dal retto sentiere si delirasse. E però non sembrano ragionevoli i grandi clamori che contro il festivo novellatore da Certaldo e gl’imitatori di lui si van ripetendo. Non delle imitazioni dal latino, ma della soverchia proclività al dipingere costumi e produrre locuzioni da trivio lamentar dobbiamo nel più elegante scrittor di prosa in una lingua con la quale non guari tempo prima chiamavasi mamma e babbo (106). E Virgilio, non già il cinguettar delle trecche, avea dettato a Dante lo bello stile che gli fece onore (107).
Gli storici della patria letteratura sono affatto silenziosi sul modo adottato fin dal dugento di tali costruzioni alla latina: e però ci si condoni se qui ci facciamo a riempire in parte una tal lacuna.
E ci piace trame un primo esempio da quel male calunniato Fra Guittone il quale per gli acerbi detti dell’Alighieri, quasi tra le sole plebee sozzure arrabattato, nella fantasia ci si dipinge. No, quel Guittone né di cuore mancava né d’ingegno: e non sempre è il suo dire dal lazzo delle plebi inquinato. Ne faccian pruova questi tratti del sermone che ei tenne a Fiorentini quando tra lor parteggiando perdevano la patria:
Vedete voi se la vostra terra è città e se voi cittadini uomini siete! E dovete savere che città non fanno già palagi né rughe belle, né nomo persona bella né drappi ricchi; ma legge naturale, ordinata a giustizia, e pace e gaudio infeudo che fa città: e uomo a ragione e sapienza, e costumi onesti e retti bene
Non unghie né denti grandi diede natura all’uomo, ma membra soavi e lievi, e figura benigna e mansueta: mostrando a che non feroce, e non nocente esser dea, ma pacifico a e dolce, e utilità prestando. E Dio rinchiuse solo in a caritade la profezia e la legge: e chi carità empie, a empie ogni giustizia ed ogni bene. Miseri! come duna que l’odiate tanto? O forsennati e rabbiosi, venati a come cani mordendo l’uno e divorando l’altro! Che a peccato grande e disnaturata e laida cosa l’uomo offendere all’uomo, e spezialmente al domestico suo! Non a è già fera crudele tanto che il suo simile offenda. Oh a non Fiorentini, ma disfiorati e disfogliati e infranti! Sta a voi quasi sepolcro la terra vostra non mai partendo, d’essa, mostrando, e alle genti il vostro obbrobrio spargendo. Che non è meretrice audace più che a ognuno di voi che riesce a mostrarsi poiché la sua faccia di tanta onta è lorda, ec. (108).
Non può dirsi al certo che il bisogno di conchiudere in rima alcuni concetti avesse determinato i nostri primi trovatori a quelle che diconsi trasposizioni da chi, al solo volgare del Romano transalpino educati, sì fanno a credere che costruzion naturale sia quella soltanto la quale, con successione inflessibile, fa che al verbo proceder sempre deggia il suo soggetto, e l’obietto seguirlo: che anzi costruzione dettata da natura e non da arte, come nel balbetare de’ fanciulli osserviamo, si è quella d’indicare dapprima l’obietto, e finalmente col verbo una proposizione conchiudere. Del resto anche al di la de’ giusti limiti protratta, veggiamo non pochi poemi a modo della costruzione farina ordinati, fin dal dugento: del che citeremo quasi antesignano e Caposcuola quel Pannaccio da Bagno, pisano, nel quale ci rimangono ben quattordici canzoni e molti sonetti ch’ei variò d’ogni maniera. Il $u dire pende sempre più alla veemenza oratoria che alla lindura poetica. Aspri anzi che no, duri sono i suoi versi; ma pieni, vigorosi, e pensar ti fanno. Delle quattordici canzoni, cinque soltanto son d’amore, e queste senza le ordinarie languidézze e i raffinati pensieruzzi: e sempre con maschio ardire tentando impervii sentieri e fin là non di rado penetrando donde poi mosse l’Alighieri per innoltrarsi alla immortalità. Ne trascriveremo qualche tratto in piè di pagina (109).
Molto alla scuola bolognese dee l’Italia pel perfezionamento del suo linguaggio, ma ingratitudine è l’aver posto in dimenticanza la scuola pisana: ingratitudine porre da banda que’ generosi che, comunque non sempre felicemente,
Per correr miglior acqua alzati le vele,
e ne’ loro stessi naufragi nuove strade additano e nuovi mondi (110).
Il nuovo stile
Nell’incontrarsi che finge l’Alighieri in Purgatorio con Buonaggiunta Urbiciani, fa ch’ei venga da quel Lucchese riconosciuto come colui che fuore
Trasse le buone rime, incominciando:.
Donne ohe avete intelletto d’amore.
E fa poi che prosegua:
O frate! issa vegg’ io, il nodo
Che ’l Notaio e Guittone e me ritenne
Dì quà dal dolce stil nuovo ch’i’ odo.
Or quali erano quelle buone rime quale quel nuovo stile? —Se interroghiamo lo stesso Dante, egli ce ne farà instruiti in quelle pagine del Volgare eloquio, in quella erculea fatica con la quale a purgar si rivolse la volgar favella da ogni plebea sordidezza, e a gittar fuori della selva d Italia, com’ei diceva, gli alberi attraversati e le spine (111). E, senza entrare in briga su la ricerca di quell’anonimo notaio (112), né Buonagiunta Urbiciani in Purgatorio soltanto ebbe rammaricò di essersi di troppo compiaciuto de’ modi plebei (113): né, come vedremo, la fama di Fra Guittone vuol riputarsi del tutto mal meritata (114). E forse non è strana cosa il supporre che non già come scrittori non degni di lode nella infanzia del bel dire italiano erano presi a bersaglio ne rimbrotti di quell’acre ingegno, ma perché li vedea riputati come scrittori di modello in un linguaggio per le cure di tutta l’italica gente a progressiva perfettibilità avviato; e cessino, esclamava, i seguaci della ignoranza i quali estollono Guittone di Arezzo ed alcuni altri che sogliono sempre nelle parole e ne9modi somigliare alla plebe (115); che per loro naturale infingardia sonò oche e non vogliono l’aquila che (diamente vola imitare (116); che disperati a ogni dottrina, non si muovono da nullo principio (117), furibondi in questa ebrietà di credere illustri le loro plebee loquele (118), non altrimenti che ciechi i quali si erodessero distinguere i colori (119)cessino quella presunzione.
E che tale e non altra fosse stata la cagione di quell’ira dantesca, chiaro si mostra e dal come il Petrarca ci diK fra Guiitone nel Trionfo d? Amore (120), e dal come isso Alighieri nel suo maggior poema la progressiva sorte del bel dire ci va penuelieggiando, sempremai alla condizione dello sviluppamelo degl’ingegni adagiata: perciocché nella sola povertà dell’inverno il poco verde può aversi in pregio (121), e la fama de’ buoni 9II’ apparir de’ migliori si dilegua (122).
Il buon secolo
Dobbiamo a mere brighe municipali ed a pedantesche improntitudini l’origine e la conservazione di un tal nome: quelle da nobile affetto suscitate per le patrie cose: affetto indistaccabile dalle generose anime e sempremai rispettabile anche se al di là de’ giusti limiti si tragga; ma sol confortate le altre da quell’orgoglio accorto che trova agevole l’andar su senza le ale dell’ingegno e con la poca fatica delle compilazioni, e tanto più poca quanto più stretti sen raccorcino i confini, e poi, ad esempio, farsi cosi maestro su l’Adige del dir, non meritino da doversi ricondurre su l’Arno. Ma quelle gare e quell’orgoglio non sono più. Tutta l’Italia rispetta nella Toscana la patria di quella tergemina luce che fece chiaro il trecento, di que pazientissimi che di mano in mano corressero le vecchie scritture, dalle plebee rustichezze non solo ma da l’errate costruzioni sceverandole: mentre dall’altro canto di Toscana più altamente suona la voce: Non doversi l’’italico idioma riputar lingua morta e niente altro concedersi agli odierni scrittori oltre al miserabile vanto di una più o meno approssimata imitazion dall’antico (123). Quanti scrittori che già si dissero del buon secolo, al quattrocento or si appartengono!…. La sola invenzione della stampa fece il discredito del quattrocento, perché le scritture vennero a luce com’eran dettate prima che divenissero buoni testi. Ed ora non è problema ma teorema storica mostrar prima del cinquecento oscillanti tuttavia le condizioni ortografiche non solo, ma l’andamento gramaticale anch’esso, e sempre, nessuna delle scritture esclusa, al natio dialetto inchinanti (124). Toccò la lingua italica l’apogeo della sua perfezione sol quando le antiche scritture divennero buoni testi, quando di una gramatica italiana fu convenuta la lessigrafia, e determinossi quella linea di confine che il comune italico idioma da’ suoi dialetti distacca.
Conchiusione
Ben disse il Tiraboschi su la convenienza del tardivo sorgere di una gramatica italiana non prima del secolo XVI.
» Se prima non lasciasi a gli scrittori libero il corso, sicché possa ognuno usare quelle espressioni e quelle parole che più sembrino opportune, e appena nata vogliasi essa ristringere entro determinati, confini, non formerassi mai una lingua copiosa e perfetta. Ma dappoiché col volger degli anni essa si è arricchita e può bastare per se medesima a spiegare i sentimenti tutti dell’animo, allora, osservando le leggi che hanno comunemente osservate i più applauditi scrittori e le avvertenze con le quali a comun giudizio si rende più soave e più armonioso lo stile, si posson esse ridurre a certi determinati principi; e senza ristringer la lingua in modo che nulla più le si possa aggiugner di nuovo, fissar le regole con le quali abbia a parlare e a scrivere correttamente».
A che dunque lo studio de’ dialetti? A quale scopo la compilazione del nostro vocabolario? À far che le plebi anch’esse alla nobiltà si elevino del comune idioma: e addestrar tutti a sempreppiù dismettersi vievia da’ volgari idiotismi. Non v’ha gentilezza vera in un popolo, se nelle più basse classi non abbarbica della ch’il comunanza: é sol di grado in grado a miglioramento si perviene.
Il Far sé centro dell’universo, poneva a gran senno per prima dignità delle sue meditazioni il nostro Vico, e nelle condizioni della infanzia degl’individui e delle nazioni; e gli acutissimi ingegni di un S. Agostino, di un Leibnitz, vagheggiavano la perfezione e l’armonia dell’universo imposta dal Creatore, nel mondo fisico del pari che nei morale, nella mutua concorrenza, nel consenso delle varietà.
Vedemmo ne’ primi barlumi della Storia italica spandersi la progenie degli audaci figli di Giapeto da’ monti centrali, e dalla più alta vetta degli Appennini diramarsi per tutta la penisola, e distendersi anche oltre le Alpi; e poi nel meriggio della luce istorica vivere tuttavia quell’avito idioma nelle sue caratteristiche forme anche quando l’ellenico linguaggio e il laziale, in linguaggio letterato si affazzonavano: il quale popolar linguaggio il più antico de’ nostri gramatici nel caso latino caratterizzava, caso ch’ei sol riconosceva come caso naturale, e dei quale nell’idioma ellenico altresì riconoscer possiamo i vestigi, ma che nel solo latino idioma invariato serbossi, comunque lievemente per varie profferenze distinto. E un tal linguaggio da popolo formar vedemmo tuttavia le delizie di Roma ne’ più bei giorni della sua floridezza, e propagarsi e stabilmente radicarsi ovunque le aquile latine spinsero il loro volo, ovunque della federazione latina si ebbero stazioni e colonie.
Cosi a fronte di un comun linguaggio ridotto a scrittura vari dialetti romani sorgevano, i quali ben possiamo per minute considerazioni in tanti altri dialetti suddiviere, per quanti sono i ricinti che un muro ed una fossa serra, ma poi di mano in mano andarli raggruppando per quante, sono le regioni dall’altezza de’ monti circonvallate. Così del romano idioma non altro che dialetti riguardar dobbiamo a grandi compartimenti le lingue del mezzogiorno di Europa, che l’Alighieri differenziava con la sola caratteristica della particella affermativa.
Così le razze romane o romanizzate, anche in un sol popolo fuso nella gran federazione entro la gran siepe delle Alpi illimitata riconoscere dobbiamo; e non altro essere là lingua d’Oc se non l’italico linguaggio modellato all’accento italico della gran valle del Po, traboccata poi con romani costumi in quella regione che di provincia romana si ebbe il nome.
Con la predicazione del Vangelo questo italico linguaggio da popolo venne di mano in mano a dismetter le tante diversità di sembianza, e di lingua chericale si ebbe il nome. La quale, divenuta poi aulica e gentile alla corte di Federico Ruggieri, ed appunto per opera del clero, crebbe vievia sempre più in venustà e gentilezza, tal che nella età del grand’Esule di Firenze era già quella che in tutte le città italiche appariva; e non rinvengasi in alcuna. E che la nobiltà dell’aulico linguaggio fin da quella stagione dal più bel fiore di tutti gl’italici dialetti si componesse, manifestazione limpidissima ne danno le immortali Cantiche dei Ire regni in quella energia di dettalo, che di tutti quanti gl’italici dialetti manifesta la fusione. Perciocché, per non dire altro, que’ troncamenti che il dir nobile italiano adottava, caratteristica de’ dialetti di tutt’i volghi d’Italia oltre la flessione degli Appennini, si, que’ troncamenti son quel li che han rafforzata, nobilitata, illegiadrita la profferenza de’ volghi meridionali, sempre vocalizzante, e perciò di soverchio molle e dolciata.
Cosi tutte le città italiche come già concorsero fin da suoi primordi, concorrer deggiono tuttavia anche ora per provvedere a’ bisogni del comune italico linguaggio, quale rimaner non deve stazionario nel progresso della civiltà e delle industrie umane, né adagiarsi alle convenienze di un solo volgo, ma di tutte quante le plebi d’Italia, e non renderne arcano il glossario, quando ne han tutte varia bensì, ma non diversa la lessigrafia, e tutte, nessuna esclusa, la sembianza materna riproducono (**).
(**) Dobbiamo ima pubblica testimonianza di animo grato agli Scienziati Italiani riuniti nella Sezione di Archeologia e Geografia nella Settima Adunanza celebrata qui in Napoli, a’ quali di questi pensieri facemmo comunicazione. » Dopo di che » è detto negli atti dell’Adunanza medesima a carta 663,» D. Angiolo Grillo Cassinole disse che sarebbe cosa utilissima per le lettere italiane la compilazione di un Dizionario di tutt’i dialetti d’Italia e delle isole adiacenti, coll’etimologia delle voci di origine greca, latina, araba, longobarda, francese, spagnola, ecc. -r delle lingue insomma di tutt’i popoli che invasero la nostra penisola. Al quale proposito si avvisò che sarebbe mestieri stabilire una società di filologi, dotti in molte lingue, la quale aprisse le sue relazioni con uomini di lettere delle provincie italiane, ricevendo da questi un catalogo di tutte le voci volgari adoperate ne rispettivi paesi; del che potrebbero occuparsi le accademie che si trovano nelle città delle provincie ».
NOTE
________________________________
1 E testimonio ne danno da Logudori a Cagliari, un Araolle, oh Cubedda, un Pes, un Sanna, un Pintor: nel Piemonte un Isler, un Balbi, un Calvo: e vievia procedendo, un Zabata, un Foglietta, un Cavalli, Un Dertona, un Villa da Genova; e un Lo marno e un Maggi da Milano, col Rausi, col Balestrieri, col Porta, coi Grossi; e il Ferrari da Modena; e il Fulli da Norcia; e il Rava, 3 Maganza, il Rustichelli, il Bertovello da Padova, il Collaredo da Forlì; il Colombrano da Bergamo, con quel Gobbo che volle dirsi da Venezia e il Bocchini e l’Assonica; nella veneta laguna, per tacere del gran comico italiano, inimitabile quando de patri costumi con l’accento natio pennelleggia le lepidezze, e il Calmo e il Magano e l’Ingegneri e il Maffeo il Venieri il Rossalupi il Bosecchiui il Mondino il Baffi il Burati: il Patrizi da Perugia; il Pavesio da Boma, col Patacca e il Berviceri; e il Croce da Bologna, col Negri, col Lotti, il Magano!, lo Stanzani, il Landi, il Bovicca, il Tunsi, il Balestrieri, il Porta, il Grossi, e…. sì le tre Grazie che nelle amabili Zanotti e Manfredi si tramutarono; e nella Valle dell’Arno, infine, in quell’Attica dell’Italia, que’ tanti che delle rusticane e popolaresche forme si compiacquero dallo scrittore della Nencia agli scrittori della Tina e della Tancia e della Fiera; dal Falci, al Baldovini, dal Moniglia al Zannotti…
E chi potrà di tutti il nome dirti?
Che non uomini sol, ma Dei gran parte
Empiono il bosco degli ombrosi mirti. PbtrarcA, Tr.
10 Dilatet Deus laphet et habitet in tabemaculis Sem. Genesi IX, 27. Ma nel testo ebreo è detto: Iaphth Eloim le Iaphet. Il che importa precisamente nel nostro idioma: Il Signore giapetizò Giapeto.
Arist. ne’ Politici. E mi si conceda rammentare che quel filosofo da que’ Logi, che qualificavi come i più dotti e i più intelligenti della storia delle antichità italiche, ricavò che la comunanza degli alimenti erasi stabilita dal Re Italo nell’Enotria molto prima che Sesostri in Egitto, Minosse in Creta facessero altrettanto. Italo, ei prosieguo. condusse alla pratica dell’agricoltura gli Enotri, i quali dapprima erano soltanto pastori nomadi, ed instituì i conviti sodalizi i quali tuttavia da alcuni discendenti di quell’antico popolo sino alla sua età si praticavano. L’età che si assegna a Minosse è quella di quattordici secoli prima della nostra era. I nostri Osci erano adunque agricoltori fin dal quindicesimo secolo precedente all1 era volgare. Giunti a tale stadio del progresso civile, qualunque ulteriore ricerca sull’antico stato degli abitatori primitivi delle nostre regioni sarebbe mera perdita di tempo, mero lusso d’intemperante erudizione.
16Che di razza osca fossero i Siculi appare dalla lettera terza attribuita a Platone nella quale il timore si manifesta ohe i Fenici e gli Opici espeller potessero i Greci dall’isola ed introdurvi la lingua loro. Avanzò il Niebuhr che quegli Osci esser potevano i mercenari italici che in Sicilia militarono (Ist. Rem. I., 62. 22. 206) Sarebbe lo stesso aver timore che una lingua nazionale si estinguesse per la presenza de reggimenti stranieri! — Tracce rimangono dell’antico soggiorno de’ Siculi nella gronda dell’Adriatico dal Tronto ai Capo Zefirio, e nell’altra del Tirreno, dal Lazio alla Campania. Nella tradizione mitologica, Italo, Siculo, Morgete vengono promiscuamente detti ora re d’Italia ora di Sicilia. E Saturnia si denominò sino alla età di Diodoro qualunque luogo alto e fortificato (177 -60) V. anche ARNOBIO, IV. p. 144. — Ma v’ha dippiù Isacco Tsese antico e perpetuo scoliaste ai Licofrone, nel verso 717 ci conserva la tradizione che un Falero re siciliano fosse il fondatore della nostra Napoli: Il che si ripete benanche da Stefano Bizantino.
21Se la propagazione delle discendenze de’ Patriarchi considerar si volesse totalmente terrestre, forse non affatto strani riputar si dovrebbero i calcoli del Saint-Aubim co’ quali pretese dimostrare che i discendenti di Gomer, partendo dalla terra natale, non sarebbero giunti ai confini dell’Europa prima dei principio delle nostra era. Ma dall1 Arca uscivano i Noaehiti; e per le tradizioni occidentali navigatori furono i figli di Licaone, e con l’emblema di Giano, costantemente, l’emblema della nave, o del mezzo toro remigante, che vuol dire lo stesso, i monumenti italici conservarono. V’ha dippiù. Noè, uscito dall’Arca, piantò la vigna; e il protoparente, il protolegislatore, il nume veramente italico piantator della vigna le tradizioni italiche designarono in Giano. Giano è manifestissima derivazione e senza contorcimenti dal semidico p (iaìn) che vuol dir vino, in greco Ed Enotri, i primissimi italici vennero da’ Greci a denominarsi. Tanto, come su dicevamo, più o meno guaste sibbene, più o meno obliterate, le tradizioni orientali nelle nostre d’occidente si trasfusero!
31 Intendo per quest’indole natia quel primitivo tipo di gramatica e di glossario di che troviamo evidentissima l’analogia quando da quelle industrie facciamo astrazione che nel vario andamento della quà e là s’ introdussero In una parte più e meno altrove. Molto buio è già tolto per opera di que’ pazientissimi che delle etimologiche derivazioni si fecero a produrre la tale e tale altra ipotesi. Ma per quel che riguarda più prossimamente il nostro obbietto, più#che barlume di prossima aurora balenava nella dotta dissertazione di F. Paolino da S. Bartolommeo De latini sermonis origine et cum orientalibus linguis connexione, Romae 1812. Arreni forse mena luce di meriggio quando alle sole etimologie delle parole isolate non si vedrà circoscritta l’opera degli eruditi, ed una gramatica veramente universale e non fantastica vedrem sorgere alle cui regole non immaginate ma rinvenute, tutti i parziali sistemi gramaticali della razza umana venir possano senza stento ad adagiarsi.
Del resto memorabile pel nostro argomento è la sede dell’imperio trasportata da Costantino nella Tracia, donde le orfiche dottrine partivano: perciocché da quell’epoca le prime tracce derivar si possono dal greco moderno, comeché il maggior numero degli scroni stranieri introdotti in quel linguaggio si voglian ripetere dall’età delle crociate. Non è cambiato un linguaggio quando molte parole divengano antiquate e molte altre se ne adottino, o sorgano dal fondo stesso degli antichi radicali o anche sieno allatto nuove: ma quando il gramatical sistema venga a variarsi. Per ciò che riguarda la lingua italiana in confronto con la latina, la massima differenza è nell’abolizione de’ casi nei nomi: giacché ne’ verbi, astrazion fatta da’ modi participiali e dalle inflessioni passive, sol si trovano ingentilimenti di pronunzia piuttosto che varietà. Ma nel greco moderno la teorica de’ verbi quasi affatto dall’antico si distacca: e (quel ch’è mirabile!) con quella della lingua romana si ricongiunge. I filologi accordan troppo alla presenza de’ Veneziani e dei Genovesi. Ma la forza gramaticale del greco moderno è la stessa anche là dove Veneziani e Genovesi non penetrarono: e in sole gradazioni mere di profferenza t’imbatti. Il v, a cagion d’esempio, spiccatissimo negli Scroti, appena distinguerai a Smirne, e sparisce affatto in Costantinopoli. Queste ed altrettali varietà nel sillabare mostrami assai di frequente; ma la grama tira è una.
34 Delle cosi dette scale menagiane si è fatto argomento di scherzo da coloro che, pizzicando letteratura, aspirano piuttosto a brillare con un epigramma nelle società galanti che ad impegnarsi in ricerche alquanto per essi astrusette. l’generosi Alemanni nati vendicato nobilmente l’erudito Francese col ritorcere sull’autore del viaggio dell’Alfana quel riso eh ei volea promuovere. Con tutto ciò ai quel mal deriso viaggio si fa tuttavia ricordo nel secolo XIX! Su la costanza delle permutazioni di alcune sillabe, riguardo specialmente alle lingue romane. alcuni saggi riunì il Reynouard (v. Journ. des sauans, giugno 1820), ed è bello, ei dice, rinvenire in tai risultamenti dell’analisi de’ linguaggi la stessa costanza che si ammira nell’ordine fisico.
Ma tali ricerche estender si vogliano anche ai dialetti. PL, a cagion d’esempio, ritenuto al modo latino al di là dell’Appennino ed in Francia, si trasforma nella lingua comune d’Italia in PI, nel napoletano in CHI, di là da Pirenei in LL: ec. Le origini Italiane, quali furono meditate dal Menaglo, esigono sibbene un finimento, ma l’abozzo è ben fatto.
» Ed assai ragionato è il suo dire quando assume essere italiane e venute dal latino molte voci che si estimano provenzali, le quali» pure e il Bembo nelle sue prose, e il Varchi nel suo Ercolano, e i Deputati sul Decamerone, e il Tassoni nelle sue note, vogliono che sieno provenzali. Nè vale il dire, come fanno il Bembo ed il Varchi, che i rimatori provenzali fossero prima de’ Toscani. Perciocchè incominciò a formarsi la favella italiana dalla latina gran tempo avanti a que’ rimatori provenzali, cioè circa il tempo di Giustiniano, come l’osservò bene Claudio Salmasio, ec. ec. »(Reynouard, l. c. pag. 73.)
35Pochi principi generali su le trasformazioni che ricevono diverse lettere daranno un’idea del come le parole italiche nello Spagnuolo vengano a modificarsi. La F, la quale in fatti può risguardarsi come un’aspirazione, si cangia in H nello spagnuolo. Quindi fabulari lat.; favellare ital. j habar spagli. Il LI latino, si attenua in GLI nell’italiano, nella semplice J nello spagnuolo. Quindi Filio lat.; figlio it. -, Hijo spagn. ec. ec.
42 Scrisse Montesquieu: io farò vedere in un’opera «pedale, che il disegno della Monarchia degli Ostrogoti differiva in tutto dal disegno dell’altre Monarchie Barbariche di quel tempo; e che in reco d’affermare d’essere stata una cosa qualunque usata da’ Franchi, bisogna dire che una cosa usata dagli Ostrogoti non si praticasse tra’ Franchi. Msprit des Loix, liv, XX, Chap, XII, Ma quest’opera speciale non fu poi pubblicata. Il nostro Trova a riempire principalmente una tale laguna dettò le tre parti dei primo volume, le quali non solo van considerate come un apparato alla Storia d’Italia del Medio-evo, ma formano una limpida dimostrazione della diversità delle due razze getica o gotica e della germanica: e per quel che riguarda il nostro obbietto, una limpida dimostrazione insìememente del perché tre furono i linguaggi cardinali del medio-evo col quale tutte le varie loquele de’ popoli diversi venivano nelle nostre regioni ad affratellarsi, il latino letterato cioè, il latino volgare, che poi fu lingua romanza, e l’idioma teutonico, detto per Carlomagno idioma francese’, il qual poi nel germanico si compose. Tutte le altre loquele quasi come dialetti andar vogliono considerate. Di qui l’elogio di papa Gregorio V sulla fine del secolo X:
VSVS. FRANCIGBNA. VVLGARI. ET. VOCE.
LATINA INSTITVIT. POPVLOS. ELOQVIO. TRIPLICI.
E questa lingua volgare appunto, distintissima dalla germanica, fu quella che dalle razze gotiche con tutte le altre razze le quali con le gotiche si affratellarono, venne costantissimamente adoperata.
43 Ci piace seguir l’ipotesi dell’autore della Storia d’Italia del Medio-evo, Alla venuta dell’Unno, i Daco-Geti, ovvero i Goti, che o condotti od inviati da Ermanarico si erano sospinti sul Baltico, cioè sull’antico Seno Venedico di Tolommeo, si videro dopo le vittorie su’ Venedi chiusa qualunque via di comunicazione con la loro patria sul Danubio e sul Ponto Kusino. Qui comincia la loro storia settentrionale, che ha sconvolto per lunga età le fondamenta della meridionale d’Europa, facendo credere che le conquiste de’ Goti Zamolziani d’Ermanarico nella Scandinavia riferir si dovessero a tempi antichissimi e favolosi prima di Berico, e che il culto di Zalmolxi uscito fosse di Svezia». Trova. Nella quale ipotesi, la quale oggimai riconoscer si dee come storica verità, tutte le tradizioni si adagiano che i seguenti scrittori, mirando solo alle ultime emigrazioni, affazzonarono.
48 Bastino a darne piena dimostrazione, i seguenti esempi ne’ quali la vocale che dee supplirsi a cagione del metro noteremo con un apostrofo: E sa beutat es entr las gensor
Genser oasi com entr foillas fior.
E sens mal gienh, sens blasm, sens folia
Sens enveg dir e sensvillania.
I primi due versi sono di Reimaro; gli altri di Berlingìeri da Palazzuolo: i quali versi sono ortograficamente di dieci sillabe (in compiuto francese, di nove), ma ne’ quali la pronunzia dee restituire una sillaba. Del pari, di otto sillabe sembra questo verso di Elia di Besiolo:
Ahi! com’ tragg grev penetenza;
e di sette quest’altro di Guaselmo Taidito:
Frane, fide!, d’umil sembiant;
e pure non ci vuol molta industria per riconoscere in questi versi due sonori endecasillabi:
Ahi! come traggo greve penetenza:
Franco, fedele a umile sembiante.
Tanto la lingua d’oc non altrimenti vuol considerarsi se non come di nera italiana origine!
51 Tutti gli scrittori che han ragionato delle origini della lingua italiana non han taciuto di un tale giuramento. Crediam nostro debito ciò non ostante qui trascriverlo per tenore come quello che ci dà occasione ad alcune, comunque ovvie, pure opportunissime riflessioni al nostro obbietto. GIURAMENTO
di
LODOVICO.
Pro Deo amur, et pro chistian poplo et nostro comun salvament d’ist di in avanti, in quant Deus podir et savir me dunat, si salvarajio cist meon fratre Karlo et in adjudha et in cudhuna cosa sic com per dreit son fradre salvar dist, in o qud il mi altresì fazet. Et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai qui meon fradre Karlo in damno sit.
GIURAMENTO
del
POPOLO.
Oba Karlthea eid then ersine mo bruodher Ludhunvige gesnor, gelcistit, ind Ludhuuvg min her ro then er inno gesnor ob ih ina nes auwenden nenag, non ih, noh thero thein hes iuven dem mag ino ce follusti uvidhar Karle ne uviedhit.
GIURAMENTO
di
C A R L O.
In Godes minna, ind durh tes christlanes folches ind unser bedhero gealtrissi,fon these.o dage frammordes. So fraim so nir Got geu vizei indi inadh fur gibit, co hald ih tesan ninan bruodher……….soso man mit rehtu sinan bruoder scal, inthi ut haz cerznig soso maduo. Indi mit Lutheren inno theinni thing ne ge gango, zhe minan vuillon imo ce schaen vuerhen
GIURAMENTO
del
POPOLO,
Si Lodhuvigs sacramentque son fradre Karlo jurat conservat, et Karlus meo sendra de sua part non lo stavit, si io retornar non l’int pois, ne io ne veuls cui eo returnar int pois’ in nullo adjudo contra Lodhuuvig nun li iver.
Il testo per noi trascritto è qual si legge nel Nitardo. Il Leibnizio, il Muratori, il Ciampi, ed ultimamente il Perticari variamente vi lessero. Acciò non cada dubbio di lezione prediletta per far rilucere il nostro assunto, le varianti andrem tutte minutamente notando. Ed è gioconda cosa il vedere come, se alla ortografia supplisci; e quell’italiano primitivo che noi crediamo osco, e quell’antico latino castrense o romano rustico che dir si voglia, e molta inclinazione alla napoletana profferenza da tutt i nostri scrittori del ducento prediletta, si manifestino del pari.
Pilo Deo Amur. Var. Dò, interpetrato dal Ciampi Divin O Amor. Noi abbiam ritenuto nell’aulico linguaggio la Dio grazia, la Dio mercé. Credeva il Bouhour che i francesi non usassero articoli sino alla fine del secolo IX (Entretien II d’Ariste). Anche nel ducento troviamo in Fra Guittone: Disio grande che porto vói (lett. 5.) Madonna madre Deo (lett. 28. ) lo per altro credo che qui la pronunzia rapida di una formola usitatissiina ristabilisca l’articolo. Il nostro volgo non altrimenti contrae per lo: prf o ammore’i Dio; ed anche Pr’ ammor i Ddio
Poblo. Var. Poplo. Nella colonna rostrata ed in Plauto si osserva simile contrazione. E il nostro volgo pronunzia pobb’lo per popolo.
Salvament. Osserva il Tracy: » Quando io scrivo il e lo pronuncio, v’ha un’articolazione debole innanzi alla i ed una voce debole, una E muta, uno sceva dopo la L; senza di che la L sarebbe inutile». Dunque anche i Francesi, generosissimi troncatori delle parole, qui aggiugnerebbero una vocale. E valga un tale avvertimento per tutti i casi simili. V. la nota 48.
D’ist dì. Var. D’isrri dì. Nel nap. Da sti dì. a avant. Var. In ant. L’una e l’altra lezione danno voci italiane. Dicea la donna di Ciullo d’Alcamo.
Avanti li cavelli m’arritonno.
Ed il Guinicelli:
Né f è Amore anti che Gentil core,
Né Gentil core anti che Amor Natura.
Il volgo napoletano ha del pari Nnavante e ’Nnante.
In qua nt. Var. En quant. L’e e l’i si scambiavano e scambiano spesso nell’antico e nel moderno volgo d’Italia. Gli antichissimi latini dicevano endo ed indo per in. Ennio presso Ausonio: Endo suam do. Lo stesso presso Macrobio: Indo mari magno. Lucilio presso Lattanzio: Iactare indo foro se omnes. Ed ecco tutt’insieme la ragione del perché in, en, ente, inte sieno modi promiscui in tutti gl’idiomi romani e ne’ dialetti loro. Quanti altri idiotismi italiani vedremmo presso i vecchi scrittori se le loro opere ci fossero nella loro integrità pervenute!
Savir 8t roDiR Var. Saper et poter. La prima maniera è precisamente del dialetto siciliano; e però frequentissima in tutti i nostri poeti del duecento.
Donat. Var. Dunat. Anche l’O e l’U sono pronunzie affini degli antichi e de’ moderni volghi. Sappiamo da Festo che gli Umbri e gli Etrusci litteram pro O èfferebant; e viceversa da Prisciano che multis Italìae populis V in usu non erat, et contrario utebantur O. — La V nelle terze persone de’ verbi è meramente ortografica, sempre per la lingua del sì e d’oi: perché non riputarla tale anche per quella d’oc?-Si noti per altro che talora è paragogica nel moderno francese e ch’è divenuta desinenziale nel dialetto napoletano pei preteriti, come facette, dicette, ec.
Salvaraio. Var. Saltareteo: Salvar sio. Da quello che abbiam già notato alla pag. XI su la formazione de futuri, è chiaro che nelle lingue romane tutte le uscite della prima persona esser possono ò, aio, albo, aggio, ec. E perciò la V della prima variante altro non dimostra se non l’industria dello scrittore per esprimere quella J equivoca tra la I aspirata e la Z de Veneziani o la doppia G de’ Napolitani.
Cist. Var Ist. Ci persuade l’opinione del Cittadini su la formazione de’ nostri pronomi questo, quello, che che ne pensasse il Muratori il quale li vorrebbe derivati da qui iste, qui ille. Il raddoppiare gli adiettivi dimostrativi è comune a tutti i volghi, e ne usa la lingua letterata di Francia, perché quell’idioma l’identità conserva del linguaggio di conversazione. — Il napolitano ha con servato chisto: il provenzale cist: il franco vallone avea cest: l’italiano aulico ha questo: l’italiano plebeo e lo spagnuolo esto, este. E gli antichi latini scriveano quoi per cui. V. nel nostro Vocabolario la lettera C.
Meon fradre. Var. Meo fratre. Quindi il mon per mio. La donna di Ciullo:
Poi tanto trabagliastiti,
Faccioti meo preghieri
Che tu vadi e addimandimi
A mia mare e mon peri.
» La voce mio, scrisse il Perticari, anco le femminette sanno che scende dal latino meus. Ma il modo di questa permutazione né le femminette sanno né i gramatici l’hanno detto. Non di meno se si leggerà ne’ versi della contessa di Dia
Lo mieus bels amics,
a un tratto conosceremo le venture di questa voce e diremo: I latini dissero meus: i romani volgari vi frapposero un i, al modo de Ionici, e dissero non più meus, ma mieus. La s, secondo il vezzo comune di tutti i rustici, anzi di Ennio medesimo, da prima non si pronunciò, poi si tacque: come nel conte di Poetù:
Al mieu albir
Indi si gittò il dittongo ie, e come pone Folchetto di Marsiglia, e si cangiò iit miu:
Lo miu den vestre er
Finalmente la u per naturale dolcezza romana ai mutò in o, e di miu si disse mio, come da sepulcro e da stultizia, si disse stoltizia e sepolcro. » — Ma perché tanti giri se abbiamo belli e formati nelV antico latino mius e mi in Diomede, del pari che Dius e Dia in Varrone? Dicasi piuttosto che le vocali, come quelle che hanno gradazioni infinitesime, mal possono esprimersi con la povertà dell’alfabeto latino: che i Greci al maggior numero delle loro vocali aggiunsero molti dittonghi: che gli orientali primi perciò l’esclusero da’ loro alfabeti: e che non dobbiamo far maraviglie se prima della introduzione delle gramatiche, tanta diversità s incontri nella loro espressione ortografica.
Adiudha. Var. Adiuto. » Vedi, lettore, disse il Perticar!, come adiuto è sincope di adiumento. Togli la sillaba men, e rimane aiuto. Così i latini dissero decures per decuriones: dixis per dixeris: festra per fenestra: torum per torridum. » Ma adiuto l’abbiamo bello e fatto in Macrobio. Osserva piuttosto l’industria dello scrittore che con l’aspirazione aggiunta alla d esprimer volle il cangiamento di pronuncia. Cosa. V. questa parola nel Vocabolario.
Sic com. Var. Si com, Siccom. Evidentissima è la derivazione di questa parola dal latino sic quomodo. E da quomodo deriva prima corno, poi com, come e comente: ché in tutti questi modi fu scritto e pronunziato da’ nostri primi trovatori italiani del dugento: mentre nel dialetto napoletano si ha comma pel consueto vezzo di pronunziare con forza la m.
Pee dreit. Var. Om per dreit. Credo quell’om una ripetizione dell’ultima sillaba precedente. Del resto, ben potrebbe essere una contrazione di Omo (uomo) e l’iniziativa dell’On de’ moderni francesi. I nostri Abruzzesi dicono nella rapidità della loro pronunzia Te n’ome vo. (è l’on te cherche de’ Francesi), in vece di dire: Te un uomo vuole.
Son fradre. Var. Som fratre. Sono pel dialetto napoletano Frate, Sore, modi conservati ne’ monasteri; e Fratello e Sorella sembrano meri vezzeggiativi..
Ennio disse sos per suos e sis per suis
Graecos memorare solent sos.
Postquam lumina sis oculis bonus Ancu’ reliquit
La nostra plebe tronca eziandio la m e la n. Il plebeo Guittene scrivea:
Ch’a un calesse mostrar so valore.
E il Sacchetti:
E in altro spende ornai lo tempo so.
In o quid il mi altresì fazet. Var. in o qu7 il altresì mi fazet. Il Ciampi e il Perticari interpetrano: in hoc quod, ec. ed il Muratori: in quello che un altro farebbe a me! Io credo doversi ricorrere al latino barbaro in omne quid, e tradurre: in tanto che, iNtroque: confortato in ciò dal contesto il qua’ e par che qui esigei una condizione, dal corrispondente tedesco inthi ut, dalla condizione espressa nel giuramento che segue del popola, e da quella frase di Cicerone: Apronius posset omne quantum exapavero,Verr. V, io. V. la seguente nota (97).
Plaid. Var. Pait. Ne tempi di mezzo le pubbliche convenzioni sempre furon dette placiti.
PRINDRAL. Abbiamo la contrazione di prehendere in prendere fin dalla età di Marziale:
Si te prenderò, Gargìli, tacchis.
Qui meom. Var. Qui per meo.
Vol. Var. Voleiss, Voib. È volle per velie non dovea per analogia essere ignoto agli antichi. Volt, voltis, ec. è comunissimo in lapidi, in Terenzio, in Plauto. Anche Cicerone disse volim per velim, De Nat. deor. I. Deus lo volt, era il grido di guerra de Crocesegnati: e nella lingua d’oi l’o e l’e si pronunziano ambiguamente ora col dittongo eu, ora col dittongo ou.
Cist meon. Var. A iss meo.
Sit. Var. Siat.
Sacrament. Non noteremo più varianti perché del giuramento del popolo gli autori sopra citati non si brigarono. — Intanto vedi proprietà di questo vocabolo castrense, esteso poi a tutti i significati del latino Iusiurandum. Dagli antichi italiani e dal nostro popolo si pronunziò e pronunzia ancora sacramento e saramento; e non ne mancano esempi nella lingua d’oi prima che per maggior contrazione si formasse l’attuale serment. Abbiamo nel Roman de Rosa:
Chescun fist a Guillaume hommage e serement
Sendrf, Signore? Forse il testo è scorretto, e va scritto alla spagnuola. Senor. I latini impiegavano le parole senior e senex anche per esprimere soltanto dignità della persona, senza aver riguardo alla età. Disse Silio Italico, I, v. 56:
Iam Patribus Claris que senum sua munia curas.
Non lo stavit. Stare al giuramento è bel modo italiano derivante dal latino: Fidem non Rabirius, sed Marius dedit: idemque violavit si in fidem non stetit. Cic. pro Rabir. 10. — Lo è aferesi di illo, illoc, come nel frammento della orazione di Claudio presso il Grutero p. dii.
Si io Ne io, Abbiam veduto già come senza tanti giri mio e Dio si avessero anche gli antichi invece di meo e Deo: per analogia può dirsi altrettanto di EgO trasformato in IgO e poi, rimossa la gutturale secondo il vezzo della plebe napoletana, in eo ed io nell’italiano, e ieu, je, eu nelle altre lingue romane. È notabile trovar qui io fin dai secolo IX; e dicea Giulio d7Alcamo, come abbiam veduto,
Se li cavelli artonniti,
Avanti foss’io morta.
Il volgo napoletano non pronunzia mai eo. V. appresso la nota (97).
Returnar non t7int pois, ec. In uno strumento nella Cronica del Volturno si trova una frase simile: Si nos per quodlibet ingenium returnar e quaesierimus: R. I. S. t. I, p. II, ad ann. 853. Qui returnare è nel senso di frastornare, far cangiare pensiero; il che conforta l’etimologia che dava il Ciampi a questa voce in occasione del celebre torna, torna frate. » E presa la metafora dal moto del» tornio, che dopo aver fatto mezzo giro ricomincia. »
L’int pois…. Li iver. Li, disse il Perticari, fu de’ Provenzali com’è degl’italiani: les de’ Francesi. Ma i Romani seguono ancora a profferire li quello che altri profferiscono gli Li viene da illi. quella g è intrusa e non è latina. »
Ottimamente. Se non che è da avvertire che gli antichi francesi anche avevano li, come nel Rom&u de Rose
Que peut faire un soul homme e que pout exploiter
Si li homme li faillent qui li doivent aidier?
Del resto presso gl7Italiani la sillaba li è sempre raddolcita in gli quando è seguita da una vocale: e lo stesso fanno i Francesi: gli Spagnuoli l’aspirano: i Veneziani la cangiano in gi i Romagnuoli in j: i Calabresi e ì Siciliani in ghi, ec. Di qui le varie industrie per esprimere coll’alfabeto latino questa sillaba gi, come ad esmempio, la troviamo espressa con le due lettere dl ed Id in amiraldo e bridla per latinizzare i volgari ammiraglio e briglia. Ed in vero l’industria è ingegnosa quando si pon mente al suono ambiguo di questo, direm così, dittongo di consonanti.
53 Ne abbiamo una continuazione di testimonianze da S. Girolamo a S, Gregorio Magno. Tutto lo studio de7 padri era quello dì piegarsi il più che fosse possibile alla intelligenza de’ volgari: pel quale oggetto parea pur bello al Magno Gregorio il confessare che ei non fuggiva la collisione del motorismo, non la confusione del barbarismo; né ad osservar s’inchinava il suono e il caso voluti dalle preposizioni: stimando iniquo che le parole de’ celesti si dirigessero colle regole di Donato. (Gio. Diacono, in vita 8. Oreg. M.. ) Ed ecco quel tale latino che dir potremmo veramente volgare, e che in pretto italiano si trasforma sol che di alcune lettere si taccia la profferenti le quali come mere ortografiche van considerate. E per darne piena dimostrazione ci avvarremmo di un pensi e re del Fourmont (Act. de l’Acad. des inscript, tom. IV p. 467)» Le rime, ei ben riflette, fan testimonio che molte lettere, comunque scritte, vadano o adatto taciute o in modo pronunciate a che dagli ordinari su cui alfabetici si distacchino». Or, in appoggio delle riflessioni di quel dotto accademico, leggendo questi versi:
Isoli te aomnae noli te sanctae,
Nolite credere fabulas tantas, etc.
come presso il Baluzio; non v’ha ragione da credere che fabulas tantas vadati pronunziate per favole tante nella corrispondenza di sante che per mera ortografia scrivevasi sanctae? Cosi appo lo stesso:
Tempus primus iam tran soc tus
Et hoc fui quod vobis est aptum, etc.
Ed ecco transatto ed atto parole italiane perfettamente rimanti.
Ma chi crederebbe rinvenire in bocca germanica la pronunzia di core in corde? Ma non altrimenti trovar ai può la rima in questi versi:.
Omnibus rebus iam peractis,
Nulla fules est in pactis,
Mel in ore, fel in corde
Verba lactis, fraus in factis,
Corda auguina, verba butirina.
Ap. Thedd. Eberti, poetic. hebr. barin. rhitm. metr. etc.
62 Dante pone i termini della lingua d’oc dai confini de’ Genovesi alla flessione dell’Appennino (De vulg. el. §. I, c. 7. ), la qual flessione vuol riporsi là dove, dopo aver corso quasi da ponente a levante, ripiega quasi da settentrione a mezzodì, e donde quel pjcciol humicello deriva che fu già confine dell’Italia romana. Non so donde il Giambullari attignesse questi fatti. » Terminavano, dic}egli, i nostri antichi la maggior parte delle parole in consonanti. Ed i Siciliani per l’opposito finivano colle vocali… Considerando adunque, ei prosegue, la nostra pronuncia e la siciliana, e reggendo la durezza delle consonanti offendere tanto l’orecchio, quanto si conosce nelle rime provenzali, si cominciò coll’addolcire e mitigare quell’asprezza, non a pigliare le voci dei forestieri, ma ad aggiungnere le vocali in fine di tutte le nostre (Giamb. p. i36 e i3v)». Certo è che anche la Toscana ebbe poeti che imitavano il cantar provenzale, come Paolo Lanfranchi, incerto se Pisano o Pistoiese, Ruggetto da Lucca, e quel Migliore degli Abati da Fiorenza di cui nella LXX1X delle Ciento novelle antiche si conta che seppe cantare e seppe il provenzale oltre misura profferire: certo è che l’attual popolo fiorentino ha una pronunzia oltremodo mazzicata (V. gli Scherzi Comici del eh. ab. Zaunoni), e che non solo ser Brunetto dettò il suo Tesoro in francese parceque lengue francaise cort parmi le mond et est, come ei diceva, la plus dilitable a lire et a dir que nulle autre; ma che tutti i guelfi fiorentini, ed eminentemente i Villani, fecer di tutto per infranciosare l’italiano, riputato lingua maledetta e ghibellina. Pel quale odio si giunse finanche a falsare i testi. Arrichetto da Settimello, a cagion d’esempio, avea detto, parlando della Filosofia:
Et mihi SICANOS ubi nostra palatia muros
(Sic stat propositum mentis) adire habet.
Ma il suo volgarizzatore, il qual visse ne’ tempi angioini, si credè in coscienza dire invece:
» Alle mura del mio Parigi, dove sono i nostri palagi, egli mi piace andare: cosi sta il proponimento della mia mente… j Si è assunto da qualche nostro letterato (Bettinelli, Andres, ec. ) che la corte di Carlo d’Angiò avesse potuto mettere in voga la lingua provenzale tra noi. Ma oltre che non v’ha esempio di provenzalismo in Italia al di qua della flessione dell’Appennino, eccezion fatta dai sopra notati nel bacino dell’Arno Carlo, che non mancava d’essere anch’egli poeta, trovava nella lingua d’oi non in quella d’oc. Come dai seguenti versi che si citano ai lui:
Un scul confor me tien en bon espoir
Et e est de ce qu’onques ne la guerpi;
Servie Vai toujours a men povoir
N’onques vers autr ai pense fors qu a li, etc.
63 La grande analogia de’ dialetti iberici con quelli d’Italia è tanto manifesta., che addurne esempi molta perdita sarebbe di tempo e d’inchiostro; ma cen sia condonato un solo., Il dialetto portoghese è allo spagnuolo precisamente come il napoletano al comune italico. Ecco la prima delle canzonette di D. Claudio Manuele De Costa, il Metastasio lusitano, alla Lira: Amei-te eu o confesso:
E, fosse noite o dia,
Jamai tua armonia
Me viste abandonar.
Qualquer penoso excesso
Che atormentasse està alma,
A teu obsequio, em calma
Bm pude serenar.
A quantas vezes, quantas,
Do somno despertando,
Doce instrumento brando,
Te pude temperar!
So tu, disse, me encantes,
Tu so, bello instrumento,
Tu es o meu alento
Tu o meu bem seras.
Ve’, di meu fogo ardente
Qual ‘è o adivo imperio:.
Che em todo esto emisferio
Se attende respirar,
O coracao che sente
A quello incendio antico,
No mesmo mal que sigo.
Todo o favor me da.
Non so se v’abbia, dialetto in Italia che più di questo al comune idioma s avvicini.
64 Ci duole che negli atti di quel congresso la sola indicazione di quella memoria si rinvenga j e che nel seguente congresso celebrato in Napoli, le funzioni di segretario a lui addossate per la sezione di Archeologia e Geografia non gli abbia dato agio di somministrarmi mie’ lumi che dall’ingegno e dalla dottrina di lui era io ambizioso di ottenere. Pel che per altro saremo ampiamente compensati quando del suo Atlante linguistico di Europa potrem possedere integralmente il tesoro del quale la sola parte del primo volume or ci è dato conoscere. Intanto que traspadani dialetti cosi venivano in quella comunicazione ordinati: INSUBRI
Milanese,
Lodigiano,
Valtellinese.
OROBICI.
Bergamasco,
Bresciano
Cremasco
CENOMANICI
Cremonese
Mantovano
Pavese.
65 Avverti assai bene l’Alighieri che i linguaggi umani sono assai volubili e vaganti finché non sorga una gramatica, val dire un convenuto sistema alfabetico, un convenuto sistema di segni visivi al quale i più spiccanti segui vocali sieno agevolmente riferibili. Esempio prodigioso ne abbiamo nella gramatica delle lingue morte. Noi Italiani troviamo squisitissimi I poemi del Polignac, del Rapin: altrettanto fanno i Francesi per quelli del Sannazaro, del Vida. Eppure se noi declamiamo ai Francesi, o essi a noi declamano qualche brano dell’Eneide, tipo del verseggiare del Folignac, del Rapin, del Sannazaro, del Vida, o non c’intendiamo affatto, o ci diam la berta a vicenda. Tanto è lontano dal vero che la gramatica ci conservi le voci, come da Quintiliano in qua ci si va ripetendo!
67 Ci limiteremo a pochi ricordi. Ecco bella enciclica d’un Pontefice: De quibusdam locis ad nos refertur, non magistros neque curam inveniri pro studio literarum. Idcirco in universis Episcopi is subiectisque plebibus et aliis locis in quibus necessitas occurrerit, omnino cura et diligentia habeatur, ut magistri et doctores constituantur qui studia literarum liberaliumque artium in sancta habentes dogmata assidue doceant, quia in his maximedivina manifestantur et declarantur mandata, Barok. ad ann. 826. Gli accademici palatini instituiti da Carlo Magno prendevano il nome de1 classici greci e latini.. Nel catalogo de’ libri del monistero di Bobio, pubblicato dal Muratori, non poca copia di autori profani si rinviene. E tale era P ardore di studiare in Virgilio, Orazio, Giovenale e Terenzio, che fino ai Pontefici i claustrali si dirigevano per possederne i comentatori.
72 Dell’imperatrice Costanza cosi cantà l’Alighieri per bocca di Piccarda, Farad, III, 109. E quest’altro splendor che ti si mostra…
Sorella su: È cosi le fu tolta
Di capo l’ombra delle sacre bende.
Ila poi che pur al mondo fu rivolta..
Contro suo grado e contro buona usanza,
Non fu dal vel del cor giammai disciolta.
Questa è la luce de la gran Constanza
Che del secondo vento di Soave
Generò ‘l terzo, e l’ultima possanza.
Tanto è lontano che per l’Alighieri lo spirito di ghibellinismo sia l’unico spiritò dominante!
77 Anche nella cronaca di Francesco Piftno (Scrip. R. I. (87) . t. IX, p. 661), si dice di lui che era un principe satis litteratus linguarum doctus, omnium artium mechanicarum, quibus animum dederat, artifex peritus
89 DANTE, ubi supra, c. 16. – Ci piace qui rammentare il Ragionamento del marchese G. M. Puoti sul trattato degli scrittori del trecento del conte Perticati s sulla proposta delle giunte scorrezioni al vocabolario della crusca del eoa Monti Napoli, Trani, 1818), ne’ cui pensieri siamo perfettamente d’accordo: e prendiamo di qui occasione di rispondere all’unica obbiezione che gli si fa dal con Cesare Lucchesini nel suo Ragionamento della illustrazione delle lingue antiche e moderne e principalmente della Italiana procurata nel secolo XVIII. (Lucca, 1800, tom. IL pag. 221. ) Avea detto il primo: » Che parli un uomo E qualunque porte d’Italia in presenza di abitatori di tntte le altre contrade di questo paese: egli sarà inteso da tutti. » E l’altro opponeva: »Si, sarà inteso se parlerà quella lingua che egli ha imparata sa i libri, non quella del suo parse. A me è avvenuto assai volte di sentir parlare fra loro cavalieri e dame genovesi e piemontesi ne’ loro natii linguaggi né mi è riuscito d’intendere pure una parola».
Osserveremo che quel non intendere da doppio fonte derivar poteva. 1.° dalla rapidità del dire nel favillar conversare nel quale d’ordinario tutte le parole ai contraggono da un accento feriale al quale l’orecchio non è abituato; o da parole a modi prediletti ed allusivi a specialità di consuetudini ignote. Ma fate che si parli adagio, fate che adagio si risponda a dilucidazione di quelle parole e di quelle frasi ignorate, e ben verranno a parlamento e s’intenderanno tra loro anche un idiota del primo sasso delle Alpi e un idiota dell’ultimo scoglio di Sicilia E quelle domande e quelle risposte scambievoli a chiarimento delle cose non intese con quali parole, con quai modi si faranno? Con quelle parole appunto e con que’ modi che se non sono affitto identici molto però approssimanti ai rinvengono nel natio dialetto dell’idiota da Bergamo e dell’idiota da Trapani Ed ecco, quel comune idioma che dalle Alpi alle prode in tutte le città italiche appare e‘ in nessuna si rinviene. Nella stessa Firenze, in quell’Atene dell’Italia, fate che un idiota parli con quel dire smozzicato che il ch. Zannoni gli mette in bocca ne’ suoi Scherzi comici ed adoperi parole e modi pretti di mercato vecchio: ed ecco il bisogno di quelle interrogazioni e di quelle risposte dilucidative per intenderle, e di tanta importanza per quanta ne conobbero i benemeriti e valorosi annotatori del Pataffio, de’ Burchielleshi e del Malmantile per rendere intelligibile quel dir natio ai gentil ceto della stessa Firenze.
Del resto, lo stesso eh. Lucchesini confessa che quella vicenda di non intendere gli avvenne assai spesso, ma non sempre, e quando quelle dame e cavalieri, parlavano tra loro, ma non con lui. V’ha un gentile linguaggio nazionale in tutte le gentili brigate di tutta quanta l’Italia, come un italico linguaggio in embrione è in tutti i popolari dialetti; e quantunque, come già notammo, l’Appennin parta il bel paese per due profferenze, al di là molto inchinante all’apocope, al di qua forse al soperchio vocalizzante; quel linguaggio gentile ohe vuol dirsi vero linguaggio nazionale perfezionato anche per le due grandi partizioni appare, tua non si rinviene, dopo che pel concorso di tutta quanta l’italica famiglia con la morbidezza cisappennina la transappennina vigoria Tenne a fondersi ed un idioma a comporre che a bel grado de’ soavi affitti del cuore, delle espansioni energiche dell’intelletto, e della tempesta delle passioni acquisto le varie tinte, ed ai diversi stili si effigiò dall’Alighieri e il Petrarca, al Metastasio e l’Alberi Del resto che lo studiare ne libri la gramatica e le eleganze del bel dire aulico italiano sia di primo bisogno anche pe’ Toscani, anche pe’ Fiorentini, abbiam mallevadori il Bommatei ed il Varchi.
96Son noti i rimproveri di Dante contro quel Ciullo che tuttavia da’ nostri scrittori si va proclamando come il più. antico trovatore siciliano, argomentandosi dalla sesta stanza che quell1 amebeo deggia riputarsi composto tra il 1187 e il 1193; senza por mente alla quinta, la qual dice così: Se i toi parenti trovatimi,.
E che mi posson fari?
Una defensa mettoci
Di dumilia ago stari.
Non mi toccarà patreto,
Per quanto avere ha in Bari.
Viva lo Mperadore, grazi’a Deo:
Intendi, bella, quel che ti dich’eo?
Gli Augustali furono la prima volta battuti in Brindisi e Messina non prima dell’anno 1231. Della costituzione Iuris gentium, tit. De defensis imponendis alla quale il poeta allude non possiamo accertar la data; ma certamente dal contesto par che non sia delle prime dell’Imperador Federico.
Del resto neppure questo Ciullo scrisse nel pretto volgare siciliano: e se, conte in questa strofa, v’ha fari, siciliano, la conchiusione è calabrese con Deo ed eo che i Siciliani non hanno, quando non voglia supporsi tutta imitazione di quegli scrittori che affettavano latinismo, come farem vedere in seguito. Ma è da riflettere che comunque voglia migliorarsi la dizione di questo amebeo s tempre rimane il plebicismo del soggetto l’amore è vilmente fisico, e non mai a nobiltà di pensieri si spiritualizza.
98 Comunemente oi è credulo quest’Odo un germano o cugino di Guido. Il Tiraboschi propone il dubbio se considerar si dovesse piuttosto figlio o nipote. Ma perché non crederlo anzi padre o zio? Certo. è che il suo stile è più ingenuo e piano di quello di Guido. E di quell’opera dell’arte, la quale sebben grezza tuttavia si mostri ne’ tentativi ne’ migliori nostri poeti del dugento, pur sempre accenna un progresso, qui non appare vestigio. Un’altra canzone di lui è in ottonari, metro ben presto dismesso e ripreso poi assai tardi esclusivamente per la musica.
99 Quum neque Musarum scopulos quisquam superarat, ‘ Nec dicti studiosus erat, Ennio.
101 Oltre di questa, quattro altre sono le canzoni sinora pubblicate dell’imperador Federico. Fra le quali una discorde, cioè a stanze disuguali e con movimento ditirambico. Quel che non è da preferirsi nella canzone qui trascritta dell’imp. Federico si è: 1.° la partitone alla greca di strofe, antistrofe ed epodo, che i nostri dissero volta rivolta e stanza. ‘partizione affatto ignota ai Provenzali; 2.0 le strofe senza rima, da cercarsene nelle spie antistrofe la corrispondenza; 3.° il protrarre le sentenze oltre i limiti del gretto periodo musicale.
102 Petrarca, Trionfo d’Amore
103 A rendere evidente una tal proposizione, si riflette che il comun Romano, che attualmente ne’ tre grandi dialetti Italico, Ispano, e Francese or si diranno, se prescindasi da un accento prediletto che le tre Nazioni Italiana, Spagnuola e Francese adottarono, accento evidentemente cortigiano e non mai plebeo, tutta la formazione della gentilezza di tali idiomi, nelle sole condizioni si rinviene di essersi adatto abolito tutto ciò che contrar si potrebbe dalle plebee sozzure. E per quel che riguarda il gentile idioma della nostra Italia, se reggiamo fuor di Toscana adottate alcune voci ed alcune frasi della plebe Fiorentina 5 è da riflettere che gli eleganti scrittori di Toscana quelle voci e quelle frasi non adoperano, mentre veggonsi adottate dai non Toscani sol perché in bocca de volgari delle loro regioni non si ascoltano, e le reputano belle e gentili sol perché ne’ libri l’appresero senza l’esame della provvenienza. Ad esempio Lattovaro per Elettuario, Fistio, Ristio per Fischio, Rischio, ec. E conforteremo (mesti nostri pensieri con l’autorità del Consigliere Lucchesini. » La pura lingua nella quale si scrive è quella stessa che si parla dalle culte persone».
E così » La lingua comune è la lingua toscana, spogliata come ragion vuole dalle irregolarità del volgo e da riboboli». V. la nota 89. Ma ci si permetta di non accedere alla opinione di tai quando assume che qualche non gravi differenze in poche cose detta coniugazione de’ verbi non formi diversità di una lingua»: persuasi che nel distaccarsi appunto dal malvezzo delle inflessioni plebee consister deggiano le prime condizioni d’un linguaggio gentile per dirsi nazionale e che quelle diversità lessigrafiche appunto, o a meglio dire varietà ed appunto perché non gravi, se ravvicinano più o meno un dialetto al linguaggio nazionale, precisamente l’impronta di dialetto gli suggellano.
104 Ne abbiam fitto altravolta ampia dimostrazione; qui basti la canzone, bellissime per Quella età, del giureconsulto bolognese Semprebene: la lingua è più di qualunque altro scrittore assai prossima al dialetto siciliano, ma i modi ne sono ingentiliti ed aulici. E resister non possiamo all’impulso che in noi sorge di dare ai nostri leggitori un saggio almeno del dir poetico di questo gentil trovatore, per vagheggiarne, se non altro. Come lo giorno quand’è dal moti no
Bello e serino -ed è bello a vedire,
B gli augelletti fanno in lor latino
Cantare fino ch’è bello ad audire;
Se poi a mezzogiorno cangia e muta,
E torna in pioggia la bella venuta
Che dimostrava:
Lo pellegrino che secuto andava
Per la speranza del bel giorno, in quello
Diventa fello e pieno di pesanza:
Cosi m’ha fatto Amore in mia certanza.
Cosi m ha fatto Amore certamente:
Chi allegramente prima mi mostrao
Sollazzo e tutto ben da l’avvenente:
A la più gente lo cor poi cangino!
Credevami di trar tutta mia vita
Savio, cortise, di bella partita,.
E girne baldo
Per lei che passa giacinto e smeraldo
E ave bellezze ond’eo struggo e desio:
Or saccio e crio che ben follia lo tira.
Chi lauda ‘l giorno anti che sia sira.
Seguono due altre stanze. Indubitatamente molto si è cangiato nelle trascrizioni. Ma le rime non han potuto espellere il sicilianismo. E così sempre negli altri poemi, per tutta la metà del dugento, ed anche appresso, sebbene con minor frequenza.
* Gente, cioè Gentile.
108 E ci piace qui trascrivere un sonetto di Era Guittone, non senza giustizia rammentato di chi nelle lamentazioni dell’Alighieri, non altro riconoscer vorrebbe oltre la stizza inseparabile da chi videsi a torto discacciato da una patria che amava. Donna del Cielo; gloriosa Madre
Del buon Gesù la cui sacrata morte
Per liberarci dalle infernal porte
Tolse l’error del primo nostro padre:
Risguarda amor con saette aspre e quadre
A che strazio m’adduce ed a qual sorte!
Madre pietosa, a noi cara consorte,
Ritrarne dal seguir sue turbe squadre.
Infondi in me di quel divino amore
Che tira l’alme nostre al primo loco,
Sì ch’io disciolga l’amoroso nodo.
Co tal rimedio ha quest’aspro dolore:
Tal’acqua suole spegner questo foco:
Come crasse si trae chiodo con chiodo.
109 Ecco le quartine di uno de’ suoi Sonetti rinterzati. La gran sovrabbondanza
Che di gravose amor mi ha dato pene
Da poi mi fè voi, gentil donna, amare,
Mi tene in gran pesanza
Dì lontano sollazzo è d’ogni bene
E in gran martiri mi fan consumare:
Perché mostrare a voi non ebbi ardire,
Mentre vi fui presente, il mio celato
Puro e leal, ched io vi porto, amore;
Onde languore il mio dammi fallire:
ché s’ io com’ porti avessi lui mostrato
Ogni mi sembrarla pena dolzore.
Di questo poeta nulla ci dicono gli storici della patria letteratura. Ma i suoi trovati non meritavano tanta noncuranza. Egli può dirsi caposcuola di questa nuova maniera: ché molti seguirono l’esempio di lui, e l’ebber quasi a maestro, come Bacciarone di Messer Saccone, Dotto di Sor Dato ed altri. Ma ciò non è tutto. Quasi nulla in. lui si rinviene di comune ai trovatori della prima età, vuoi per la scelta dell’argomento, vuoi per la fabbrica de’ versi. Delle quattordici canzoni ché di lui sono a stampa, cinque soltanto son d’amore, e queste senza le ordinarie languidezze e i raffinati pensieruzzi: e pare che ben presto si legasse con voti e di buon core (Canz. Considerando la vera partenza Che ho fatto intera di ogni vano amore); peggiore stimando che morso di capra.
Ove Amor fer d’artiglio e da di becco
Puro sembra che poi si trovasse pentito d’avere cangiato abito e stato, disnaturando natura com’egli dice (Canz. Dolorosa doglianza in dir in adduce. Vi dir già più non celo). Certo è ch’ebbe stanza in Corsica e che là delle cose secolaresche non abbandonò il pensiero, ed altolevò la voce contro le novità del governo (Canz. La dolorosa noia) e i suoi concittadini incitava a tentare miglior fortuna (Son. Prega chi dorme eh oramai ti svegli. E nel suo core ingeneri vigore ec. Forse queste tue brighe il fecero imprigionare, ed egli tra i ferri pianse la sua aventura (Canz. Lasso tapino in che punto crudele.
111 Volg. Eloquio L. I, C. II. Qual fosse la baldanza de’ volgari poeti che moveano stomaco all’Alighieri mostrasi specchiata nei sonetti di un Gonnella degl’Interminelli e di un Notaio Bondico, arabo da Lucca, ne’ quali si pretende dimostrare nientemeno che non valga studio e dottrina per portare miglioramento ad un linguaggio! D’ogni arte dell’Alchima io mi diffido.
Ed uom che muta parlar per accento.
Non trae per senno al fuoco la farfalla?
113 Veggansi i sonetti; Detta ragion che non savete vero: Naturalmente falla lo penserò; in risposta a’ due sonetti di quel Gonnella degl’Internimelli; Una ragion qual eo non saccio ch’ero: Pensatati non fare indovinerò. Dalle quali risposte dell’Urbiciani ben si scorge che più da storico che da. poeta l’Alighieri tratteggiò in purgatorio quel suo colloquio col buon Lucchese, il quale m que’ sonetti appunto còme Dante il dipinse si manifesta. Ma è ben uà credere che non sempre fossero tali i pensieri dell’Urbiciani. Un sonetto abbiaci di lui diretto a Guido Guinicelli, e si è creduto da qualche insigne letterato che fosse una lode generosa al massimo trovitor bolognese. E tal sembra sino al sesto verso. Ma dal settimo in poi erompe l’amara ironia.. Poi che avete mutata la manera
E li piacenti detti da l’amore
De la ferma de l’esser là dov’era
Dir avanzare ogni altro trovatore.
Avete fatto come la lumera
Che a le scure partite dà splendore:
Ma non quine ove luce la sua spera
La quale avanza e passa dì valore.
E voi passate ogni uom di sottighanza,
E non si trova alcun che bene ispogna:
Tant’è oscura vostra parlatura!
Ed è tenuta gran dissimiglianza,
Ancor che ‘l senno vegna da Bologna,
Traier canzon per forza di scrittura!
114 A quel che abbiam detto di Fra Guittone, si aggiunga che il Petrarca nel Son. Sennuccio mio, mette tutti in un fascio, il Poeta d’Arezzo, Cin da Pistoja, e lo stesso Dante Fiorentino. Ma ben ti prego che ’i la, terza spera.
Guitton saluti e mescer Cino e Dante.
120 Ecco Dante e Beatrice, ecco Selvaggia, Ecco Cin da Pistoia, Guitton d’Arezzo,
CHE DI NON ESSER PRIMO PAR CH’IRA AGGIA.
121 Com’ poco verde in su la cima dura, Se non è giunta da l’etadi grosse! Purg, XI.
122 Credette Cimabue nella pittura Tener lo campo: ed or ha Giotto il grido
Sì che la fama di colui oscura.
Così ha tolto l’uno a l’altro Guido
La gloria della lingua: é forse è nato
Chi l’uno e l’altro caccerà di nido. Ibid.
124 Come sino al trecento, i dialetti Col comune linguaggio aulico si confondessero, trarremo un saggio da domestici esempi: e il trarremo dalle sole lapidi, come quelle che più de’ Codici, quando non sono autentici, serbalixx le tracce del loro progressivo emendamento. # Molte esser doveano tra noi le antiche iscrizioni dettate in italiano. Ecco quel che abbiamo dal Mazzocchi: Sed et marmoraplura sunt passim eadem dialecto perscripta: cuiusmodi illud quod in Oratorio S. Ioannis ad Fontes prope S. Restitutam legltur in hunc modum: questa cappella la edificai lò imperatore CONSTATINO ALI ANI CCCXXXIII POV LA NATI ri DE XPO ET LA CÒSACRAI S. SILVESTRO ET AVE NOME S. IOANNE AD FONTE ET IndvlgetiA Ifinita. Neapoli ergo non nisi ista neapohtana dialecto scriptores saeculo XIV et XV. utebantur: sed multo ìamenpuriore quam qua vulgus tieapolìtanum colloquebatur De cath. ecd. neap. semp. un. etc p. 85. n. 70. Ma oltre di questa che trascrive altra or non ne abbiamo, se non quella cheleggesi in un monumento alla Piazzetta di S. Pietro Martire, nel qual monumento la figura vedesi scolpita della morte coronata con un falcone in pugno ed un logoro nell al tra mano quasi in atto di cacciatore, soprastante ad un mucchio di persone morte di ogni ceto, ed innauzi ad una specie di ara, sulla quale una figura con abito di mercadaute versa un sacco di monete. Ora le iscrizioni son queste:
Nell orlo.
MILLE. LAUDE. FACTIO. ÀDIO. PÀTRE. EALA. SANTA. TRINCATE. CHE. DUE. VOLTE. ME. ÀVENO. SCAMPATO. ETUCTI. LIALTRI. FORO. ANNEGATI. FRANCISCHINO. FUI. DE. BRIGNAL. (sic) FECI. FARE. QUESTA. MEMORIA. ALE. M. CCC. LXI. DE. LOMESE. DE. AGUSTO. XUII. INDICCIONIS. Ne cartocci ch’esprimono il dialogo tra il Mercadante e la Morte TUTO. TEVOLIO. DARE. SEMELASI. SCANPARE.
SETU. MEPOTISSE DARE. QUANTO. SEPOTE. ADEMANDARE. NOTE. SCANPARA. LA. MORTE. SETEVENE. LASORTE.
Nell ara
EOSO. LAMORTE. CHICHACIO
SOPERA. VOI. IENTE. MUNDANA
LAMALATA. ELASANA
DIE. NOTE. LAPERQHACCIO
NOFUGIA. NESUNO. INETANA
E. SCAMPARE. DALOMIO. LACTIO
CHE. TUCTO. LOMUNDO. ABRACTIO.
ETUCTA. LAGENTE. UMANA
PER. CHE. NESSUNO. SE. CONFORTA
MA. PRENDA. SPAVENTO
CHEO. PER. COMANDAMENTO
DE. PRENDERE. ACHIVENE. LASORTE
SIAVE. CASTIGAMENTO
QUESTA. FEGURA. DE. MORTE
E PENSA VIE. DE. FARE. FORTE
IN. VIA. DE. SALVAMENTO.
Poco ci convien dire su l’ortografia: e don ri arresteremo né su l’Avena né su l’Annegate, che-a primo aspetto sembran falli di sintassi, ma che cessano di esser tali ae si rifletta al
del primo V. della Genesi, ed alla E stretta quasi sempre dai nostri sostituita alla I. E dopo di aver detto che l’ultima parola Indiccionie è nella pronunzia de’ nostri maggiori che anche dissero lecciones (nella Cronica di S. M. del Principio) avrem detto tutto. Ma del— rondeggiamento dell’ortografia di questo marmo non è da tacere.
Vi si legga tufo, tucti, scanpare e scampare; e poi chacio,faczio, ec. Ma tuto, e scompare provengono indubitatamente dal poco spazio de7 cartocci: e poi tucto, t lieta, tue ti, dall’analogia della riduzione del latino CT in TT: riduzione della quale appare l’antico uso in Authore fin dai tempi remotissimi. Pure nel quarto emistichio abbiamo notte in vece di nocte..
E lo stesso è da dire di faczio, laczio, abbraczio, in vece di faccio, laccio e abbraccio. Ma è da notarsi che non sono infrequenti in Italia le profferenze di queste voci assai prossimamente a azzo, lazzo, abbiiizzo, particolarmente ne’ dialetti di maremma, come il veneziano, pisano, ec. E nel napoletano, oltre che laccio co suoi derivati non altrimenti si pronunzia che lazzo, è vezzo specialmente donnesco attenuare l’articolazione CE sino alla Z lieve: vezzo che il Boccaccio conservò nelle ballate dei suo Decamerone, e che giustifica il bisticcio di Ausonio; Nata Salo, producta Solo, patre edita caelo: come bene avvertiva il nostro Vico.
E perciò le rime di laccio e abbraccio non sarebbero precisamente identiche, ma soltanto analoghe a quelle di caccio e percaccio, e quindi espresse con diversa ortografia. Oltre che nel nostro dialetto dicesi cacciare quadrisillabo, non cacciare. Bercaccio poi è parola non ancora registrata, ed esprime qualche cosa più del persequor, e del
L’antico francese aveva il pourchaèser. E non dobbiamo dimenticarci dell’antico capsare di Accio e di Plauto.
Un’altra oscillazione di scrittura abbiamo nella parola gente, intera nell’ottavo verso, attenuata in jente nel secondo. Ma l’attenuazione de’ nomi ne’ vocativi è. costantissima nel napoletano non solo, ma in tutti i linguaggi quantunque l’ortografia non sempre l’esprima. I novellieri per altro ce ne hanno serbato i vestigi.
Finalmente volio per voglio, e lasi per lasci van considerati come ripieghi anch’essi per esprimere articolazioni che i latini non ebbero. Ma è da notare che il lassi de1 napoletani hà qualche cosa di mezzano tra il lasci e il laxi. Il che ci conduce all’antica etimologia della parola. Delle permutazioni delle I in E, sarebbe inutil cosa l’intrattenersi. Modi inchinanti al dialetto son questi, e molto più vene, foro, potè, potisse, fugia, aveno, pensavie, in analogia più prossima colle inflessioni verbali de’ latini. Quindi scamparà senza r attenuazione dell’a in e. E quindi mundo, mundarta, agusto. E di vantaggio le preposizioni sopera e ine, in vece di sopra ed in, che voglion riferirsi aliandole speciale del dialetto di non terminare, non solo veruna parola, ma nessuna sillaba-per consertante. E per la ragione medesima no te scamparà, no fugia, invece di non ti scamperà, non fugga. Ma se la dettatura del monumento è inchinantissima al dialetto; l’intenzione di adottare quel che si disse linguaggio aulico, cortigiano, è manifestissima. Il nostro popolo non dice due volte, ma doie vote; non mundo, prendere, ecc.; prescindendo da questa e questo che pronunzia sempre per chesta, e chesto, analogamente forse alle antiche profferenze quando i ramatici latini disputavano sul valore della QV che avrebber voluto espressa per la semplice K. Ma quel che ripugna affatto all’indole del dialetto ò quell’EO in vece di IO, pel quale i nostri popolari non solo han ribrezzo, ma orrore (V. Galiani, del dialetto napt). Ed intanto di questo latinismo, e se anche vogliasi grecismo, non isbarbicato sinora nella sola cresta meridionale dell’Appeunino, ridondano tutte le antiche nostre scritture, anche de’ primi trovatori di Sicilia, nella quale l’attenuazione della E in I è costantissimo vezzo nazionale. V. la nostra Mem. su i metri arabi negli Atti dell’Acc. Pontaniana, tom. III.
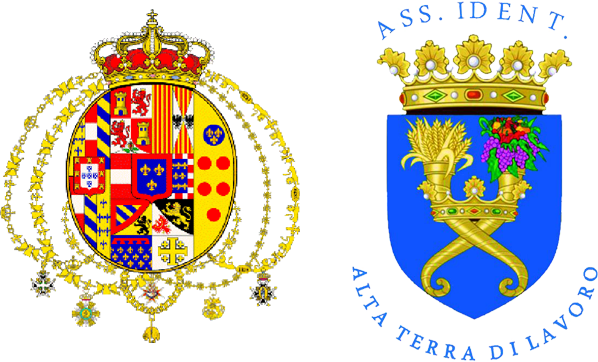



 invio in corso...
invio in corso...




grazie per le belle parole cercherò di avere notizie sul testo
Stupendamente interessante!
Mica è disponibile in commercio? Magari in copia anastatica?
Se disponibile è interessante il riferimento per l’acquisto.
Grazie e complimenti come sempre per tutto.
Agostino Catuogno