“Ernesto il disingannato” (romanzo del 1874) a cura di Gianandrea de Antonellis (XV)
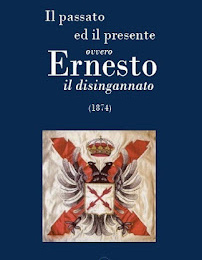
Seconda parte
Capitolo V. Carlo
Carlo, che aveva inteso dal suo nascondiglio, come abbiamo detto, i discorsi tenuti dai due nello studio del Duca, si era formato un piano proficuo per poterlo mettere in esecuzione e senza por tempo in mezzo cominciò a svilupparlo nello stesso giorno.
Egli aveva avuto dalla sua innamorata un tempo un bozzo di lettera del padre col quale, dietro di lei negativa, rispondeva ad un nobile Napolitano che l’aveva chiesta per sposa di non poterlo accontentare: pensò che da questo bozzo avrebbe benissimo potuto ricavare un fac simile di carattere, e siccome egli stesso era espertissimo nell’arte calligrafica, si pose immediatamente all’opera scrivendo una lunga lettera ad Ernesto, nella quale, formando una specie di piano per una restaurazione, chiedeva in ultimo un riscontro con delle riflessioni per poter prendere due colombe ad una fava, cioè compromettere i due personaggi e tirar l’acqua al suo mulino, ottenendo per tal mezzo la mano della sua innamorata o almeno una forte somma che avesse in gran parte equiparata la dote di costei, della quale andava a caccia più che della stessa Giuseppina, che amava, è vero, ma non con tanto amore da morir tisico se non l’avesse sposata.
Una intera giornata si trattenne intorno all’indicato lavoro, sia per comporre la lettera che doveva avere un certo che di verosimile da poter persuadere Ernesto essere veramente scritta dal Duca ed obbligarlo a rispondere, sia per copiarla con un carattere che avesse ben potuto illuderlo e farla credere effettivamente di mano dell’abitante del Monte di Dio.
Era la sera, quando l’opera fu compita e Carlo, gloriandosi di quello che aveva fatto, attese tutto quel giorno e l’altro appresso, senza curarsi dell’immaginato progetto ed aspettando, per arrivare al suo intento, il terzo giorno, in cui stabilì di procedere innanzi senza arrestarsi.
***
Ernesto, ritiratosi nel suo piccolo casinetto, aperse uno scrigno dal quale trasse un bel piegato pacco di lettere, una più lunga dell’altra, e rileggendole tutte e consideratele bene, si pose dopo molto tempo a scrivere in risposta alle stesse e poscia verso sera, chiamato Nicola, l’oste della Pigna, ed affidatogli il foglio vergato, gli raccomandò di recarsi subito in Napoli e di recapitarlo alla strada dell’Anticaglia, presso quel Signore a cui – sempre per suo incarico – aveva recato altre due lettere.
Che cosa era quel pacco di lettore? Lo vedremo.
Quelle lettere venivano da Roma ed erano indirizzata ad Ernesto da una persona altolocata, che avendo saputo per mezzo di suoi amici e subalterni la posizione nella quale Ernesto si trovava ed il bene che si poteva cacciare[1] da lui ricredutosi dai suoi falsi principii, qualche tempo prima dell’inizio del nostro racconto ne aveva già sondate le acque, facendogli delle proposizioni nello stesso senso che gliene aveva fatto il Duca, ma però con vedute molto più corte[2] e che Ernesto stimava impossibili ad effettuarsi; per conseguenza, non potendo dargli ascolto, aveva scritto al Signore che gli dirigeva una lunga corrispondenza che quantunque in massima egli divideva completamente le sue vedute, pure trovava sì forti ostacoli per la esecuzione, che non poteva in verun modo annuire a ciò che egli avrebbe voluto e tanto più, diceva, si vedeva obbligato a comportarsi in tal modo che non sapeva affatto se qui in Napoli, per i disegni che si accennavano, avrebbe potuto trovare qualche appoggio nel caso di naufragio.
Ma ora che le cose gli si presentavano con vedute molto più vaste, e quantunque più larghe e lontane di esecuzione, pure meno impossibili, ed egli vedeva di poter in qualunque caso aver chi lo difenderebbe nella città di sua permanenza, avendo riflettuto bene dopo l’abboccamento col Duca, riprendendo le lettere pervenutegli da Roma rispose a chi gli aveva scritto diversamente che nella prima occasione, corredando però la sua lettera con riflessioni opportune e con tutte le vedute le più sopraffine che la lunga esperienza di tali cose gli faceva fare.
***
Il terzo giorno, destinato da Carlo al principio del suo progetto, arrivò. Questi, non perdendo un sol minuto, diede subito cominciamento a quello che aveva immaginato. Egli portava lunga barba al mento e capelli tagliati così detti alla tedesca, aveva grossi mostacchi ed un paio di baffetti rivolti all’insù ed incerati che erano una meraviglia e che, dando un certo non so che di virile al bell’ovale della faccia, lo rendevano effettivamente uno dei più bei giovani di Napoli; in un attimo tutta questa roba scomparve sotto il rasoio ed il damerino Carlo prese l’aspetto di un contadinotto imberbe e sciamannato; ed inoltre egli, per farsi creder tale, indossò rozzissime vesti: un paio di brache di tela grossolana, un gilet simile, una giacca di panno bleu, ma tale da dar a divedere di aver fatto per diversi anni il servizio, un cappello molto malandato in testa, un paio di scarpacce eguali a tutto il resto dell’abbigliamento; pose appeso al collo un abitino del Sacro Cuore di Gesù, un altro della Madonna del Carmine e non appena furono battute le ventiquattr’ore[3] si pose in viaggio per la Pigna – senza essersi dimenticato di usare la precauzione di portare un buon revolver per difesa, nascosto in una tasca del calzone – e giunto dopo una buon’ora del suo mettersi in viaggio andò difilato a bussare alla casetta di Ernesto, che egli conosceva, e dall’interno della quale, appena egli diede i primi colpi al portone di strada, si udì un forte abbaiare di cani, compagnia che Ernesto, trovandosi in quel sito, teneva con sé e che non avrebbero fatto entrare alcuno, nemmeno una comitiva armata, senza saltare prima al collo del più ardito che si fosse presentato alla porta.
Al secondo colpo si aprì una piccola finestruola situata perpendicolarmente sul portone ed una voce, quella di Ernesto, dimandò:
– Chi è a quest’ora?
Carlo, con accento piuttosto basso, ma preciso, rispose:
– Un servo del Signor Duca di ***.
– A quest’ora?
– È necessario che apriate: porto con me un foglio di Sua Eccellenza, il quale attende ansiosamente una risposta di unita ad un’altra persona, quest’oggi arrivata da Marsiglia, e che a mezzanotte in punto riparte per Roma.
– Ma…
– Sua Eccellenza vi fa sapere, per vostra buona intelligenza, che non dubitate di me e che vi ricordate che domenica notte, quando foste a trovarlo nel suo palazzo al Monte di Dio, foste seduto sotto il ritratto di suo padre e di rimpetto a quello di sua madre nel suo studio e che l’ultima parola che egli vi disse nel licenziarvi fu: «Addio, signor Ernesto, pensate al trionfo della buona causa».
Ernesto ricordò tutte queste cose, le quali erano più che vere perché Carlo le aveva effettivamente intese; calò giù, frenò lo zelo dei suoi guardiani, schiuse l’uscio e fece entrare l’ambasciatore del Duca, il quale cavato dall’altra tasca delle sue brache – non da quella dove si celava il revolver – un involto di pannilini, da questo trasse un rozzo portafogli, d’onde estrasse la lettera da lui foggiata e la porse ad Ernesto che, riconosciutone il ben imitato carattere, immediatamente l’aprì e, invitato il messo a sedere e riposarsi, cominciò a leggerla con ponderazione e posatezza.
Carlo, sdraiatosi su di un sofà e posato il suo cappello in terra in mezzo ai suoi piedi, come ordinariamente fanno questi uomini di contado, finse a poco a poco di addormentarsi e si trattenne in tale posizione per oltre un’ora, in cui Ernesto lesse il primo foglio, ne vergò la risposta, considerandola con tutta calma e dopo di averla chiusa e suggellata, svegliò dal sonno il messo e, consegnandogliela, gli raccomandò di portarla immantinente al Duca, che ansiosamente l’aspettava, dicendogli a voce che egli ne attendeva, siccome avevano combinato la notte della domenica, l’altra con ulteriori schiarimenti ed istruzioni nella ventura settimana. Carlo promise tutto eseguire e, preso il misterioso foglio, partì e con passo più che spedito andò via, prendendo invece della strada che menava al Monte di Dio, dove abitava il Duca, quella di Via Nuova Monteoliveto, dove era situato il suo quartiere, nel qual sito appena giunto, aprì la lettera di Ernesto, lesse tutto ciò che ci era vergato e che era in correlazione con quella falsa del Duca e, facendo un beffardo sorriso, disse:
– Ci sono riuscito! Ora, signor Duca, siete nelle mie mani; ora Giuseppina sarà mia sposa o almeno l’equivalente della sua dote sarà il compenso del mio silenzio.
Ciò detto, entrò in letto e si addormentò tranquillamente, come se non avesse immaginata la più grande delle perfidie e non si accingesse a metterla completamente in esecuzione.
Al mattino seguente, trasfiguratosi nuovamente e da abile commediante con finti peli al mento, ripreso il suo primo aspetto, verso le undici ore antimeridiane prese la via del Monte di Dio e, presentatosi al guardaportone, che non lo conosceva perché non a parte dagl’imbrogli nei quali era una delle parti principali la figliuola, dimandò se il Duca era in casa ed avutane l’affermativa salì al secondo piano dove questi abitava e si fece annunziare arditamente, facendo dirgli che un gentiluomo doveva parlargli di gravi affari.
Ammesso alla presenta del nobile vecchio, dopo aver fatto le cerimonie di uso, cominciò il seguente discorso:
– Signor Duca, il mio nome è Carlo Alberetti, gentiluomo piuttosto di nascita, quantunque non tale di poter eguagliare la vostra prosapia, ma da poter però aver l’ardire di farvi la proposizione che ora vi faccio. Io amo vostra figlia Giuseppina.
– Voi!…
– E ne sono corrisposto.
– Ciò mi reca somma meraviglia, rispose il titolato; dalle vostre parole e dai vostri modi, quantunque mi accorgo che voi abbiate della intelligenza e della istruzione, pure vengo a conoscenza che siete di una condizione molto al di sotto della mia e, sebbene forse abbiate di già potuto far innamorare mia figlia – cosa, in sostanza, non molto difficile, perché le donne non troppo riflettono a ciò che fanno – pure debbo dirvi che la vostra domanda è frustranea[4] e che io non posso in verun modo annuire ad essa.
– E mi negate la mano di vostra figlia?
– Recisamente, perché, ancorché io volessi transigere nella qualità della vostra nascita – cosa la quale non sono affatto disposto a fare – è troppo necessario avere dei mezzi per portare innanzi una famiglia ed io – sempre ripeto dai vostri discorsi – non trovo un fondamento su cui poggiare questa importantissima circostanza di chi vuol mettere su famiglia.
– Di ciò, signor Duca, non dovete incaricarvi; potete, volendo, informarvi di me e vedere quale è la vita che io faccio, il lusso nel quale vivo.
– Con quali mezzi?
– È mio segreto; ma nonpertanto esso è tale da appagare ogni più schifiltoso padre e nobile vostro pari; poi a questo si aggiunge l’ingente somma a cui ascende la dote della signorina, la quale sarà posta nelle mani di un uomo che saprà farla fruttificare: vedrete che tutto sarà accomodato e che l’avvenire della signorina non può essere in verun modo pregiudicato.
– Signore, – con nobile orgoglio rispose il Duca – voi sì avete tutta l’aria di un cavaliere d’industria ed io non posso rispondere alla vostra domanda che con una sola parola: uscite di casa mia.
– Uscire, signor Duca? Ma non capite che questo è un insulto?
– Signor Carlo, non capite voi che la vostra venuta in questa casa è insulto più grave di quello che ricevete?
Ciò dicendo il Duca posò la mano su di un campanello per chiamare un servo e far mettere alla porta lo sciagurato che l’insultava. Carlo, accortosi della intenzione del Duca, fu sollecito di fermargli il braccio, dicendo:
– Fermatevi, signore, e discutiamo placidamente di affari.
– Non ho affari con persone della vostra qualità.
– V’ingannate, può anche essere che ne abbiate a iniziare qualcheduno, e d’importanza.
– Spiegatevi meglio.
– Io amo vostra figlia.
– Amate la sua dote.
– Vostra figlia ama me.
– Vi dimenticherà, quando saprà che non siete degno di lei.
– Vostra figlia sarà mia moglie.
– Questo è impossibile. – rispose molto seriamente il Duca.
– Questo dev’essere! – rispose con tono beffardo Carlo.
Un lampo terribile balenò alla mente del povero padre. Avesse lo scellerato di già abusato dell’amore di sua figlia? Avesse, per ottenere uno scopo a cui difficilmente per altra via avrebbe potuto arrivare, portata una macchia alla sua famiglia? Si diede un colpo nella fronte e stette per dare in una esclamazione, che compresa da Carlo, lo interruppe dicendo:
– Frenatevi, signor Duca! Comprendo dalla vostra emozione che forse voi mi giudicate un birbante e che temete pel vostro onore. Oh! siate certo che vostra figlia è intatta e che io non sarei stato capace di farle il menomo oltraggio, poiché destinandola a mia sposa non sarei stato cotanto svergognato da disonorarla. Su di questo articolo potete essere sicuro; non è questa la ragione che m’induce a dirvi che il matrimonio si dovrebbe assolutamente fare; ma è tutt’altra, assicuratevi, è tutt’altra.
– Non ne saprei vedere altra.
– Le mura alle volte possono avere orecchi per ascoltare e bocca per parlare: ricordatevi l’abboccamento tenuto all’alba del giorno di domenica…
– Che!… Voi!…
– So tutto.
– Che dite mai!…
– Ma quello che voi non sapete, è che io provo le medesime vostre aspirazioni, che sono perfettamente del vostro partito: ma non però sono innamorato…
– Spiegatevi più chiaro.
– O vostra figlia sarà mia sposa o io ho nelle mani tale documento da potervi precipitare.
– Ciò è impossibile!
– Una lettera che manderebbe in rovina voi ed il signor Ernesto.
– È una menzogna!
– Eccola, osservatela… ma nelle mie mani: riconoscetene il carattere e fremete, che se non mi accordate fra tre giorni il consenso per queste nozze, non passeranno i medesimi che voi insieme col signor Ernesto sarete denunziati. E per tali specie di delitti, per cospirazione, sapete pure che non si transige. Pensate dunque a riparare al mal fatto e riflettete che questa carta, in mano mia, vale tanto oro per quanto non possono valere tutti i tesori della California scoperti e da scoprirsi. Per ora vi levo l’incomodo, ci siamo intesi. Fra tre giorni ritornerò, presenterò questa cambiale e voi o la paghereste, annuendo alle mie brame, o dopo poche altre ore andrete a scontare in un carcere provvisoriamente e quindi – che so in quale altra maniera! – il delitto di cospirazione – e di terribile cospirazione! – di cui i piani sono tracciati in queste due lettere.
Si alzò dopo tali parole, prese il cappello e, salutando cortesemente il Duca, andò via, giubilando di aver molto bene iniziato il suo affare dell’esito del quale si riprometteva la più completa riuscita.
Il Duca rimase annientato. La lettera di Ernesto da lui veduta, quantunque non sapesse in effetti che cosa conteneva, era un documento terribile e non potette far altro pel momento che correre egli medesimo di tutta fretta in cerca di Ernesto e verificare se veramente era cosa pericolosa quella che gli aveva dato ad intendere Carlo. Verificato che tutto era verissimo, comprese il pericolo e non volendo in verun modo annuire alle scellerate pretese dell’innamorato di sua figlia, stabilì di accordo con Ernesto che immediatamente, sotto mentite vesti, la sera sarebbero partiti egli per Parigi ed Ernesto per Roma, per poi raggiungerlo puranche nella capitale della Francia. L’ora fu fissata, i mezzi stabiliti di accordo ed i due cospiratori si separarono per mettere immantinente in esecuzione i loro disegni.
Il Duca nel ritornare a casa non disse verbo colla figliuola dell’accaduto, per paura che questa non facesse conoscere qualche cosa al suo amante; ma chiamato un suo stretto parente, anch’egli nobile e prudente uomo, gli raccontò il tutto e lo incaricò di tenere nel tempo del suo allontanamento la tutela della figlia; sopraggiunta la notte, munitosi di forte somma, partì insieme con Ernesto su di un legno estero che era pronto a far vela e che, dopo toccato il porto di Civitavecchia, faceva volta per Marsiglia.
Carlo non ebbe sospetto di cosa alcuna, perché il parente del Duca, secondo le ingiunzioni avute, non fece parola del fatto alla ragazza se non nel giorno in cui si sarebbe dovuto presentare Carlo, facendo sapere che in quei tre giorni il Duca si era recato in Sorrento per un affare; anzi si fece giungere di là una sua lettera, diretta alla figlia, nella quale le si davano delle incombenze per affari domestici; ma giunta la mattina del giorno destinato, lo zio di Giuseppina le fece conoscere la volontà di suo padre e la trasse con sé in casa sua, mentre Carlo, recatosi per ottenere risposta, non essendosi fatto veder prima, nemmeno dalla sua bella, essendosi egli veramente trattenuto presso un suo amico fuori Napoli, sia per poter togliere di mezzo che il Duca forse avesse potuto cercare e di aggiustare diversamente la cosa non come egli voleva, sia anche per dare a divedere di una certa considerazione, non assediandolo nelle sue risoluzioni.
Terribile fu il disappunto di Carlo, vedendosi con la partenza del Duca tolto di mano il frutto della sua macchinazione; ma però, quantunque da principio fosse sbalordito, pure, rientrato in se stesso, non si diede per vinto e fattosi coraggio, cercò di rannodare presto il filo delle sue pratiche e, se non altro, vendicarsi.
Dalle indagini che potette prendere, si persuase che ambedue i fuggitivi avevano dovuto prendere la via di Roma; per conseguenza cercò subito di raggiungerli e senza por tempo in mezzo prese quella via, gettandosi nella ferrovia, che in poche ore lo avrebbe condotto sulle peste[5] di coloro che aveva premura di raggiungere.
Capitolo VI. Roma
Roma, la Città cattolica per eccellenza; la sede della Religione cristiana, la Cattedra di Pietro e dei suoi successori, vituperata fin dal 1870 dai nemici della Fede, è ora diventata la moderna Babilonia.
Un tempo in essa sedeva un governo santo e fondato nelle tradizioni divine ed ora è soppiantato da quello, che ha avuto la forza di rovinare l’Italia.
Un tempo era sede di virtù e di strettissima morale, ora è immersa, come tante altre città, nell’abominazione e nel peccato.
Roma, insomma, dove una volta si correva per ispirarsi nei suoi sacri monumenti, nelle sue basiliche, per ammirare le grandi funzioni sacre che vi si eseguivano con tutta la possibile pompa cristiana, ora è diventata la schiava dei moderni costumi, il carcere del Vicario di Cristo.
Quella era Roma un tempo, questa è Roma nei giorni presenti.
Ernesto, sbarcato a Civitavecchia, difilatamente prese la via di Roma, essendosi posto di concerto col Duca che lo andava ad attendere in Parigi, mentre egli, nascondendosi sotto un aspetto diverso dal suo, doveva vedere alcuni membri di una certa riunione, che influir potano sopra i fatti di cui si parla e che stavano sempre di accordo con altri uomini, influenti anch’essi, nelle diverse città principali dell’Europa.
Presentatosi in casa di una donna da lui altra volta conosciuta in Trastevere, fu da costei accolto con tutta l’amorevolezza ed alloggiato per la notte, nella quale, avendo per quanto potette cambiato figura e fisionomia, la mattina ben per tempo si recò in diverse case, principiando di nuovo un tirocinio come quello già fatto in altri tempi per causa peggiore, ma che ora era fatto pel trionfo di quella che aveva preso a servire.
Nelle ore meridiane la curiosità, e più di tutto lo spirito patriottico, ma il vero spirito patriottico, lo spinse a recarsi ad assistere ad una seduta del parlamento, volendo vedere e toccare con le proprie mani ciò che in quel luogo si faceva e persuadersi del bene e del male che si faceva alla povera terra da lui stesso in gran parte tradita.
Sedutosi nella tribuna pubblica, cominciò a sentire la discussione, la quale verteva come al solito sull’unica materia che dal 1870 in poi ha occupato i Padri della Patria: l’aggiunzione di nuove tasse alle tante di già esistenti. Ernesto rimase stupefatto ed avvilito, vedendo con quanto cinismo si operava da coloro che, chiamati dagl’improvvidi cittadini a tutelare gl’interessi propri, assumendo malamente il titolo di Padri della Patria, non ottemperano come sarebbe conveniente ai loro mandati e, giudicando a casaccio, sacrificano coloro che gli hanno rivestiti dei poteri, che gli danno tanta forza, e facendo il più delle volte le parti di pecore più che di deputati, fanno come dice il sommo Alighieri: «Quel che l’una fa l’altre più fanno».[6]
Uscito di là, percorse per qualche ora le vie della città eterna, ma giunto verso le ventitré ore nella piazza del Vaticano, s’incontrò faccia a faccia con un uomo che, chiamatolo per nome, con alterigia gli disse:
– Ernesto!… Ah! non mi era malamente apposto, ti ho finalmente raggiunto, ora non sfuggirai alla mia sorveglianza!
– E chi sei tu, che ardisci parlami in questo modo? Io non ti conosco ed il mio nome non è stato mai Ernesto.
– T’inganni: ti conosco troppo e la tua presenza in questa città mi fa giudicare che anche il Duca di *** sia qui.
– Ahi! Tu dunque mi cerchi?…
– Per farti arrestare come cospiratore e farti salire in pochi giorni sul patibolo: corro a chiamare una guardia, un carabiniere e non sfuggirai più dalle mani della giustizia!
– Ma…
– Inutilmente tu ed il tuo complice, il signor Duca, siete fuggiti da Napoli, io vi sorvegliavo, vi ho però raggiunti e non vi lascerò più, se non mi sarò vendicato!
Ernesto, vistosi alle strette, non sapendo più come fare per sfuggire a colui che aveva ben compreso che poteva rovinarlo, cercò, da quell’uomo esperto che era, di trovare una via che lo potesse salvare e, dopo qualche momento di silenzio, ritornò a dire:
– Ebbene, Carlo, noi non ci conoscevamo prima di questo momento; ma ora che la combinazione ci mette a fronte l’uno dell’altro, prima di correre a mezzi violenti, noi potremmo intenderci. Il Duca, persuaditi, non accorderà mai e poi mai il consenso che tu sposi sua figlia; ma se lo scopo tuo nell’impalmarla è piuttosto quello di renderti padrone della sua dote, che della sua persona, il Duca forse non sarebbe alieno dall’accordartela e si può venire a trattative.
– Tu mentisci!
– Non ho mai mentito in vita mia! Il Duca verrà a trovarti, dove sei alloggiato?
– Via del Babbuino, numero 37.
– Vanne a casa, fra un’ora io ed il Duca saremo appo te; tu intascherai una bella moneta e quella somma così sonante e lampante che intascherai, ti farà immediatamente dimenticare Giuseppina e la sua bellezza e potrai, restituendo le lettere inventate da una parte e carpite dall’altra, vivere una vita da gentiluomo; se invece veramente vorrai unirti a noi, sarai accolto fra i nostri di tutto cuore.
Ernesto, mettendo in campo cotale storia, intendeva soltanto di prender tempo e, guadagnando poche ore, apparecchiarsi a fuggire da Roma, recandosi all’estero. dove non avrebbe avuto più timore di Carlo; ma il suo conto fu malamente tirato, perché se egli era accorto, l’altro lo era del pari e difficilmente lo avrebbe potuto ingannare.
Carlo alle parole di Ernesto stette per qualche tempo sopra pensiero, perché rispose, avendo però un piccolo risolino sulle labbra:
– Caro signor Ernesto, le vostre parole sono bellissime: ma chi mi assicura che voi mi diciate il vero e non tentiate burlarmi?
– L’interesse comune di non essere scoperti. Siate sicuro che io non ho mai agito con dolo e se voi vi fiderete in me, otterrete il vostro scopo. Ebbene, – soggiunse – per darvi una prova maggiore di ciò che io vi dico e del vero interesse che io prendo a questo affare, vi propongo che io metterò verso il Duca tutta la mia influenza e vi farò riuscire nel vostro intento; però… siamo tutti uomini e tutti dobbiamo vivere: precisate qual sia la somma della quale vi contenterete, non potendo avere tutta la dote della signorina Giuseppina: qualunque sia la somma l’avrete, ma… però… mi darete un piccolo compenso per la fatica che io metterò in mezzo per farvi ottenere il menzionato scopo.
– Voi mi proponete ciò?
– Ve lo propongo.
– E la somma che io richiedessi, l’avrei?
– Fra poche ore. E partiremo insieme subito di nuovo per Napoli.
Carlo, niente persuaso di quello che Ernesto diceva, volle però vedere dove costui avrebbe saputo giungere e disse:
– Ebbene: la dote della signorina Giuseppina è di centomila franchi, oltre la porzione che potrà spettarle quando il vecchio Duca verrà a morire: mi si diano all’istante sessantamila franchi ed io restituisco le due lettere che potrebbero perdervi.
– Lo so.
– E rinunzierò al mio amore, quantunque io veramente adori quella ragazza; per voi poi, il mezzo per cento potrà bastare?
– Restiamo intesi.
– Io dunque mi ritiro in casa e vi attendo.
– Fra un’ora e mezzo io e il Duca saremo da voi.
Si divisero ed Ernesto avanzò i suoi passi con tutta rapidità verso la sua casa, ruminando un mezzo, onde potesse immediatamente fuggire da Roma e sotto un ben combinato travestimento levarsi dall’imbarazzo in cui si trovava.
Carlo però, che non era per niente persuaso del discorso fatto, finse di allontanarsi, ma dopo aver fatto una giravolta si pose accanitamente sulle peste dell’altro e si recò nel quartiere di Trastevere per spionare[7] tutto ciò che Ernesto faceva.
Costui, giunto nella casa dov’era alloggiato, chiese subito alla donna che lo alloggiava un mezzo sicuro per scappare da Roma e recarsi all’estero.
– Ci vuol poco. – disse la donna – Una barca parte fra breve ed arrivato a Fiumicino potrete prendere la via di terra travestito da contadino e facendo non più che una giornata di cammino a piedi [si può raggiungere Civitavecchia. Da lì, con una nave potere arrivare a Genova e poi,] in pochissimi giorni, trovarvi al traforo del Moncenisio[8].
– Ora dunque bisognerebbe che mi travestissi da marinaio.
– È presto fatto. Eccovi dei panni di mio figlio, che ora serve nel militare; vi raccomanderò al mio compare Giovanni, padrone della barca nella quale dovreste fare il primo tratto di viaggio.
– Chiamatelo: è necessario che io fugga immantinente.
La donna uscì e ritornò dopo poco con Giovanni; nel frattempo Ernesto si era travestito da marinaio e, giunto il padrone della barca, postosi d’accordo con costui e regalatogli una ben guarnita borsa, appena Giovanni era uscito dalla casa, lo seguì da vicino, per andarsi ad imbarcare, dovendo partire dopo pochissimo tempo.
Giunto però presso lo scalo del fiume e mentre si accingeva ad entrare in un piccolo schifo[9] per andarsi ad imbarcare, s’intese improvvisamente una mano sulla spalla, che battendogliela lo scosse, ed una voce che gli disse:
– L’appuntamento è in via del Babbuino numero 37; ma per andarci non ci si va per acqua: la via che avete presa è quella di una fuga, né più, né meno.
– Carlo!
– Ai vostri comandi. Credevate forse che io avessi creduto alle vostre chiacchiere? No, non sono tanto gonzo; ma se la prima volta siete riuscito ad allontanarmi per poco, ora non ci riuscirete, perché in questo momento…
Ernesto, vistosi alle strette, né trovando altra via come liberarsi del suo persecutore senza frapporre indugio, rispose all’apostrofe di Carlo con queste parole:
– Perché voi in questo momento sarete da me punito delle vostre nefandezze e della infamia a noi commessa; eccovi il premio che vi spetta, traditore scellerato, della vostra bricconeria!
E ciò dicendo, con la rapidità del lampo, cavata di tasca una pistola ne fece scattare il grilletto, ferendo nel petto Carlo, che gettando un grido cadde rovescioni, mentre Ernesto, gettatosi nello schifo, raggiunse la barca e sparì a bordo di essa e dopo poco più di un quarto d’ora partiva, senza che alcuno avesse visto tutto ciò che era succeduto, con tanta rapidità fu eseguita la scena su accennata.
Carlo cadde immerso nel proprio sangue ed il colpo fu così bene assestato, che poco mancò non lo rimanesse estinto immantinente; ma però lo fece rimanere talmente maltrattato e rovinato, che finché venne trasportato all’ospedale, tutti supponevano che fosse morto. Dovette eseguirsi l’operazione dagli uomini dell’arte ed estrarre la palla, la qual cosa lo prostrò totalmente di forze, essendo egli di fibra talmente delicata, che non potette resistere al dolore che lo affliggeva e non potette in verun modo emettere verbo. E buon fu per Ernesto che in questo modo potette avere tutto il tempo di fuggire, sbarcare a Fiumicino, prendere un più comodo e facile travestimento ed allontanarsi con la rapidità del vento, e prendere un imbarco nel porto di Civitavecchia e, non seguendo in tutto i consigli che gli aveva dato la donna sua albergatrice, decise di farsi trasportare immediatamente in Marsiglia, dove trovò il Duca. Postolo a parte dell’accaduto e supponendo, come Ernesto credeva, che Carlo fosse perito e che si fossero tolti d’attorno il nemico più terribile, entrambi ritennero che non sarebbero stati più vessati nei loro progetti ed avrebbero con più sicurezza potuto agire con tutta la possibile tranquillità[10].
[1] Ricavare.
[2] Limitate nel tempo e nello spazio.
[3] Cioè l’ora del tramonto, non la mezzanotte. Cfr. pag. 1, nota 2.
[4] Inutile.
[5] Tracce.
[6] Purgatorio, III, 82. Il verso originale recita: «e ciò che fa la prima, e l’altre fanno»
[7] Spiare.
[8] Il traforo ferroviario del Frejus, che collega Francia ed Italia, fu aperto nel 1871. Nel testo originale sono evidentemente saltate una o più righe.
[9] Imbarcazione lunga e sottile, a vela o remi, usata per la pesca costiera.
[10] Frase leggermente adattata per una maggiore comprensibilità.



 invio in corso...
invio in corso...



