Il sogno della Rivoluzione
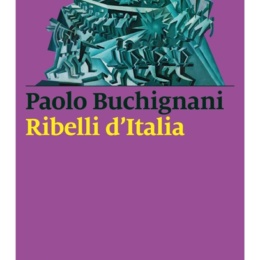
Paolo Buchignani ha tracciato nella sua ultima opera un percorso che, dal Risorgimento agli anni di piombo, mostra la fortuna e la longevità della rivoluzione in Italia
Sin dal Risorgimento, nel nostro Paese s’è sempre fatto un gran parlare di Rivoluzione: l’Interventismo, il Fascismo, la Resistenza, sono solo parte di quel grande sogno rivoluzionario che, da Garibaldi alle Brigate Rosse, ha attraversato e animato lo Stivale senza poi mai concretizzarsi nei fatti. Il nuovo libro di Paolo Buchignani offre perfettamente in tal senso una disamina robusta e impietosa di quella grande e interminata liaison passionaria tra Italiani e Rivoluzione, rianimata oggi dai morsi crudeli della crisi economica. Il nostro Gianluca Giansanti ha intervistato in esclusiva l’autore, a cui va il nostro ringraziamento per la cortesia usataci.
Nel suo scritto appare subito chiaro il fondamentale ruolo svolto, nei rivoluzionari italiani, da quello che Emilio Gentile chiama il “mito della conquista della modernità”: il mito dell’italiano nuovo. Parallelamente a questo corre il considerare la pratica politica come un’esperienza profondamente religiosa, composta da una sua mistica ed un suo apostolato. In questo c’è qualcosa di profondamente anti-moderno che contraddistingue l’esperienza rivoluzionaria italiana da quella di altri paesi nel XX secolo?
La conquista della modernità non è in contraddizione con la visione religiosa della politica. I due elementi spesso convivono. I futuristi, per esempio, sedotti dal macchinismo, dal mito del volo, dalla modernità, hanno ugualmente una visione religiosa ed estetica della politica, auspicano una rivoluzione palingenetica e antropologica. Allo stesso modo molti “fascisti rivoluzionari”, come per esempio Berto Ricci, matematico e uomo di scienza e nello stesso tempo, “mistico” del fascismo.
Si è soliti associare all’idea di rivoluzione quella della Francia del XVIII secolo e della “dittatura della democrazia”. L’esperienza italiana invece, partendo da Manzoni che aveva tanto in dispregio la folla, ci racconta di un profondo anti-democratismo, di un’atavica ostilità nei confronti dei vituperati “ludi cartacei” e della costante ricerca di una élite dirigenziale. Questa particolarità da cosa fu dettata?
Manzoni era un liberale moderato e cattolico, ostile alla rivoluzione, che identificava col giacobinismo: un giacobinismo in cui vedeva la genesi del “terrore” robespierrista, mentre proprio quel giacobinismo di matrice rousseaiana, fondato sul rapporto diretto élite-masse, estraneo alla democrazia liberale rappresentativa, (si vedano gli studi di Jakob Talmon) è alla base del mito della rivoluzione che si è affermato in Europa e con particolare forza in Italia: tanto della rivoluzione declinata nel fascismo quanto di quella declinata nel comunismo. Una rivoluzione che si risolve in una “democrazia totalitaria” (Talmon) e quindi in una dittatura.
Il concetto dell’uomo nuovo operava un sunto delle idee di Nietzsche, Pareto, Le Bon, Sorel e altri. La palingenesi fascista affonda le sue radici nelle disumanità del primo conflitto mondiale, il quale dissipa i flutti alcolici della Belle Époque e getta gli uomini sul freddo suolo della trincea. Qui l’individuo riflette sull’impossibilità di avere un mondo umano rivolto al progresso infinito ed inarrestabile, sui benefici dell’industrializzazione e dello sviluppo scientifico. È qui che nascono i veri rivoluzionari più che dagli esempi mazziniani e garibaldini?
Il mito della rivoluzione, in Italia, ha le sue radici nel giacobinismo e in particolare nel mito mazziniano del Risorgimento come rivoluzione tradita e incompiuta. Si sviluppa in Oriani e nelle élites intellettuali antigiolittiane del primo Novecento (futuristi, sindacalisti rivoluzionari, vociani, il giovane Mussolini), si rafforza con le culture irrazionalistiche e antipositiviste provenienti dall’Europa e poi, certamente, con l’interventismo e con la Grande Guerra, dalla quale nasce il fascismo, la cui logica totalitaria (con l’avversario non si discute, ma lo si annienta, l’avversario è un nemico) è la stessa della guerra. I fascisti rivoluzionari, in particolare, si ritengono figli della guerra, che considerano omologa alla rivoluzione. Durante il regime invocano una nuova guerra per far ripartire quella rivoluzione che ritengono “tradita” dal fascismo conservatore e borghese. Infatti vanno tutti volontari nella guerra d’Etiopia e molti anche nella seconda guerra mondiale.
Quello che contraddistingue l’esperienza fascista da quella di qualsiasi altra forza politica italiana del primo dopoguerra fu l’incredibile forza d’attrazione verso i più giovani, delusi dall’esperienza liberale. Sul “Popolo d’Italia” nel 1919 Mussolini affermava: “se la gioventù delle trincee e delle scuole accorre ai fasci […] è perché, nei fasci non c’è la muffa delle vecchie idee […] ma c’è giovinezza, c’è dell’impeto e della fede”. L’ideal-tipo di rivoluzionario spesso è quello dell’uomo vissuto ed adulto, queste parole però sembrano contraddire tale idea. Quale fu il ruolo dei giovani in seno ai “rivoluzionari italiani”?
Quello della giovinezza fu, nel fascismo, un mito fondamentale (si pensi all’inno “Giovinezza”). I fascisti erano effettivamente giovani (giovane era lo stesso Mussolini), una forza nuova nata dalla guerra e decisa a seppellire lo Stato liberale, l’Italia giolittiana, che giudicava vecchia, pavida, bottegaia, borghese. Il fascismo, viceversa, proprio perché giovane e figlio della trincea, si presentava come il portatore di un’etica alternativa a quella borghese, un’etica fondata sul mito soreliano e futurista della violenza purificatrice, dell’ardimento, del patriottismo bellicista, del disprezzo del denaro e della vita comoda. Su queste basi, la rivoluzione fascista avrebbe dovuto costruire il “mondo nuovo”.
A tutti è noto il passaggio evolutivo compiuto dal movimento fascista: dall’arditismo e dalla mobilitazione rivoluzionaria delle prime avanguardie ad istituzionalizzazione burocratica. Nell’arco di tale evoluzione un ruolo di primo piano viene assunto dal segretario del PNF Augusto Turati. Questo nel 1926, forse nel tentativo di riaffermare il retaggio rivoluzionario fascista, simbolicamente battezzava la FNUF “Alfredo Oriani”. L’abbandono del “santo manganello” tanto caro ai gufini e agli appartenenti ai sommovimenti studenteschi fascisti è chiaramente un cambio di passo notevole. La rivoluzione era già tradita?
Secondo i “fascisti rivoluzionari” sì. La rivoluzione sarebbe stata tradita dai gerarchi borghesi, non tanto da Mussolini, che continuano a considerare il più grande rivoluzionario del ‘900 e attendono impazienti che scateni una nuova ondata squadristica, questa volta non più contro i socialisti, ma contro la borghesia. Le loro speranze si riaccendono all’inizio degli anni ’30, quando il duce, dopo il tempo della conquista del potere e quello del suo consolidamento, apre il “terzo tempo” del fascismo, quello della terza via corporativa, che avrebbe dovuto svincolarlo dalla soggezione alla borghesia. Naturalmente, almeno sul piano economico-sociale, ciò non avviene, ma essi continuano a sperare, con la guerra d’Etiopia e, molti, con la seconda guerra mondiale, che ciò possa accadere.
Molto interessante è l’attenzione posta, dall’autoproclamata aristocrazia nuova, nei riguardi di strumenti nuovi ed alternativi quali riviste e giornali. Lei cita spesso “Lacerba”, “La Voce”, “Il Leonardo” mentre sotto il ventennio possiamo citare tra le numerose esperienze cartacee “Il Lambello”, “Vent’anni” e “L’appello”. Sembra come se i fautori della rivoluzione in Italia avessero scientemente deciso d’imbracciare oltre alla spada anche la penna. È azzardato dire che questa è una peculiarità tipica della “via italiana” alla rivoluzione, una fusione perfetta tra militanza politica e pratica intellettuale?
Non so se si tratti di una specificità italiana: è certamente vero che molti intellettuali italiani, sia del primo ‘900 che del fascismo, intendono combattere per la rivoluzione sia con la penna che con la spada. A volte accade (penso, per esempio, a Berto Ricci) che abbandonino la penna quando si tratta di impugnare la spada: smettono di scrivere per andare al fronte volontari, sempre in nome della rivoluzione. Molti rivoluzionari sono esponenti di una élite intellettuale, di formazione umanistica, scrittori o filosofi, imbevuti di una cultura sulla base della quale si sentono investiti della “missione” di fare un’Italia “grande” e “popolare”, contrapposta a quella “meschina” e borghese di Giolitti, e di farlo con le armi della scrittura e della guerra (Marcello Gallian si definiva “letterato-squadrista.)
Ciò che mi ha colpito maggiormente, oltre all’influenza di Alfredo Oriani, è il debito che le diverse forze rivoluzionarie hanno contratto con Curzio Suckert Malaparte. Questo, per il suo altalenarsi tra esperienza fascista ed adesione al comunismo, fu spessissimo tacciato d’essere nient’altro che un voltagabbana. È il destino di chi cerca così ardentemente il radicale rinnovellamento nazionale?
Difficile dire quanto Malaparte fosse opportunista. Certamente il passaggio dal fascismo rivoluzionario al comunismo era il destino normale di quanti erano stati sedotti dal mito della rivoluzione antiborghese, anticapitalistica, antiamericana, populista. Crollato il fascismo passano al comunismo, in cui trovano ingredienti simili; sulla base anche, di una radicata e persistente visione religiosa e totalitaria della politica. Spesso anche la filosofia gentilana acquisita nel fascismo favorisce la transizione al comunismo
Lei pone molta attenzione su di una tematica che attanaglia trasversalmente le forze che hanno ricercato l’attuazione della rivoluzione palingenetica in Italia, ossia la presenza costante e mortifera di un nemico interno. Un nemico con un nome ed un cognome: forze liberal-borghesi. Questa presenza costante sembra confermare quanto Carl Schmidt asseriva riguardo l’essenza della politica, una politica basata sulla dicotomia “Freund/Feind” (Amico/Nemico) ossia nell’espressione dualistica di politica inclusiva e politica esclusiva. Ogni epoca storica ha il suo grande nemico, a suo parere qual è il grande nemico interno della nostra?
In uno stato democratico non dovrebbero esserci nemici, ma una dialettica costruttiva tra forze diverse. Chi auspica, anche oggi, una rivoluzione palingenetica (poiché considera la realtà assolutamente negativa e non riformabile e attribuisce a se stesso una funzione salvifica), ha una visione totalitaria. Il nemico di oggi è certamente il terrorismo islamico, ma vedo con grande preoccupazione l’ondata di nazionalismo e di populismo che minaccia la coesione e i valori fondanti del mondo occidentale. Quel nazionalismo populista e xenofobo, che sfrutta un disagio reale provocato dalla finanziarizzazione dell’economia, assomiglia maledettamente, nelle sue strutture di base, a quello fascista e nazista degli anni ’20 e ’30 del ‘900. La nazione, un valore positivo finché si sposa con la libertà e il pluralismo, la tolleranza e la solidarietà, oggi, come allora, va degenerando in nazionalismo, portatore di guerre e dittature (pensiamo soltanto alla recente involuzione autoritaria della Turchia). Un nazionalismo, che significa potenziamento della propria nazione a danno degli altri e il cui risvolto è il populismo: la pretesa di autoproclamarsi come l’unico, autentico rappresentante del popolo contro le istituzioni e i partiti. Ricordiamo che il fascismo si definiva “rivoluzione del popolo”, che Mussolini, all’inizio fondò un movimento, che definì “antipartito dei combattenti”. Poi i partiti li abolirà tutti tranne il suo. L’antipolitica è un pericolo reale, accentuato dalla elezione di Trump in America.
Molto interessante è quella “tenaglia destra-sinistra” che si strinse attorno al collo del parlamentarismo ed il riconoscimento delle radici in comune tra comunismo e fascismo italiano. Questi presuppongono non pochi punti di contatto tra gli intellettuali delle due parti, tanto da spingere i dirigenti del Partito Comunista a quello che alcuni potrebbero definire un paradosso storico: il riferirsi ai fascisti come “fratelli in camicia nera”. Dalla fine della guerra moltissimi fascisti abbracciarono l’invito di Togliatti. I più maliziosi più che interpretare questo fatto storico come fedeltà alla causa rivoluzionaria potrebbero concordare con quanto Prezzolini disse riguardo l’Italia, ossia che è il paese del trasformismo politico. Lei cosa ne pensa?
Dell’affinità ideologica tra fascismo rivoluzionario e comunismo, ho già parlato. Il Pci pensò di reclutare i fascisti proprio sulla base di quell’affinità, sia negli anni ’30 che nel secondo immediato dopoguerra (di questa vicenda mi sono occupato in particolare nel mio volume Fascisti Rossi, più volte stampato da Mondadori e che Marsilio riproporrà nei tascabili). Certo, oltre a quell’affinità, fondata sul mito della rivoluzione, avrà inciso anche la grande disponibilità del Pci ad accogliere tra le sue file gli ex fascisti e ad offrire loro appetibili collocazioni nelle istituzioni che Botteghe Oscure controllava nell’Italia repubblicana. Non dimentichiamo che tanto Mussolini quanto Togliatti ponevano grande cura alla politica culturale: pensiamo, per esempio, al ruolo svolto da Bottai con “Critica fascista” e “Primato” e da Giovanni Gentile con l’Enciclopedia Italiana; ma anche al non minore impegno con cui il partito comunista togliattiano si dedicò alla conquista delle “casematte” della cultura.
Ne “Il codice della vita italiana” Prezzolini scoperchia i mali atavici nostrani, dividendo il paese in due tronconi: da una parte i fessi, dall’altra i furbi. A suo modo di vedere i vari Garibaldi, Oriani, Mazzini, Mussolini, Gramsci e Togliatti a quale compagine appartengono?
Mussolini e Togliatti sicuramente ai furbi. Gli altri mi pare ingeneroso definirli fessi. Sono idealisti, forse un po’ ingenui.
Il Sessantotto italiano affonda le proprie origini in un momento d’estrema effervescenza politico-culturale che viene da Lei definito, condividendo la riflessione di Nicola Matteucci, “la terza rivolta populista”: anche qui, come già nell’interventismo e nel fascismo della vigilia, giovani e giovanissimi rifiutano la democrazia, si arroccano in idee semplici e passioni elementari. E’ dunque possibile poter rintracciare, con le naturali differenze del caso, un file rouge antidemocratico che attraversa- dilaniandolo- il Novecento italiano?
Certamente sì. Confermo l’analisi svolta nel libro, proprio sulle orme di Matteucci. I populisti (di cui ho già detto) hanno idee semplici e passioni elementari, che derivano loro da una visione della politica, riconducibile al giacobinismo: astratta, semplificata, demagogica, religiosa, sostanzialmente totalitaria. Una visione che non consente un’analisi realistica dei problemi, né propone soluzioni praticabili, proprio perché ignora la complessità delle cose.
Uno dei punti più originali e interessanti della parte relativa all’Italia del Dopoguerra tratta della “rivoluzione dei cattolici”: sulla scorta dell’elezione di Giovanni XXIII al soglio pontificio, le idee certamente progressiste di Romolo Murri e Giuseppe Dossetti vengono riscoperte e sviluppate da una nuova generazione di cattolici, vogliosi di costruire una “nuova civiltà cristiana” anticonsumistica e addirittura anticapitalistica. Che rapporto v’è tra la DC e costoro? Risulta errato parlare di “catto-comunismo”?
Il catto-comunismo è esistito come una piccola componente interna al Pci. La sinistra democristiana (Fanfani, La Pira, Enrico Mattei), così come la Chiesa conciliare di Giovanni XXIII e Paolo VI, a mio avviso, hanno avuto il merito di compiere una importante apertura sul piano sociale, di denunciare, per esempio, i guasti del neo-colonialismo: mentre la chiesa preconciliare giustificava il colonialismo come opportunità di evangelizzazione, quella post-conciliare denuncia coraggiosamente l’oppressione politica ed economica di cui sono vittime i paesi del Terzo Mondo. Questa apertura, in sé positiva, ha incoraggiato, fra i cattolici– ma non fra i democristiani- il diffondersi del mito della rivoluzione, l’idea che il Vangelo si realizza con la rivoluzione politica e sociale. Alcuni (una piccola minoranza) hanno pensato, in sintonia con le idee del Che, che quella rivoluzione dovesse realizzarsi, attraverso la lotta armata, non solo in Sud America per rovesciare oppressive dittature militari, ma anche nell’Occidente capitalistico: di qui l’apporto di esigui gruppi di matrice cattolica al terrorismo brigatista.
Gli anni sessanta vedono la destra- raccolta tra i labari del MSI- intenta in un’inedita opera di “rivoluzione” tradizionalista che trova in Julius Evola il proprio guru dottrinario. In tal senso, perché i “fascisti” decidono di abbandonare il patrimonio di idee e di fatti del Ventennio mussoliniano? Questa svolta esoterica e reazionaria non risulta in fondo antitetica e opposta all’esperienza storica del Regime?
Sì, Evola, durante il Ventennio, aveva scarsissimo seguito, sia tra i fascisti rivoluzionari che tra quelli conservatori. La sua fortuna nel dopoguerra è dovuta al fatto che egli, col suo spiritualismo radicale ed antimoderno, offre ai fascisti sconfitti una spiegazione che dà un senso a quella disfatta e, nello stesso tempo, sbarrato uno sbocco politico prossimo, una speranza di redenzione, seppur a lungo termine: secondo la sua visione, con la guerra mondiale hanno vinto le forze del materialismo capitalista e comunista incarnate al massimo grado da Usa e Urss, ma i neofascisti sono “uomini” in piedi fra “le rovine”, per parafrasare il titolo di un suo libro del tempo, una specie di “Bibbia” della destra radicale. Hanno prevalso le forze oscure della modernità, radicate nel Rinascimento e nell’illuminismo, ma gli uomini rimasti in piedi devono mantenere accesa la fiamma dei valori tradizionali e preparare la riscossa. Nel Msi, tuttavia, ci sono anche i “socializzatori”, che si rifanno al “fascismo di sinistra” della Rsi. E poi, la prassi politica, di fatto, è altra cosa rispetto al radicalismo evoliano: alcuni cercano l’inserimento nel “sistema”, altri scelgono la strada della violenza terroristica.
La violenza sarà la cifra caratteristica degli anni di Piombo, unica ed ultima bandiera rimasta a chi ha imboccato la via della lotta armata e dell’eversione. Colpisce come la totalità dell’ultrasinistra sia convinta della possibilità di fare la rivoluzione. Ingenuità o clamoroso errore di valutazione? Il peccato originale dei sindacalisti rivoluzionari appare ancora presente nelle BR e nella vasta area dell’autonomia?
Nell’Italia degli anni ‘60 c’è una inquietudine di fasce operaie che vivono il trauma di una improvvisa modernizzazione (migrazioni interne, carenze infrastrutturali) e un ribellismo studentesco marcusiano e marxista legato all’avvento della scuola di massa; è diffuso e potente il mito della rivoluzione, mancandone però del tutto le condizioni. Come osservò l’ex brigatista Patrizio Peci, per la rivoluzione manca una condizione fondamentale: manca la fame. Nella deriva terroristica del ’68, che è una scorciatoia per un consenso alla rivoluzione che non si riesce ad ottenere, è sicuramente presente (lo ha riconosciuto anche Adriano Sofri) l’idea sindacalista rivoluzionaria e marxista della violenza come levatrice della storia.
Al contempo, il ghetto in cui la destra evoliana si è autoconfinata diviene serbatoio di manovalanza da cui attingere per gli scopi più loschi e vili: la cosiddetta Strategia della Tensione s’intreccia ripetutamente con i settori più estremi del neofascismo. Come e perché lo stragismo attinge a piene mani dai neri? Perché non appare possibile una comunione di intenti tra gli opposti estremismi, accumunati dall’odio antiborghese e dal rifiuto della democrazia?
L’anticomunismo della destra evoliana, confinata nel ghetto, viene utilizzato dalla forze oscure che manovrano la strategia della tensione. Gli evoliani si fanno manovrare per uscire dal ghetto, per seminare terrore e caos che pensano possa mettere in crisi quel sistema che odiano. E, su questo terreno, come ha confessato il terrorista nero Concutelli, in realtà una sorta di alleanza col terrorismo rosso c’è stata, o è stata tentata, perché gli uni e gli altri volevano abbattere lo Stato borghese.
In conclusione osiamo sconfinare nella attualità. Oggi che si fa gran parlare di populismo, è possibile intravedere in Italia un quarto tempo di quella rivolta appunto populista che ha segnato a fondo il Novecento italiano? Nell’attuale contesto di grande e perenne difficoltà economica, quasi di fame come direbbe il brigatista Patrizio Peci, può strutturarsi nel nostro Paese una deriva estremistica, rivoluzionaria?
Ho indirettamente risposto a questa domanda: il disagio attuale– disoccupazione di massa, intollerabili diseguaglianze- ha già attivato la quarta rivolta populista, fatta di idee semplici e passioni elementari, di demagogiche semplificazioni, di autoproclamazioni che pretendono l’esclusiva rappresentanza del popolo (come se il popolo fosse un monolite e non una pluralità di soggetti con idee e interessi diversi), in contrapposizione ai partiti e all’establisment. Si tratta di un populismo più reazionario che rivoluzionario, a vocazione totalitaria, che minaccia non di contrastare l’establishment, come afferma (e che è in gran parte responsabile dei guai da cui è nato il populismo stesso) ma di colpire la democrazia liberale e di frantumare l’Occidente. Insomma, come accadde negli anni ’20 e ’30, pur in un contesto diverso, la quarta rivolta populista non è la soluzione al disagio, ma una medicina sbagliata che ci precipiterebbe dalla padella nella brace. In Italia mi pare si debba identificare con i sostenitori di Trump: Meloni, Salvini, ma soprattutto il Movimento 5 Stelle, il più pericoloso perché più trasversale e suscettibile di pescare consensi a destra e a sinistra.
fonte
https://www.lintellettualedissidente.it/monogrammi/il-sogno-della-rivoluzione/



 invio in corso...
invio in corso...



