“Siamo fottuti, regina!” (Re Francesco II delle Due Sicilie, Gaeta, 14 febbraio 1861)

“Solo. A prendere decisioni che avrebbero dovuto salvare il trono dove nel 1734 si era seduto, per primo, il suo avo Carlo III. Solo, a 24 anni, a tentare di salvare il regno e il futuro della dinastia“. Così Gigi Di Fiore descrive Francesco II di Borbone, l’ultimo Re di Napoli e delle Due Sicilie, in quell’estate da tregenda del 1860.
Solo, ma non del tutto. Aveva accanto la moglie, Maria Sofia di Baviera, sorella della leggendaria Principessa Sissi. Il 5 settembre il Re incaricò il Primo Ministro di scrivere l’annuncio della partenza per Gaeta, poi andò in girò per Napoli con la Regina, su una carrozza scoperta, con al seguito un paio di gentiluomini. La solita passeggiata quotidiana, come se l’avanzata di quel Generale col poncho – che Re Francesco chiamava familiarmente “il nostro Don Peppino” – non avesse tolto ai Sovrani neanche un quarto d’ora di serenità, come se nulla li potesse privare del dominio di sé, neanche la più pietosa delle scene, proprio sotto i loro occhi.
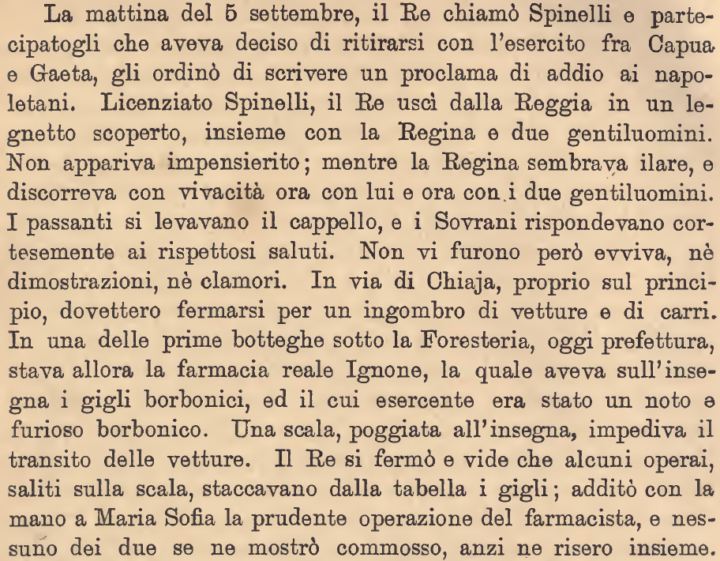
Francesco II era salito al trono il 22 maggio 1859, “nel punto in cui ferve in Italia una delle più difficili crisi che abbia mai offerto la storia“, si legge nel “Fondo Borbone” dell’Archivio di Stato di Napoli (f. 1691, n. 160). Le circostanze e i tempi non gli avevano permesso di imparare il mestiere di Re, di conoscere i suoi consiglieri, di mettere a fuoco le situazioni, di acquisire la maturità necessaria a padroneggiare quella caotica fase di conflitti ideologici, politici e militari.
La Costituzione, l’amnistia, il rientro degli esuli e la riforma delle istituzioni siciliane sono tutti meriti snaturati dalle contingenze, privi di efficacia. Il Regno è debole e miope. La politica estera delle Due Sicilie aveva una tradizione di stretta neutralità e l’aggressione di uno Stato straniero sfuggiva a ogni previsione. La classe politica era totalmente impreparata a una “guerra ingiusta e contro la ragione delle genti“, come Francesco l’avrebbe definita nel Proclama del 6 settembre. Ingiusta e conto la ragione, perché orfana della figura centrale che sin allora aveva sostenuto la retorica romantica e giustificato l’azione bellica: lo straniero invasore e usurpatore di una terra destinata a ritornare unita. Nelle Due Sicilie non c’erano gli Asburgo, i Lorena o gli Este. Nelle Due Sicilie regnava la dinastia dei Borbone, da 127 anni. “Non so cosa voglia dire l’indipendenza italiana” – avrebbe detto Re Francesco – “io penso soltanto all’indipendenza napoletana“.

I traditori pagati dal mio nemico straniero sedevano accanto ai fedeli nel mio Consiglio;
ma nella sincerità del mio cuore io non potea credere al tradimento”.
(Re Francesco II delle Due Sicilie)
Scocca l’ora più tenebrosa, quella del tradimento.
L’alternativa tra Napoli e Torino – tra la difesa di un Regno secolare e la partecipazione alla formazione di un nuovo Stato – sfuma da scelta ideologica a calcolo di convenienza, attiva antagonismi e ambizioni personali, favorisce riallocazioni di potere e aspirazioni di carriera, mette in crisi la fedeltà alla dinastia, i legami col territorio, il sentimento di appartenenza, le tradizioni.
E’ il contrappasso alla straordinarietà di Re Ferdinando II. La continuità dinastica – l’assenza di fratture tra la scomparsa dell’antico Sovrano e l’avvento del suo successore – sconta per la prima volta incertezze e perplessità. La formula il Re è morto, lunga vita al Re, il Re è morto, viva il Re – la versione aristocratica del più popolare morto un Papa se ne fa un altro – è messa sotto pressione dall’impietoso confronto tra i due Re. La sacralità costruita intorno a Ferdinando fatica a rimodularsi su Francesco. La Monarchia borbonica – privata di una figura mitizzata, che aveva accentrato tutti i volti del potere – si ritrova esposta a una perdita di fascino e mordente. La legittimità ereditata lascia il posto al consenso da conquistare, con l’audacia, il carisma, la forza.
Ma Francesco non era Ferdinando. I suoi stessi familiari – i fratelli minori e la Regina Maria Teresa – continuarono a trattarlo con sufficienza, a tenere atteggiamenti informali, e al fondo non ne riconobbero mai l’autorità. Persino la presa di potere – per lo smisurato rispetto verso Ferdinando, della famiglia reale prima, e dell’intero Regno poi – non si accompagnò subito a feste e tripudi: le celebrazioni per Re Francesco iniziarono soltanto il 24 luglio – ben tre mesi dopo la morte di Re Ferdinando – e si protrassero solo per tre giorni.
C’era tutto un corpo politico e militare fedele alla persona del Re, più che alla storia del Regno, legato alla figura del Sovrano, più che all’idea di Nazione napoletana. Gli elementi della triade Re-Esercito-Territorio – che sotto Ferdinando avevano raggiunto rispettivamente il massimo livello di legittimazione, efficienza e radicamento – non solo scontavano un calo fisiologico, ma subivano l’urto di una nuova ondata rivoluzionaria. I nemici dei Borbone avevano gioco facile nel ribaltare il significato della continuità dinastica, nell’enfatizzarne il lato speculare. Francesco II era figlio di Ferdinando II, nipote di Francesco I, pronipote di Ferdinando I, ultimo anello di una catena simbolo di una maledizione perpetua, ultimo esponente di una stirpe di vili tiranni, un “nemico giurato d’Italia, un Re che giura solo per poter spergiurare“, avrebbe detto Carlo Poerio, la perla degli esuli napoletani.
Gli assi portanti della dinastia iniziano a sfilarsi. I rappresentati della vecchia guardia si rivelano traditori, disertori, a loro dire rivoluzionari o patrioti. Francesco non ha fatto in tempo a conoscerli, e già se li ritrova schierati contro. Dietro i cambiamenti epocali, dietro lo stravolgimento dei regimi e delle istituzioni, ci sono pur sempre gli uomini, singoli individui, protagonisti in carne e ossa della storia, a cui le rivoluzioni offrono straordinarie e irripetibili occasioni per realizzare carriere fulminee. Perché sudarsi galloni e promozioni, se tutto poteva aversi semplicemente con un cambio di casacca e di padrone, per di più giustificato dalla più nobile delle motivazioni? Perché impegnarsi in una partita già in mano all’avversario, soprattutto se a reggere il banco era Cavour, il maggiore statista dell’epoca? Perché combattere, se tutto era già scritto, e l’alternativa era così allettante? “Ma se l’Europa non lo vuole, perché dobbiamo farci ammazzare per lui?“, si racconta protestasse un alto Ufficiale borbonico, ad agosto, riferendosi a Re Francesco.

e così la slealtà di pochi e la clemenza mia hanno aiutato la invasione Piemontese,
pria per mezzo degli avventurieri rivoluzionari e poi della sua Armata regolare,
paralizzando la fedeltà de’ miei Popoli, il valore dei miei soldati”.
(Re Francesco II delle Due Sicilie)
Spicca un nome su tutti: Alessandro Nunziante, uomo dei Borbone, amico intimo e consigliere storico di Re Ferdinando, consultato di continuo anche da Re Francesco. E’ la figura da esibire a Torino, come simbolo dell’implosione delle Due Sicilie, e da usare a Napoli, per far passare l’esercito borbonico dalla parte del Piemonte, prima dell’arrivo di Garibaldi. Invia le dimissioni il 2 luglio, senza ricevere risposta. Scrive una seconda lettera, due settimane dopo, col colpo a effetto: la restituzione in blocco delle onorificenze ricevute negli anni, le più prestigiose del Regno. Non può portare sul petto – dice – le decorazioni di un Governo che “confonde uomini onesti, retti e leali con quelli che meritano disprezzo“. Inviterà i suoi uomini a divenire “soldati della gloriosa patria italiana” e la moglie lascerà l’incarico di dama di corte.
La perdita più grave, però, non è in un singolo nome, mai in un intero corpo militare: la Marina. “Possiamo ormai far conto sulla maggior parte dell’officialità della regia marina napoletana“, scriveva l’Ammiraglio Persano al Conte di Cavour. E ancora: “Gli Ufficiali Napoletani son pur devoti alla politica di V.E. ed a me. Conservo corrispondenza con quelli di Napoli, non compromettente, ma tale però che ce li assicura senza fallo. Mi scrivono che se si tratta di venire sotto il mio comando son pronti quando che sia“. E poi: “Gli Stati Maggiori di questa marina si possono dire tutti nostri, pochissime essendo le eccezioni“.
Il vile trasformismo della Marina è oggi unanimemente riconosciuto, come apparve evidente già allora. “Rispetto alla Marina Napoletana, era impossibile riconoscere le ultime promozioni fatte da Garibaldi, ch’io non esito a qualificare scandalose” – scriveva Cavour a Vittorio Emanuele. “I contro ammiragli Vacca, Anguisolla, Scugli, ecc. erano capitani di fregata nello scorso luglio, sono di sei o dieci anni meno anziani dei nostri capitani; non si sono mai battuti, hanno navigato pochissimo; non hanno saputo né servire il loro Re, né dichiararsi per la loro patria, hanno sino all’ultimo cercato a tenersi la via aperta per approfittare degli eventi qualunque essi fossero“.
Ma defezioni e tradimenti si erano avuti già in Sicilia, prima che Persano arrivasse a Napoli con armi per combattere, agenti per negoziare e denaro per corrompere. Francesco Cossovich, incapace di impedire l’arrivo delle navi garibaldine. Guglielmo Acton, con la sua ridicola opposizione allo sbarco di Marsala. Marino Caracciolo, in clamoroso ritardo nell’appoggiare il già debole contrasto ai “Mille”. Amilcare Anguissola, pronto a consegnare la sua pirofregata Veloce a un imbarazzato Persano (che a sua volta la girò a Garibaldi che la ribattezzò Tuckory, il nome del soldato ungherese caduto a Palermo con le camice rosse).
I fatti siciliani suscitarono sconcerto persino a Torino. “Le cose di Sicilia sono una gran lezione ai Governi” – scriveva D’Azeglio a Persano, il 28 maggio 1860 – “Pensare che quello di Napoli è arrivato a indebolirsi al punto che un uomo solo, con poche centinaia, sembra ormai sia bastato a rovesciarlo. Quel che non capirò mai (salvo aiuto inglese, o tradimento dei comandanti napoletani) è come il Re, con ventiquattro fregate a vapore non abbia potuto guardare tre o quattrocento miglia di coste. Una fregata ogni venticinque miglia faceva dalle dodici alle sedici fregate, e mai più bella occasione di servir bene. Basta: meglio così“.
Il voltafaccia delle forze di mare fu impressionante, ma altrettanto sconcertante fu l’atteggiamento delle forze di terra.
La lista è aperta da Paolo Ruffo, Principe di Castelcicala, luogotenente del Re in Sicilia. Inviò contro le camicie rosse soltanto la colonna del Generale Francesco Landi (anch’egli bollato col marchio di traditore, e se non lo fu nei fatti, lo rimase nella percezione diffusa: relegato a Ischia, retrocesso alla seconda classe e infine collocato in pensione). Non utilizzò la “Brigata Bonanno”, giunta da Gaeta a rinforzare le truppe. Rimase incerto, timoroso e indeciso in ogni circostanza. Re Francesco lo richiamò a Napoli dopo lo sbarco di Garibaldi, gli evitò il giudizio del tribunale, ma non gli risparmiò un giudizio personale – moralmente più pesante – di incapacità e codardia. Non lo incontrò né lo volle a Gaeta.
Ferdinando Lanza sostituì il Castelcicala, su consiglio di Filangieri. Disponeva di 20.000 uomini e seppe solo asserragliarsi a difesa della capitale siciliana. Inviato anche lui a Ischia, in attesa di giudizio, fu poi assolto e messo in aspettativa, anche qui con una condanna morale di Francesco che oltrepassava ogni sentenza formale. Sarà tra i primi a recarsi a Palazzo d’Angri a ossequiare Garibaldi, dopo la partenza del Re da Napoli.
Giuseppe Letizia consigliò a Lanza di prolungare la tregua con i garibaldini, di affrettarsi a firmare la capitolazione, quando a Palermo c’erano ancora migliaia di soldati borbonici pronti a combattere. Gennaro Gonzales riuscì a perdere un’intera Brigata, prima a Messina e poi in Calabria, senza sparare un colpo. Francesco Bonanno, inviato in Sicilia in aiuto di Landi, sbarcò inspiegabilmente a Palermo anziché a Marsala, e poi, in Puglia, smarrì anche lui la sua Brigata. Il Maresciallo Filippo Flores non provò neppure a combattere e preferì sedersi subito a tavolo delle trattative col Generale garibaldino Stefano Turr. Tommaso Clary fu il principale responsabile della perdita definitiva della Sicilia, anche a causa delle infelici decisioni prese a Catania, dove i borbonici erano usciti vittoriosi, e anziché consolidare le posizioni favorevoli furono smembrati con l’invio di truppe a Messina. E poi Fileno Briganti, Nicola Melendez, Giuseppe Caldarelli, Giuseppe Ghio, tutti personaggi ambigui, in vario modo colpevoli dell’atto più ignobile: il rifiuto a combattere, l’accordo sottobanco col nemico, l’abbandono delle truppe.
L’elenco della vergogna sarebbe interminabile, a volerlo esaurire. C’era una massa di imbelli e profittatori che quando fu chiaro chi fosse il vincitore “si dichiararono partigiani del nuovo ordine di cose e si sarebbero dichiarati anche sans culottes o maomettani se vi avessero trovato tornaconto” – scriverà il cappellano borbonico Giuseppe Buttà.
Possiamo gettare sale sulla ferita del tradimento – come Renata De Lorenzo – e chiederci come mai il Regno Due Sicilie “avesse nei suoi quadri di vertice uomini vecchi e inoltre facilmente corruttibili o comunque pronti ad abbandonare l’ ‘amato’ sovrano“; ma sarebbe un’impostazione autoreferenziale, un voler tacere su modalità persuasive di stampo manifestamente corruttivo, un mettere in sordina il male fatto alla causa risorgimentale da una fedeltà divenuta merce di scambio; e persino la De Lorenzo, di fronte a tradimenti e cospirazioni, a sotterfugi e manipolazioni, non può fare a meno di dare voce al pensiero dell’uomo della strada: “avrebbero agito allo stesso modo nei confronti di Re Ferdinando?“.

La caduta di Gaeta non sarà mai pagata abbastanza“
(Camillo Benso Conte di Cavour)
L’oro del Governo di Torino aveva comprato i militari di Napoli. Forse avrebbe potuto corrompere anche il Re.
Francesco aveva portato poco a Gaeta. Non aveva ritirato i depositi personali, aveva lasciato intatto il tesoro dello Stato, e messo in salvo dalla Reggia solo oggetti di devozione e ricordi familiari. Il Governo italiano confiscò tutto, ma era anche pronto a una conciliazione, a restituire a Francesco il suo patrimonio, se solo Francesco avesse pubblicamente rinunciato a ogni pretesa sui territori delle ormai decadute Due Sicilie.
Francesco oppose sempre un fermo e dignitoso rifiuto. Non accettò mai di ritirarsi in cambio di un’onorevole sistemazione, anche quando stretto da condizioni economiche precarie. Ancora nel 1870, all’indomani della partenza da un agonizzante Stato Pontificio, così rispondeva al diplomatico austriaco, Barone von Hubner, che si offriva di mediare per il recupero di almeno una parte delle ricchezze: “La restituzione del mio non mi adesca. Quando si perde un trono, poco importa il patrimonio. Se l’abbia l’usurpatore o lo restituisca, né quello mi strappa un lamento, né questo un sorriso. Povero sono, come oggi tanti altri migliori di me. Il mio onore non è in vendita“.

(Re Francesco II di Borbone delle Due Sicilie)
All’ora più buia seguono i rintocchi dell’orgoglio e della dignità.
Il traditore aveva permesso la supremazia dei nemici – interni e esterni – ma aveva anche offerto le motivazioni ad agire ai lealisti borbonici, e “giammai il Regno di Napoli ricorda soldati così fedeli alla bandiera” – scriverà Cesare Morisani, un intellettuale militante – come quelli chiamati a far da controcanto ai vili e ai disertori. Chi fu obbligato a seguire le scelte opposte dei diretti comandanti – come i marinai delle navi sequestrate da Persano – espresse il suo dissenso con azioni di sabotaggio. Non si mossero le navi a cui Vincenzo Criscuolo – fedelissimo della dinastia – aveva ordinato di accompagnare il Re in partenza. Lo seguì però la fregata a vela Partenope, stracarica di uomini. I capitani traditori Vacca e Vitagliano recuperano sì le loro navi, ma le trovano vuote: gli equipaggi erano scesi a terra, per raggiungere Francesco a Gaeta.
La resistenza di Gaeta – fiera, orgogliosa, accanita – mirava a suscitare una reazione diplomatica all’espansionismo corsaro dei Savoia, ma si alimentava anche con la speranza di un revival del miracolo del 1799, quando un’azione lampo, supportata dal popolo, aveva riconsegnato il Regno al bisnonno di Francesco II. “Quella gloriosa e sventurata campagna del 1860-1861” – come la definì il Generale Giosuè Ritucci, comandante del fronte del Volturno, memoria storica dell’Armata delle Due Sicilie – coagulò la rabbia per la prepotenza dello straniero, il disprezzo per il tradimento dei profittatori, la lealtà delle truppe rimaste accanto alla dinastia e l’eroismo dei popolani. Nasceva il mito unificante della resistenza borbonica.
“Chi restò fino all’ultimo, fra quelle mura di sasso, rimase orgoglioso della scelta atta al punto da scriverlo sui biglietti da visita. Difficile comprendere che cosa spingesse tanta gente a combattere su quell’estremo baluardo di una guerra ormai definitivamente compromessa. Odio per il nuovo corso? Desiderio di non darla vinta ai prepotenti? Senso dell’onore? La storia, talvolta, regala atteggiamenti razionalmente incomprensibili che maturano in un clima irripetibile, esaltato, anche se appare del tutto evidente – agli stessi protagonisti – che il risultato finale non può che essere un massacro […]. I borbonici legittimisti sapevano di non avere un briciolo di speranza. Il loro atteggiamento poteva sembrare il rimasuglio di una romanticheria ottocentesca. Forse qualcuno sperava ancora nella rivolta del popolo e nella guerriglia nelle campagne, ma la maggior parte non poteva non rendersi conto che Francesco II e i brandelli di corte rimasti con lui avevano le ore contate. Viverle eroicamente era il tributo che ciascuno pagava al proprio orgoglio. […]. Francesco II e la regina Maria Sofia si comportarono con orgoglio e dignità. Lui riscattò l’immagine del mollaccione che gli era piombata addosso e lei fu donna di straordinario fascino che trascinò l’entusiasmo dei giovani nobili d’Europa. Si distinsero sugli spalti, incoraggiarono i soldati, curarono i feriti e si dichiararono comprensivi con gli uomini della guarnigione, condivisero il razionamento del cibo e, anzi, si privarono del pranzo per favorire gli abitati civili della cittadella. […]. Sembravano preparati – e forse rassegnati – al peggio e lo dimostrarono in modo quasi incurante, come fosse un dovere della regalità“.
Lorenzo Del Boca ci ricorda che gli eroi sono eroi, non perché vincono o perdono, ma perché si comportano da eroi.
I giorni di Gaeta – a prescindere dall’esito – rimangono una pagina di epica. Lontani dalle ipocrisie e dagli intrighi, in un’atmosfera irreale, tra fragore, polvere e grida, Francesco e Maria Sofia riacquistano il loro spazio e la loro gloria, costruiscono una regalità esaltante, attraverso il contatto quotidiano con i soldati, la condivisione dei pasti, la sfida alla morte, sorretti dalla semplicità delle loro abitudini di vita.
“Che il nostro destino sia presto deciso o che un lungo periodo di sofferenze e di lotte ci attenda ancora, noi affronteremo la nostra sorte con docilità e senza paura, colla calma fiera e dignitosa che si conviene ai soldati; noi andremo incontro alle gioie del trionfo o alla morte dei prodi, innalzando l’antico nostro grido di Viva il Re!“: è il messaggio degli Ufficiali nella Fortezza di Gaeta, un mirabile esempio di valore militare e fedeltà politica, che riscatta l’onore dei Borbone e salva la storia delle Due Sicilie.

di cui la tristezza dei tempi ci à fatto spettatori afflitti ed indegnati;
noi sottoscritti, uffiziali della Guarnigione di Gaeta, veniamo, uniti in una ferma volontà, rinnovare l’omaggio della nostra fede innanzi al vostro trono,
reso più venerabile e splendido dalla sventura.
Cingendo la spada, giurammo che la bandiera affidataci da V.M.
sarebbe difesa da noi, a costo del nostro sangue.
E’ a questo giuramento che intendiamo restar fedeli;
quali che siano le privazioni, le sofferenze e i pericoli ai quali ci chiama la voce dei nostri capi,sacrificheremo con gioia le nostre fortune, la nostra vita e tutt’altro bene
per il successo o pei bisogni della causa comune.
Gelosi custodi di quest’onor militare che distingue solo il soldato dal bandito,
vogliamo mostrare a V.M. ed all’Europa intera
che se molti fra noi ànno col tradimento o viltà macchiato il nome dell’Armata Napolitana, grande fu pure il numero di quelli che si sforzarono
di trasmetterlo puro e senza macchia alla posterità”.
(Messaggio degli Ufficiali a Re Francesco II,
in risposta al termine ultimo del 31 dicembre 1860
dato dal Re a chi avesse voluto lasciare Gaeta)

Il tradimento interno, l’attacco della bande rivoluzionarie di stranieri,
l’aggressione di una Potenza che si diceva amica,
niente ha potuto domare la vostra bravura, stancare la vostra costanza.
In mezzo a sofferenze di ogni genere, traversando i campi di battaglia,
affrontando il tradimento, più terribile che il ferro e il piombo, siete venuti a Capua e Gaeta, segnando il vostro eroismo sulle rive del Volturno, sulle sponde del Garigliano,
sfidando per tre mesi dentro a queste mura gli sforzi di un nemico,
che disponeva di tutte le risorse d’Italia.
Grazie a Voi è salvo l’onore dell’Armata delle Due Sicilie;
grazie a Voi può alzar la testa con orgoglio il vostro Sovrano;
e sulla terra di esilio, in che aspetterà la giustizia del Cielo,
la memoria dell’eroica lealtà dei suoi Soldati,
sarà la più dolce consolazione delle sue sventure”.
(Re Francesco II delle Due Sicilie)
Un clamoroso ritrovamento: lo svolazzo n. 23di Gaeta, su francobolli borbonici.
Emilio Diena congetturava l’esistenza dello svolazzo di Gaeta,
ma dubitava della consegna all’Officina, e comunque del suo effettivo utilizzo,
a causa delle operazioni belliche del periodo garibaldino,
non disponendo di nessun documento (lettera, frontespizio, frammento).
Suo figlio, Alberto Diena, ne aveva poi rintracciato uno,
in una lettera affrancata con un esemplare della IV emissione del Regno di Sardegna,
per cui si ebbe certezza dell’utilizzo, ma non ancora sui francobolli di Napoli.
Altri studiosi e collezionisti non ebbero miglior fortuna, nelle loro ricerche.
Sin quando – anno 2015 – l’Ingegner Mario Merone ha mostrato il pezzo qui riprodotto.
“Il fortunato mio ritrovamento mi da l’occasione di mostrare
quanto è rimasto della parziale lettera spedita da Gaeta il 19 ottobre 1860 per Berna
dove giunse, per via di mare, con i Piroscafi Postali Francesi.
Sul fronte della lettera fu apposto, in azzurro, il bollo circolare di Gaeta,
a grande dimensione, con fregi,
mentre i francobolli, coppia orizzontale del 2 grana, prima tavola, e 5 grana, prima tavola,
entrambi rosa brunastro, furono obliterati con lo ‘svolazzo‘ del tipo 23, nel colore nero.
Con il ritrovamento mi sovvennero le seguenti domande:
1) – Se lo svolazzo del tipo 23 fu regolarmente consegnato all’Officina di Posta di Gaeta,
come mai finora non ci è pervenuta alcuna lettera
con i francobolli del Regno obliterati con siffatto annullamento?
2) – Come mai, con l’assedio di Gaeta, tale lettera superò le linee nemiche?
In riferimento alla prima domanda posso concludere
che il bollo ‘svolazzo‘ a Gaeta venne consegnato al locale ufficio di posta
ma non mi consente di precisare la data di detta consegna.
Posso, comunque, affermare che la consegna sia avvenuta
tra la metà e la fine del mese di agosto 1860.
All’epoca la corrispondenza da Gaeta era minima e la grave situazione storica del momento
non consentì all’ufficiale postale il normale uso del bollo appena ricevuto.
Va anche detto, inoltre, che Sua Maestà il Re il 7 settembre 1860 lasciò la Capitale
e si rifugiò a Gaeta con le sue truppe.
Anche molti notabili, tra i quali Caracciolo di San Vito e l’abate Eicholzer,
il Nunzio Apostolico, Monsignor Giannelli e diversi Ministri, Bermùdez de Castro,
il Cavaliere Frescobaldi, il principe Volkonskij ed altri, raggiunsero Gaeta.
Qui vi erano accampati anche circa ventimila soldati e molti generali ed ufficiali superiori
oltre un congruo numero di cavalli e muli.
Molti, inoltre, erano i volontari, e tra questi molti svizzeri,
che arrivavano per la difesa di Gaeta ed a sostegno della causa borbonica.
Le comunicazioni tra notabili e familiari avvenivano solo a mezzo del telegrafo elettrico.
La truppa non aveva comunicazioni con i propri familiari
non soltanto per la linea di fuoco esistente prima al Volturno,
tra il 26 settembre 1860 e il 2 ottobre, e successivamente al Garigliano,
ma anche perché tanto la truppa che gli ufficiali percepivano a Gaeta
soltanto il “soldo semplice” come paga con la promessa reale che la differenza di paga
sarebbe stata loro data al termine della guerra.
I dispacci e i Proclami reali, oltre che con il telegrafo elettrico,
dal 14 settembre 1860 furono riportati soltanto sulla ‘Gazzetta di Gaeta’,
unico Organo di comunicazione tra i Reali e la truppa.
Copie di questi giornali circolarono anche nella Capitale del Regno di Napoli.
Esse furono portate da alcuni soldati che, provenienti dal Nord,
le avevano cucite nei propri pastrani per attraversare le linee di fuoco nemiche.
Non vi era altra via di comunicazione tra Gaeta e il resto del mondo nell’ottobre del 1860.
Ecco poi la spiegazione alla seconda domanda.
Il 15 ottobre 1860 gettò l’ancora nella rada di Gaeta
l’éscadre d’évolution francese al comando del Vice Ammiraglio Le Barbier de Tinan
e, sotto la sua protezione, anche diversi bastimenti commerciali francesi
andavano e venivano per far evacuare la popolazione dalla cittadina e per trasportare merci.
Ciò accadde per quasi un mese e mezzo.
Fu appunto con uno di questi vapori francesi di commercio
che un volontario approfittò per inviare comunicazioni sulla guerra in atto ai propri familiari
che risiedevano a Berna in Svizzera come è riportato all’interno della missiva”.
Fonte: Lo svolazzo di Gaeta sul Regno di Napoli.
La spregiudicata Monarchia sabauda spedisce il proprio esercito al Sud, col pretesto di costituire un’argine a una possibile rivoluzione, di scongiurare l’anarchia, di evitare la degenerazione di quella “Spedizione” a cui aveva garantito protezione, armi e rifornimenti.
“Mentre i garibaldini stavano lentamente risalendo dalle province meridionali, da nord si mosse l’esercito piemontese, che scelse di intervenire nel conflitto” – scrive Lorenzo Del Boca. “Non avevano dichiarato guerra le camicie rosse e non la dichiararono i piemontesi, che pretesero di giustificare l’ingiustificabile sostenendo che si assumevano il ‘compito ingrato’ di ‘fermare l’anarchia’. A giudizio di Cavour, c’era il rischio che l’impresa dei Mille potesse degenerare in una vera e propria rivoluzione, con esiti politici allarmanti per le altre monarchie d’Europa. Se la guerra non fosse stata fermata tempestivamente – si preoccupavano a Torino – averebbe rapidamente investito i territori dello Stato Pontificio, mettendo a repentaglio la sicurezza di Pio IX. Occorreva intervenire velocemente per troncare possibili sbocchi ‘democratici’ e proteggere il Papa con i suoi possedimenti. Sempre dall’entourage di casa Savoia, si evidenziava come solo Vittorio Emanuele II – con il suo esercito – fosse nelle condizioni di ripristinare l’ordine“.
E’ alle porte un conflitto senza precedenti. I moti del 1820-21 e del 1848-49 avevano una matrice politica, puntavano a realizzare uno Stato liberale e costituzionale. Nel 1860 sbuca fuori un fatto materiale, nuovo e imprevisto: la messa in discussione dei confini geografici del Regno e, con essi, della dinastia. Il conflitto cambia di forma e dimensione. Impone una scelta di campo, senza possibilità di mediazioni: da un lato gli italiani, che sotto il tricolore e lo scettro di Vittorio Emanueleprolungano la stagione delle Guerre di Indipendenza, dall’altro i legittimisti, fedeli al giglio borbonico e a Re Francesco, pronti a combattere contro gli invasori piemontesi, per preservare la propria indipendenza.
Nello scontro di legittimità – tra i Savoia conquistatori e i Borbone spodestati – il Piemonte possiede gli appoggi internazionali e il potere politico per marcare la differenza tra lealtà e tradimento, laddove Napoli è invisa alla Potenze europee e ha un sostegno frammentato e d’incerta identificazione, che fatica a elaborare una visione ideologica e un’azione comune. Emergono in un sol colpo tutte le differenze tra la forza e il consenso dei due progetti di Stato.
“La politica consentì che uno Stato garantista invadesse i territori di un altro Stato” – scrive ancora Lorenzo Del Boca. “E se il pretesto era quello di proteggerne l’integrità geografica, la protezione venne esercitata così bene che, alla fine, tolsero al Papa le Marche e l’Umbria per annetterle al Piemonte. Per poter svolgere con dedizione il compito che si era auto-assunto – cioè quello di difendere Pio IX – il governo di Torino ebbe la pretesa che lo Stato della Santa Sede licenziasse le truppe al suo servizio, fino a quel momento efficaci difensori del Papato. E poiché Roma non disarmò, il Piemonte – sempre con scopo protettivo – attaccò senza tanti complimenti.
L’impresa venne considerata un altro capolavoro intellettuale di quel genio di Cavour. In realtà sembrerebbe piuttosto un esempio di pirateria diplomatica.
Le truppe piemontesi varcarono la frontiera l’11 settembre 1860“.
All’invasione piemontese, di Umbria e Marche, Francesco oppone un esercito ricompattato, forte di una scelta libera e coraggiosa. E’ un esercito ancora valido nei numeri – ha perso solo 5000 uomini – ma è anche un esercito demolito nella struttura e nelle gerarchie, proprio nel momento in cui è chiamato a una guerra diversa dai conflitti con cui era abituato a misurarsi.
Il modello militare napoletano vedeva nell’esercito uno strumento per assicurare l’ordine interno, per annichilire le spinte liberali e reprimere il dissenso. E l’esercito borbonico era stato eccezionale nell’assolvere la sua missione. Aveva sistematicamente sconfitto le rivoluzioni in armi – dai moti siciliani del 1837 sino alla spedizione di Sapri del 1857, passando per il grande successo del 1848 – e ogni volta ne era uscito indenne. Ma non si era mai misurato in una guerra contro un nemico esterno, a scopi di conquista o di difesa. Non era educato all’obiettivo principale delle altre monarchie europee, l’acquisizione di nuovi spazi geografici su cui esercitare la sovranità, o la protezione dei propri territori dalle mire espansionistiche di altri Stati (l’unico banco di prova l’aveva avuto con la Prima Guerra di Indipendenza, a fianco dell’esercito piemontese: un’esperienza circoscritta nel tempo, debole nei contenuti, poco sentita, con una posta in gioco fumosa e dubbie possibilità di successo. Quelle stesse forze militari riuscirono invece magnificamente bene quando, sottratte a una battaglia per loro inusuale, poterono dedicarsi alla riconquista della Sicilia).
Con questo esercito ci si giocò l’ultima carta per riappropriarsi del Regno, si andò dritti alla più autorevole fonte di legittimazione: lo scontro armato col nemico sul fronte del Volturno, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.
“Certo, quella volta, i borbonici fecero sul serio, andarono all’assalto con vigore e furono vicini alla vittoria. Questo tipo di scontri campali sono difficili da raccontare perché condizionati da una serie di circostanze che sfuggono persino ai testimoni immediati. Si corre il rischio di presentare come geniale una decisione maturata in modo del tutto occasionale. Comunque, più volte i garibaldini furono costretti a ripiegare e, da entrambe le parti, si registrarono episodi degni di eroismo. […]. Lo scontro fu aspro, violento e, fino all’ultimo, incerto. Il numero dei morti e dei feriti garibaldini superò di gran lunga quello dei borbonici, ma alla fine l’esercito di Franceschiello dovette fermarsi e ripiegare. I volontari vinsero nel senso che non si lasciarono sconfiggere, e i borbonici persero, nel senso che non furono in grado di sfondare le linee nemiche. Ormai, presi a tenaglia dalle camicie rosse da un lato e dai piemontesi in arrivo dall’altro, non avevano che da rassegnarsi e considerare chiusa la partita“.
La Battaglia del Volturno divenne mito nel momento stesso in cui si svolgeva: “gli animi erano determinati a combattere fino all’ultimo respiro, per rivendicare l’onore dello esercito patrio e far trionfare, con l’autonomia del Regno, i diritti della legittima dinastia“, ricorderà il Colonnello borbonico Giovanni Delli Franci. Re Francesco – poco addentro ai meccanismi della guerra – realizzò solo alla fine che i suoi Ufficiali, per età, vissuto, e storie personali, non avrebbero potuto condurlo alla vittoria. Ma il Volturno ebbe comunque i suoi volti e i suoi eroi. Nel segnare il tramonto di ogni riferimento conosciuto, e l’alba di un nuovo racconto, il Volturno scrisse il prologo alla narrazione della Patria dei Vinti. Re Francesco II ne uscì da protagonista, simbolo di una regalità non più ereditata ma conquistata e perfezionata nel conflitto, nell’aderenza a un’onesta di fondo, l’eroe di una nazione usurpata, l’incarnazione di una dinastia secolare, legata a doppio filo ai territori, alle tradizioni, all’identità napoletana. Nulla di più romantico di una lotta impari, dall’esito segnato, niente di più poetico di una sconfitta, soprattutto se ingiusta.
“Fra i doveri prescritti ai Re, quelli dei giorni di sventura sono i più grandiosi e solenni, ed io intendo compierli con rassegnazione scevra di debolezza“, aveva proclamato Francesco il 5 settembre, alla sua partenza da Napoli. Il quadrante della Storia contò 153 “giorni di sventura“, e i 93 dell’assedio furono i più “grandiosi e solenni“. Poi, il congedo. “Vi ringrazio tutti: a tutti stringo la mano con effusione di affetto e di riconoscenza. Non vi dico addio ma arrivederci. Conservatemi intanto la vostra lealtà, come vi conserverà eternamente la sua gratitudine e la sua affezione il vostro Re Francesco“.

La morte copre di un mesto velo le discordie umane,
e gli estinti sono tutti uguali agli occhi dei generosi”.
(Enrico Cialdini, 17 febbraio 1861)
14 febbraio 1861:
il Regno di Napoli non esiste più, ma i francobolli borbonici continuano a circolare.
“Signori! Negare a voi il diritto di gioire della presa di Gaeta sarebbe illogico.
Ma festeggiarla sotto gli occhi di Francesco II
nel dì in cui egli tornava più tradito che vinto, dall’ultima sconfitta;
festeggiarla in Roma, dove il Re spodestato con la sua famiglia aveva trovato un ospitale asilo …
è tal fatto, che congiunge crudeltà, codardia, inciviltà, dappocaggine”.
(Dal Manifesto stampato a Roma, a firma di Francesco, il 14 febbraio 1861,
contro “la baldoria e la gazzarra contro Francesco II, inscenata al suo arrivo al Quirinale”)

Giornale “L’Omnibus” del 26 febbraio 1861, da Napoli a Tagliacozzo,
affrancato con un esemplare da mezzo tornese dell’emissione delle Province Napoletane.
Il giornale riporta il documento integrale della capitolazione di Gaeta, nei suoi 23 punti.
Re Francesco II delle Due Sicilie, l’ultimo Re di Napoli, è per tutti Franceschiello, un diminutivo con una chiara intonazione dispregiativa. Scarsa presenza, imbelle, timido, fragile, insicuro, cupo, triste, annoiato, abulico, ingenuo, incompetente, indifferente, taciturno, depresso, bigotto e superstizioso. La brutta copia dal padre, nel più perfido degli apprezzamenti.
Impietoso, ai limiti dell’irriverenza, il ritratto che ne fece il Conte di Groppello, Incaricato d’Affari sardo a Napoli, nella sua relazione a Cavour del gennaio del 1857, in occasione della maggiore età del Principe: “questo Principe è figlio unico di primo letto di Ferdinando II ed al popolo napoletano, che ancora per nulla lo conosce, dovrebbe essere caro, perché gli richiama alla mente il ricordo delle virtù della sua augusta madre Maria Cristina di Savoia […]. Per somma sventura però i pregevoli doni di cui è fama esser stato dotato dalla natura questo Principe, non furono in nessun modo sviluppati da una educazione adatta all’alta posizione quale egli è destinato ad occupare nel mondo. La sua educazione fu informata da uno spirito stolto, l’istruzione che egli ha ricevuto è difettosa in moltissime parti […]. La conoscenza pratica degli uomini e delle cose gli fa intieramente difetto […]. Dicesi che ami assai suo padre, ma che assai più lo tema e gli obbedisca tremando. […]. Più volte si fece a Corte disegno di maritarlo, ma mai si trovò principessa che avesse, secondo i parenti, le doti che convenissero alle esigenze politiche di questa R. famiglia […]. Egli è sempre soggetto ad una severa sorveglianza di giorno e di notte. Ogni suo atto, ogni sua parola sono gelosamente spiati, ed una persona destinata dal Re suo padre dorme tutte le notti nella sua camera. I suoi istruttori vanno annoverati tra gli uomini che hanno fama qui di più incapaci ed inetti, in quanto concerne le scienze e le lettere, e dei più zelanti e accaniti difensori delle più falsi e demoralizzanti dottrine, in fatto di principi politici e dell’arte di governare“.
La monografia “Un re in esilio. La corte di Francesco II a Roma dal 1861 al 1870” – del 1928 – darà un ampio resoconto del decennio successivo al crollo delle Due Sicilie, attraverso le memorie di Pietro Calà Ulloa, ultimo Presidente del Consiglio del Regno di Napoli. Gino Doria, il curatore del volume, farà suo lo sferzante giudizio degli italiani di parte liberale: “Il mite e mistico abitatore del Quirinale prima, del palazzo Farnese poi, è un povero essere inoffensivo, che insegue vanamente il sogno della riconquista, piatendo presso i potentati d’Europa, ordinando ai suoi ministri all’estero di protestare per il riconoscimento del nuovo regno d’Italia, chiedendo ai suoi ministri di Roma la composizione di scritture e scritture politiche che difendano la causa del Borbone spodestato e offendano la amministrazione sabauda nell’ex-reame, sovvenzionando giornali clandestini: azioni risibili tutte, ché il sogno rimane sempre sogno, i pianti rimangono inascoltati – persino dall’Austria, persino dal Papa -, le proteste rimangon soffocate dai continui riconoscimenti del nuovo regno – persino da parte della Russia, persino da parte della Spagna – le scritture dei ministri rimangono intonse, i giornali invenduti. Il paese ne ride, come di una piacevole buffoneria offerta a distrarlo da più gravi pensieri, e il lasagnone, il bombino, il Cecchino fa spese di questa farsa che si rappresenta nella capitale del mondo cattolico, con tutto il comparsume della corte pontificia e degli zuavi francesi“.
Era questo Re Francesco II di Borbone, l’ultimo Re delle Due Sicilie?
“Voi sognate l’Italia e Vittorio Emanuele, ma purtroppo sarete infelici.
I napoletani non hanno voluto giudicarmi a ragion veduta;
io però ho la coscienza di aver fatto sempre il mio dovere,
ad essi rimarranno solo gli occhi per piangere”.
(Re Francesco II delle Due Sicilie)
Negli anni Novanta dell’Ottocento sta per morire, a Verona, il Tenente Generale Salvatore Pianell, Comandante del Corpo d’Armata, Cavaliere dell’Annunziata, Senatore del Regno d’Italia. Era stato tra i pochi militari a brillare a Custoza, nella Terza Guerra di Indipendenza, e anni prima, da Ministro della Guerra di Re Francesco, aveva contribuito alla caduta del Regno delle Due Sicilie. Ora, davanti alla morte, sente il bisogno di scrivere a Francesco, per chiedergli perdono. E Francesco gli risponde affettuosamente, confortandolo. Il Sovrano decaduto non era mai stato un condottiero, ma restava un gentiluomo e un’anima religiosa, e tanto bastava.
Questo è Francesco II di Napoli, l’ultimo Re delle Due Sicilie: un Re distrutto, ma non sconfitto, al quale tradimenti, usurpazioni e calunnie non riescono a sollecitare un sentimento di odio né un desiderio di rivalsa terrena. Cavalleresco, mite, cortese, dolce di carattere, di indole benevola, di somma franchezza, leale, scrupoloso e sensibile, forse poco avvezzo alle tortuose sinuosità della politica e alle ambiguità della diplomazia, ma sicuramente amato dalle popolazioni in mezzo alle quali era cresciuto.
“Credeva solo al bene quando Dio lo chiamò sul trono” – scriverà il Visconte Poli – e subì una congiura ancor prima di salirvi, il tentativo della matrigna – la Regina Maria Teresa, seconda moglie di Ferdinando – di sostituirlo col Conte di Trani. Filangieri gli consegnò le prove del complotto, le carte che dimostravano la cospirazione della Regina, e Francesco le gettò nel fuoco, accompagnando il gesto con parole definitive: “E’ la moglie di mio padre!“.
Credeva solo al bene quando Dio lo chiamò sul trono, e fronteggiò un groviglio di intrighi da soverchiare il più astuto e spregiudicato dei politici, si ritrovò invischiato in una “guerra ingiusta e contro la ragione delle genti“, come la definì nel Proclama del 6 settembre.
Credeva solo al bene quando Dio lo chiamò sul trono, e preservò intatta la sua credenza a costo di snaturare il clima di guerra: “il coraggio e il valore degenerano in brutalità e ferocia quando non siano accompagnati dalla virtù e dal sentimento religioso“, ricorderà ai suoi soldati in prossimità della decisiva Battaglia del Volturno.
Questo era Francesco II, l’ultimo Re delle Due Sicilie: una scomoda ospitalità a Roma con una camarilla di parolai intriganti, le tristi notizie sul suo reame, i numerosi lutti familiari – in special modo la sua unica figlia, Maria Cristina Pia, di appena tre mesi -, e poi un esilio trentennale, dal 1861 al 1894, l’anno della sua morte, nella piccola città termale di Arco di Trento, allora territorio austriaco, dove era conosciuto semplicemente come Signor Fabiani.
Maria Sofia di Baviera, l’ultima Regina delle Due Sicilie,
soprannominata affettuosamente “Spatz”, passerotto,
e poi “aquiletta bavara”, da D’Annunzio, per la sua indole battagliera.
Oppose l’impeto ribelle dei suoi 19 anni alle subdole manovre dell’aggressore.
Rischiò la vita di continuo, per sostenere le truppe a Gaeta.
“La presenza sua sopra i bastioni aumentava il coraggio dei soldati”
– annotò Angelo Insogna, intellettuale legittimista napoletano –
“e rianimava, nel cuore di questi diseredati della fortuna, la fiducia e le forze”.
Insistette con Re Francesco per attuare una resistenza a oltranza, dopo la sconfitta del Volturno,
e fu irremovibile nel voler restare, tra freddo, cibo scarso e epidemia di tifo,quando Re Francesco la invitò a lasciare la roccaforte per l’aggravarsi della situazione.
“Ho fatto ogni sforzo per persuadere S.M. la Regina a separarsi da me,
“ma sono stato vinto dalle sue tenere preghiere e dalle sue generose risoluzioni”
– scrive Francesco in una lettera a Napoleone III –
“Ella vuol dividere meco, sino alla fine, la mia fortuna,
consacrandosi a dirigere negli ospedali la cura dei feriti e degli ammalati;
da questa sera Gaeta conta una suora di carità in più”.
Ma le cronache raccontano pure di una Maria Sofiain uniforme militare,
impegnata a passare in rivista i soldati dell’esercito,
e poi, sfumando in leggenda, in prima linea sugli spalti di Gaeta,
a sostituire un artigliere ferito a morte, per continuare a far fuoco contro i piemontesi.
“Piuttosto che stare qui, amerei morire negli Abruzzi in mezzo ai quei bravi combattenti”,
sospirò durante l’assedio di Civitella del Tronto,
l’ultimo lembo di terra borbonica a cedere, col Regno di Italia già proclamato.
Conquistò l’attenzione e la simpatia di cronisti e letterati di tutta Europa,
i giornali le dedicavano articoli e poesie, e di lei scrissero Daudet e Proust.Dopo la capitolazione di Gaeta si trasferì con Francesco a Roma,
se ne allontanò per brevi periodi, per progettare la riconquista del Regno.
Ebbe molteplici contatti con gli avversari di Casa Savoia
e con i più noti anarchici del tempo, da Charles Malato ad Errico Malatesta.
Seppe fare un uso efficace dei simboli e della sua stessa immagine,
e con le immagini si provò a fiaccarne lo spirito combattivo,
architettando un disegno diffamatorio che toccò il fondo della nequizia.
Fotomontaggi tanto abili – per l’epoca – quanto squallidi e oltraggiosi:
la testa della Regina montata sul corpo di una giovane prostituta in pose lascive,
un’immagine inviata a tutte le personalità della ribalta internazionale,
dal Papa all’Imperatore d’Austria, da Napoleone III allo Zar di Russia.
Non fu una vita facile, e assomiglia poco a una vita da Regina,
ma Maria Sofia non smarrì mai la sua regalità, la dignità e il sorriso.
A distanza di mezzo secolo, sopravvissuta ai suoi tempi, la si ritrova in Germania,
in visita ai campi di prigionia durante la Prima Guerra Mondiale,
alla ricerca dei suoi sudditi divenuti soldati italiani.
“Fra quei soldati laceri ed affamati, lei cerca i suoi napoletani”
– riferirà Arrigo Petacco –
“Distribuisce, come a Gaeta, bons bons e sigari”.
Questa giovane straniera,bella, intrepida, indomita,
conquistò il popolo meridionale e ne rimase conquistata,
non ebbe mai modo di conoscere il suo Regno,
ma lo amò da subito e lo amò per sempre.
Questo era Re Francesco II, questa era la Regina Maria Sofia.
“In mano a cospirazioni continue non ho fatto versare una goccia di sangue; ed hanno accusato la mia condotta di debolezza. Se l’amore più tenero pei miei sudditi, se la fiducia naturale della gioventù nell’onestà degli altri, se l’orrore istintivo al sangue meritano questo nome, io sono stato certamente debole“.
“Ho creduto di buona fede che il Re di Piemonte, che si diceva mio fratello, mio amico, che mi protestava la invasione di Garibaldi, che negoziava col mio governo un’alleanza intima pei veri interessi d’Italia, non avrebbe rotto tutti i patti e violate tutte le leggi per invadere i miei Stati in piena pace, senza motivi né dichiarazione di guerra. Se questi erano i miei torti, preferisco le mie sventure ai trionfi dei miei avversarii“.
Il Proclama dell’8 dicembre 1860 già delinea una regalità destinata a sfociare in santità, secondo la profezia di Padre Borelli, ricordata dallo stesso Francesco appena sbarcato a Gaeta: “Se Vostra Maestà non è stato un gran Re in terra, sarà un gran Santo in cielo“.
fonte
https://tesoridicarta.blogspot.com/2020/09/siamo-fottuti-regina.html








 invio in corso...
invio in corso...



