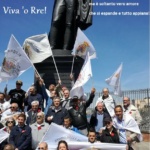Il lungo 1799-Dalla Riconquista alla resistenza antifrancese del Decennio
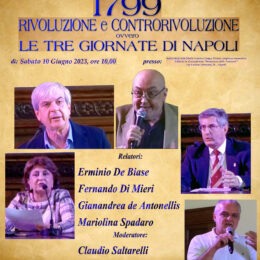
Dopo aver pubblicato il video integrale del Convegno del 10 di giugno 2023 sulle “Tre Giornate di Napoli” e i singoli interventi del Prof. Erminio De Biase, organizzatore del convegno, del Prof. Fernando Di Mieri che ha messo a fuoco il tema teologico e religioso e del Prof Gianandrea de Antonellis che ha presentato l’ultima fatica su Eleonora Pimentel Fonseca oggi chiudiamo con l’intervento della Prof.ssa Maria Carmela Spadaro che ha parlato del lungo 1799 terminato con l’invasione francese. Dopo la relazione ci sarà il video del suo intervento
- Le premesse
La data del 13 giugno segna una ricorrenza importante nella storia dell’Italia meridionale, registrando un evento epocale: la marcia del Cardinale Ruffo dalla Calabria a Napoli ed il conseguente rovesciamento della cd. Repubblica partenopea rimane ancora oggi un punto fondamentale per comprendere gli eventi successivi della storia del Regno delle Due Sicilie, nonostante la storiografia si sia dimostrata spesso “distratta” non manifestando il bisogno di approfondire la portata di quegli avvenimenti[1].
La popolazione si sollevò in armi come mai più sarebbe accaduto nel corso della sua storia, per riportare sul trono il legittimo sovrano, resistendo a quella che considerava un’invasione straniera e mostrandosi determinata a rovesciare un governo denominatosi democratico, ma in realtà espressione di un’oligarchia intellettuale molto vicina alla Franci,: la cd. Repubblica partenopea non fu se non la longa manus del potere giacobino insediatosi in Francia con la Rivoluzione del 1789[2]. Quel potere scardinava le tradizionali istituzioni politiche del Paese dei gigli, ma soprattutto scuoteva dalle fondamenta una società nella quale Dio, Patria Famiglia e Re erano valori riconosciuti dalla maggioranza dei cittadini.
Le “novità” introdotte nel Regno di Napoli dai francesi erano il frutto di una democratizzazione imposta dall’alto, non voluta dalle popolazioni che non si riconoscevano nei simboli e nel linguaggio imposti dai giacobini. Il nuovo corso manifestò subito il proposito di fare tabula rasa del passato, cancellando ogni riferimento a tradizioni e costumi plurisecolari: fu stravolta la toponomastica, sostituito il calendario con il decadario, cancellato ogni riferimento ai Santi, propagato un senso di diffusa ostilità verso la religione, considerata un limite al progresso ed uno strumento per tenere asservite le popolazioni[3].
L’azione dei clubs giacobini e delle logge massoniche, particolarmente presenti in Calabria ed a Napoli, fu intensa. Il passaggio dall’Antico al Nuovo Regime, di cui erano evidenti i sintomi nella società e che specialmente nel Regno di Napoli aveva già da tempo intrapreso la via di un cauto riformismo[4], avvenne invece in maniera traumatica. Il rovesciamento del paradigma sociale fu improvviso ed imposto con la forza: al diritto comune, che pur con le sue contraddizioni rispecchiava una società che riconosceva importanza al ruolo svolto dai corpi intermedi ed alle consuetudini quali espressione di un diritto proveniente “dal basso”, si sostituì la volontà del legislatore ed il primato della legge. Sintesi del mutamento fu il trinomio rivoluzionario (liberté, egalité, fraternité) che sedusse specialmente le élites politiche ma che, al di là del fascino delle parole, significò l’attuazione di un programma concepito in chiave anticristiana ed antireligiosa[5]. Nei fatti, la liberté realizzava l’ emancipazione dell’individuo da ogni legame di dipendenza esterno alla sua ragione e volontà (la religione cristiana è definita “superstizione”); la fraternité comportava l’obbligo morale di ogni cittadino di partecipare a questa “missione liberatrice” dai vincoli ereditati dal passato e non liberamente scelti; l’égalité si realizzava come risultato della volontà del legislatore, che dichiarava uguali tutti i cittadini senza distinzione alcuna e prescindendo da oggettive differenze di condizioni e situazioni. Era una uguaglianza teorica e non reale, tanto che nella Costituzione italiana il principio fondamentale di uguaglianza enunciato nel comma 1 dell’art. 3 è sottoposto giustamente ai “correttivi” del successivo comma 2, proprio al fine di evitare gli effetti paradossali ai quali porterebbe un’indiscriminata parificazione, essendo piuttosto evidente che l’identico trattamento di cittadini con differenti possibilità e condizioni di partenza produce inevitabilmente disuguaglianza, discriminando proprio i più deboli ed i meno fortunati.
L’attuazione tout court di quel principio nella società del tempo, invece, comportò la soppressione di privilegi e prerogative di cui erano titolari soprattutto le gerarchie ecclesiastiche ed il ceto nobiliare, ma non risparmiò comunità di villaggio, associazioni professionali, diritti reali su terre e beni comuni di pascolo, di pesca, di caccia: l’ abolizione degli usi civici produsse conseguenze drammatiche a danno delle popolazioni, specialmente rurali[6]. E’ questo un tema al quale ancora oggi si presta poca attenzione, ma che ha inciso profondamente nel tessuto sociale dell’Italia meridionale, con inevitabili ripercussioni persino su eventi molto successivi e tuttora poco noti (ne sono esempio le rivolte contadine registratesi ancora nei primi decenni del Novecento in molti paesi del Sud[7], che pur nascendo da fatti contingenti, hanno alle spalle una lunga storia, le cui origini riportano proprio alla normativa francese)
- La reazione sanfedista: difesa di un’identità.
Il “colpo di stato” che costrinse i sovrani a lasciare Napoli per rifugiarsi in Sicilia, consegnò la direzione del governo e lo Stato ai rivoluzionari giacobini, creando un governo fantoccio della Francia; impose la democratizzazione della società ricorrendo alla forza e mettendo al bando chi vi si opponeva attraverso l’ introduzione del reato di brigantaggio, dai contorni indefiniti e già sperimentato in Francia nella repressione della resistenza vandeana[8]; provocò la reazione armata delle popolazioni. La marcia sanfedista non fu che la risposta quasi scontata e sicuramente attesa, come evidenzia un documento molto interessante[9], ma scarsamente citato.
Il 13 gennaio 1799 don Biagio Rinaldi, Cappellano e Parroco della chiesa di S. Maria dell’Episcopio di Scalea, faceva pervenire al Re, che si trovava a Palermo, un suo “piano per il riacquisto del Regno”. Il documento mette ben in evidenza quale fosse l’animo delle popolazioni, in attesa di un cenno del sovrano, ma soprattutto di una guida per sollevarsi contro il governo repubblicano e ripristinare la legittima sovranità del trono.
Le notizie di violenze, saccheggi, tradimenti e di come ne fosse sconvolto l’ordine sociale, inducevano il Rinaldi a ritenere che fosse urgente e necessario “respingere il nemico, abbattere i traditori, sollevare in massa i fedelissimi vassalli” , offrendosi personalmente, se il Re glielo avesse ordinato, di radunare “gente atta all’armi” per fare entro un mese “ un corpo rispettabile di calabresi e con questi dar sesto alla capitale e mandare alle ceneri tutti gl’infedeli e felloni”. Sono peraltro molto interessanti le modalità con cui il Rinaldi pensa di procedere all’attuazione del piano: “io adopererò e il Crocifisso e la forza per le province di Calabria , non solo, ma anche per tutto il Regno… per fare a V. M. un secura e valevole difesa non solo, ma da poter distruggere quanti de’ nemici rattrovansi per l’Italia” [10]
Lo zelo del sacerdote scosse evidentemente l’animo del re, che individuò la guida più idonea per organizzare la Riconquista nel Cardinale Fabrizio Ruffo.
Che l’idea fosse stata del Rinaldi o che fosse già nell’aria e la missiva del cappellano calabrese l’avesse soltanto sollecitata, poco importa. In meno di un mese il corpo di spedizione fu formato e l’impresa avviata con le modalità indicate dal sacerdote.
La vicenda della marcia sanfedista è nota e perciò se ne riassumono solo i tratti essenziali. Il 7 febbraio 1799 un drappello di uomini al comando del Cardinale Ruffo partiva dall’estremità meridionale della Calabria, ingrossando via vie le sue file fino a concludere la marcia vittoriosamente, e giungeva a Napoli il 13 giugno, dove metteva in fuga i giacobini, consentendo ai Borbone di recuperare il Regno.
Piuttosto è interessante riflettere sugli interrogativi che da sempre questa vicenda suscita[11]: com’è stato possibile che si realizzasse in così poco tempo una mobilitazione così massiccia della popolazione? Come mai l’avanzamento delle truppe sanfediste nel territorio fu rapido e, di fatto, incontrastato dalle popolazioni, che all’approssimarsi del Ruffo nei loro paesi abbattevano gli alberi della libertà innalzando, al loro posto, la Croce ed inneggiando allo spodestato sovrano? Evidentemente c’erano alla base di quell’adesione così imponente e convinta, motivazioni molto forti, che affiorano molto chiaramente nella missiva del Rinaldi. La consapevolezza e la convinzione che fosse necessario difendere l’indipendenza del Regno da un’invasione straniera, manifestando fedeltà al legittimo sovrano e custodendo la fede in Cristo e nella religione dei padri – può spiegare in gran parte l’adesione delle popolazioni ad un corpo di spedizione che, composto inizialmente di soli 7 uomini, in 5 mesi raggiunse e superò il numero di 16.000. Il dato è sicuramente interessante ed andrebbe ulteriormente indagato ma finora ha destato solo stupore e dato origine semmai a congetture spesso fantasiose ma prive di fondamento[12].
Al passaggio del Ruffo e della sua armata della Santa fede le città si realizzavano spontaneamente, identificando in essi i veri liberatori. Probabilmente, l’aver adottato il simbolo della Santa Croce come propria insegna consentì ai sanfedisti di farsi riconoscere da un popolo rimasto profondamente cattolico: nel clima di confusione e di messa in discussione di tutte le verità di fede che i francesi seminarono, ritrovare e difendere la propria identità, culturale e spirituale, fu determinante. Quanto fosse importante per le popolazioni riconoscersi in quel simbolo, assurto a segno di identità nazionale, si evince, ad esempio, anche da una ricevuta di pagamento[13] del 1802, attestata da un atto notarile, in cui il “maestro fabbricatore” Francesco Maoro della città di Cosenza, dichiara di essere stato pagato per la realizzazione di una piramide in cima alla quale era stata collocata la Croce, dopo il passaggio dei francesi. Il documento è interessante anche perché racconta l’antefatto: il 15 marzo 1799, quando l’Armata reale del Ruffo entrò in Cosenza, la città si era già realizzata spontaneamente, senza opporre alcuna resistenza; i sanfedisti si limitarono pertanto a piantare alcuni vessilli della Santa Croce “in quel medesimo luogo dov’erano stati piantati gli infami alberi della sedicente Repubblica”. Ma, poiché in uno dei quartieri della città, frequentato da animali – bisognerebbe poi capire se davvero si trattasse di animali perché le fonti attestano frequenti episodi del genere in diversi paesi della Calabria, dove anche dopo la conclusione della vicenda sanfedista si registrano tentativi di abbattere le Croci e ripiantare gli alberi della libertà – accadeva che spesso ne venisse smosso il terreno con conseguente crollo dell’insegna, un gruppo di cittadini aveva chiesto al Preside della Provincia di Calabria Citra Don Michele Peredes l’autorizzazione ad erigere una Piramide in muratura per innalzarvi la Croce. Fu concesso il permesso, con la prescrizione di formare “ la base di detta piramide analoga alla larghezza della strada per non recare incomodo ai cittadini e deteriorarsi l’aspetto della città”. Assunse l’onere della sua realizzazione Don Antonio Cavalcanti, nobile cosentino, che ne commissionò la realizzazione al mastro Maoro. Questi effettivamente riceveva poi dal Cavalcanti la somma di 40 ducati, di cui si dichiarava interamente soddisfatto.
- Cause e ragioni di una lunga resistenza
Il documento, che non è l’unico del genere, attesta il protrarsi di una guerriglia tra opposti schieramenti che continuò ininterrotta ben dopo la conclusione della vicenda sanfedista, legandosi alla resistenza antifrancese del Decennio napoleonico: un filo rosso che mette in luce la contrapposizione tra due diverse concezioni di vita e di valori.
E’ noto che al proclama iniziale del 5 piovoso anno 7 (24 gennaio 1799) con il quale il generale Championnet, dopo avere bombardato la città dal forte di Sant’Elmo nei giorni precedenti, proclamava solennemente ai napoletani che “siete finalmente liberi; la vostra libertà è il solo prezzo che la Francia vuole trarre dalla sua conquista….” faceva seguito, appena tre giorni dopo, il decreto del 8 piovoso con il quale si stabiliva il prezzo di quella libertà, consistente in due milioni e mezzo di ducati “ somma …. che sarà interamente pagata dalla Città di Napoli e suo casali”.
Non era che un acconto: ben presto sarebbe stato richiesto agli abitanti delle province il pagamento di altri 15 milioni. Si trattava di un’imposizione che Vincenzo Cuoco considerava smoderata” e “capricciosa” anche nel modo di ripartirla tra i cittadini: “ si videro famiglie tassate di pochi ducati, e tassate in somme esorbitantissime quelle che nulla possedevano; ho visto la stessa tassa imposta a chi aveva sessantamila ducati all’anno di rendita, a chi ne aveva diecimila, a chi ne aveva mille”[14] Appunto: uguaglianza indistinta ed indiscriminata.
Alla resistenza “antidemocratica” delle popolazioni si rispose, in generale, con saccheggi e razzìe. Le fonti attestano numerosi episodi in diversi comuni, così come evidenziano i motivi che la determinarono.
All’impossibilità di reperire tutto il denaro nel breve termine imposto di due mesi, si rispose facendo ai napoletani una “concessione”: di pagare in beni ed oggetti preziosi. Dieci giorni più tardi, il commissario civile Faypoult requisiva, dichiarandoli appartenenti alla Repubblica francese, tutti i beni privati del Re e della sua famiglia, le proprietà degli ordini cavallereschi, ma anche di coloro che avevano seguito il Re in Sicilia, le terre ecclesiastiche, che furono messe in vendita, gli arsenali, la zecca, la tesoreria, i banchi, i Musei, le biblioteche, persino gli scavi di Pompei. Tutto passava nelle mani dei francesi, mentre i giacobini napoletani si preoccuparono soprattutto di propagandare, attraverso i giornali, il nuovo credo ed un dettagliato programma anticlericale stilato da Mably sotto il nome di “diritti e doveri dei cittadini”: primo di questi “doveri” era il rinnegamento della fede cristiana.
Nelle province furono inviati gli agenti democratizzatori per diffondere queste novità, attraverso un processo di indottrinamento, che passava in primo luogo dalla manipolazione del linguaggio. Con amaro realismo, Giuseppe Maria Galanti nelle Memorie denunciava[15] lo scompiglio creato da questi agenti ed il clima di dispotismo e di anarchia: “Generalmente si è sviluppato uno spirito veramente democratico, cioè di dispotismo, di demenza, di confusione, di disordine e dianarchia. Le virtù repubblicanesi manifestavano a suo avviso in “miserabili farse”, rappresentate ostentando “grossi cappelli con sublimi pennacchi, in vesti ornate d’oro e d’argento”
L’omiletica di S.Alfonso Maria de’ Liguori ebbe sicuramente un peso importante nell’alimentare il diffuso sentimento antigiacobino e non sarebbe corretto non darne atto; ma altrettanto sarebbe riduttivo ignorare il contesto storico-culturale nel quale quei fatti si svolsero.
Il popolo si senti tradito dai suoi stessi funzionari di governo, i quali avrebbero avuto il dovere di vigilare e custodire la Patria: l’armistizio di Sparanise, concluso dal Pignatelli insieme all’ordine incomprensibile d’incendiare la flotta in rada, determinò la rivolta che coinvolse tutti gli strati della popolazione. L’abolizione degli usi civici, il cambio della moneta, l’ateismo ufficialmente proclamato e reso condizione indispensabile per essere un buon “patriota”, la sostituzione del calendario con il decadario, da cui naturalmente scomparivano i Santi ed ogni riferimento alla religione, i saccheggi e le razzìe compiute dai francesi in ogni paese resistente alla “democratizzazione” forzata, fecero il resto. Ma neppure gli incendi appiccati contro le loro case riuscirono a fermare l’azione dei resistenti: in città si combatteva palmo a palmo, suscitando l’ammirazione degli stessi francesi, come annotò nel suo diario il generale Championnet (“on se bat dans toutes le rues, le terren se dispute pied a pied; les Lazaroni sont comandés par des chefs intrepide …. Et (leur) action fera époque dans l’histoire”).[16]
Specialmente i cd. Lazzari opposero una strenua resistenza, ma vi furono coinvolti anche molti esponenti del cd. ceto medio, contro i quali venivano altri scagliati sassi, vasi di fiori e fucilate.
Anche nelle province l’appello del Ruffo ad unirsi all’Armata della Santa Fede coinvolse tutti gli strati della popolazione: medici, avvocati, notai, nobili, contadini. Questi ultimi contribuirono, soprattutto in Calabria, in misura significativa alla spedizione (sono i “paysans de la Calabre” che anche nel 1806 resisteranno alle armate napoleoniche, turbando l’imperatore francese, il quale confesserà di temerli più dell’esercito). La presenza indubbiamente massiccia e preponderante dei contadini è indicativa degli effetti seguiti all’abolizione degli usi civici; ma è stato chiamato in causa soprattutto la loro scarsa alfabetizzazione per accreditare uno stereotipo della propaganda giacobina, veicolata attraverso i giornali, fra i quali in prima linea si colloca il “Monitore napoletano” , secondo il quale da una parte vi erano gli intellettuali le cui menti aperte si rendevano conto della necessità di un avanzamento del Regno verso il progresso, dall’altro le masse contadine, ignoranti e superstiziose, incapaci di comprenderne le ragioni. Il 1799, insomma, altro non sarebbe stato che una sorta di scontro tra la barbarie e la civiltà : schema a cui troppe volte si sarebbe fatto ricorso anche in seguito. Si dimentica o si preferisce tacere, però, il ruolo di sostegno alla reazione che svolsero le Accademie, in primo luogo l’Arcadia Reale alla quale aderirono molti intellettuali fedeli alla monarchia borbonica[17]. Avvocati, professori, letterati, medici, ecclesiastici, svolsero un compito importante nel propagare sul piano dottrinale i valori della Tradizione (fede in Dio, fedeltà al Re), contrastando la diffusione nel Regno del giacobinismo, che attraverso i clubs diffondeva l’ideologia massonica.
- Reazione nelle Calabrie: il lungo 1799.
Le Calabrie sono probabilmente le province in cui il 1799 non conosce davvero soste o interruzione, anche se la situazione può dirsi analoga in tutto il Regno, ma le ricerche su questo lungo 1799 sono abbastanza recenti e non ancora compiute; emergono periodicamente pezzi di verità, ma il mosaico è ancora da ricomporre.
Nel 1801 Ferdinando IV concede l’amnistia ai giacobini prigionieri o esuli: tra essi vi è Guglielmo Pepe, che ne approfitta subito per organizzare una cospirazione in Calabria; ma la congiura viene scoperta e Pepe arrestato e relegato nell’isola di Favignana dove rimane fino al 1806.
Le fonti documentano per tutti gli anni successivi l’azione incessante della Massoneria che spinge molti liberali a farsi promotori di azioni di disturbo, di atti cospirativi, di congiure nei diversi paesi. La presenza di logge in Calabria è documentata fin dal 1790 a Tropea, Catanzaro, Cotrone, Palmi, Seminara ed, in genere, lungo il versante tirrenico della Calabria Ultra: paesi nei quali viene innalzato l’albero della libertà e proclamata la “democratizzazione”. Si tratta, però, di iniziative che non incontrano i successi sperati dai giacobini ed anzi danno origine al formarsi di fazioni all’interno dei comuni, che sfociano talvolta in accesi conflitti e fatti di sangue per contenersi il predominio del municipio. Accade così a Montauro, Santa Cristina, Sant’Eufemia, Stilo, san Giovanni di Grotteria, dove il solo tentativo di affiggere in pubblico proclami repubblicani è impedito dai realisti locali[18]. Le spaccature profonde che si determinano nella società produrranno effetti duraturi, talvolta contrapponendo interi nuclei familiari e, al loro interno, persino membri della stessa famiglia: è un dato, anche questo, al quale si presta poca attenzione, ma che aiuterebbe invece a comprendere gli eventi successivi, a leggere in maniera critica alcuni episodi talvolta eccessivamente enfatizzati, soprattutto a collocare nella giusta cornice storica l’origine di talune “mentalità” ancora marcatamente presenti nella società non sempre con risvolti positivi.
Nel 1802 a Monteleone alcuni liberali (Gio. Battista Romei, Fortunato Mandarano, Antonio de Franco, Luigi Antonucci, Stefano Francolini, Antonio Contartese), abbattono la Croce innalzata in piazza dalle truppe sanfediste e vi ricollocano l’albero della libertà: si registrano scontri armati tra le due fazioni e la popolazione ne resta coinvolta dividendosi per gli uni o per gli altri. Episodi analoghi si ripetono frequentemente in molti altri paesi, originando una conflittualità latente ma pronta a manifestarsi alla prima occasione.
Dal 1799 al 1816 specialmente le Calabrie diventano quotidiano teatro di scontro tra filo-borbonici e filo-massonici, imprimendo anche alla successiva vicenda risorgimentale caratteri più marcati che altrove. Certo non si tratta solo di contrapposizioni ideologiche, spesso vi sono sottesi interessi di natura reale, collegati ai vantaggi, anche materiali, che il ruolo politico conferisce a chi riesce a porsi a capo di una municipalità. L’ideologia che ha comunque un peso rilevante, è spesso anche la maschera dietro cui si nasconde un’inconfessabile e meschina brama di potere. Una rilettura della storia d’Italia che tenesse conto di questi elementi, potrebbe senz’altro contribuire a fare chiarezza su tante vicende ancora enigmatiche che si pongono alle sue origini come nazione.
Quanto accade in Calabria ancora nel 1806 (la Calabria è un esempio paradigmatico di quanto accade in generale in tutto il Regno) rappresenta la cartina di tornasole degli eventi del ’99: con la feroce repressione[19] affidata prima al generale francese Andrè Massena e poi al suo collega Charles Antoin Manhès, che usano metodi terroristici per piegare la resistenza dei “briganti” calabresi l’intera Calabria viene messa a ferro e fuoco; i semplici sospettati di “brigantaggio” (basta a creare il sospetto anche una notizia falsa, spesso tendenziosa, anche perché la delazione viene incoraggiata e premiata), sono immediatamente fucilati. L’intero territorio è letteralmente massacrato da leggi che costringono i meno coraggiosi a denunciare i “briganti” ed i comuni a pagare i danni causati dai “briganti”.
La storiografia, sia pure con le dovute eccezioni, mentre carica di elementi negativi le azioni dei “briganti”, non riporta quasi mai le nefandezze contro le quali i briganti e – non di rado le brigantesse ( è una presenza significativa sotto diversi profili, quella delle donne ) – reagiscono. Ma quando lo fa, è sempre attenta a mettere in evidenza i sentimenti di odio da cui i briganti sono mossi. Non di rado, tuttavia, di fronte ai rilievi fatti da osservatori stranieri che non si capacitano del numero davvero esorbitante di briganti presenti nei diversi angoli del Regno[20], capita di imbattersi in qualche pagina che concede una sorta di apertura di credito alle insorgenze in quanto tali, chiamandole quindi con il loro nome, pur precisando che “ brigantaggio, insurrezione, controrivoluzione, rivolta sono termini destinati a rimanere comunque ben distinti e solo “si incrociano strettamente tra loro[21]
Tuttora, non si riesce a dare un giudizio sereno su questi fatti e c’è chi addirittura s’interroga se personaggi simili siano stati dei criminali o piuttosto dei benefattori!
E anche questo è un interrogativo che parte da lontano e va dritto al cuore del problema: perché i fatti del 1799 si proiettano immediatamente su quanto accadrà durante tutto l’arco del Decennio, ma soprattutto aprono la strada ai fatti successivi, del 1847-48 e poi del 1860.
E’ questo il punto. Un filo rosso lega queste date, di modo che gli eventi che si registrano possono essere letti in continuità tra loro; quel filo consentirebbe di restituire verità alla storia, avendo ragione di una narrazione troppo spesso condizionata da posizioni ideologiche previe, ma si presenta alquanto ingarbugliato e sono ancora timidi i tentativi per dipanarlo.
[1] J. J. CLEMENT, 1799, Signori e popolo. Napoli città aperta, Luca Torre editore, Napoli 1998.
[2] A. MANES, Un cardinale condottiero. Fabrizio Ruffo e la Repubblica Partenopea, con prefazione di A. DE FRANCESCO, ed. Jouvence, Romq, 1996
[3] G. GIARRIZZO, ra (1740-1800), stab tip. F. Morelli, Reggio Calabria 1907; F.M. DI GIOVINE, Rivoluzione contro Napoli, Edit. Il Giglio, Napoli 1998
[4] F. VALSECCHI, Il riformismo borbonico in Italia, Roma 1990
[5] C. GNERRE, Illuminismo, itinerario di contraddizioni. Confutazione di un mito, ed. Il Fedone, Battipaglia 1994; P. GAXOTTE, La Rivoluzione francese, trad.it.,Milano, 1949;
[6] P.VILLANI, Feudalità, riforme, capitalismo agrario, ed. Laterza, Bari 1968
[7] M. LA CAVA, I fatti di Casignana, Einaudi, 1974 (I edizione)
[8] R. SECHER, Il genocidio vandeano, trad. It., Milano 1989; G. BABEUF, La guerra della Vandea e il sistema di spopolamento, trad. It., Milano 1989
[9] A. MANES, Un cardinale condottiero. Fabrizio Ruffo e la Repubblica partenopea. Saggio storico, Casa Ed. Vecchioni, L’Aquila 1930, p.223-4 (appendice X)
[10] ibidem
[11] J.J. CLEMENT, cit, passim
[12] M. A. MACCIOCCHI, La strage delle innocenti, in Corriere della sera 17.2.1999, p. 33; contra G. FORMICOLA, Altamura, gli errori di Maria Antonietta Macciocchi, in Roma 7.3.1999
[13] Il notaio rogante è Ignazio Giudice di Cosenza ed il documento e l’atto è riportato integralmente in A. MANES, cit., ediz. 1930, p. 2214, Appendice doc. XI
[14] V. CUOCO, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, con introduz e note di N. Cortese, ed. Vallecchi, Firenze 1926
[15] G.M. GALANTI, Memorie storiche del mio tempo, a cura di A. PLACANICA, ed. Di mauro, Cava de’ Tirreni, 1996
[16] J. E. CHAMPIONNER. Souvenirs (1792-1800), a cura di M. FAURE, Parigi 1904
[17] E. SPAGNOLO, L’Arcadia reale ed il 1799. Un’accademia letteraria alla riconquista del Regno di Napoli, Edizioni Nazione Napoletana, Napoli 2000; V.A. GALDI, proclama per l Sacra Reale Maestà sua Ferdinando IC de’ Borboni, contro l’ultima invasione delle Armi Francesi e contro l’orrenda congiura de’ Giacobinici Novatori, Napoli 1799
[18] G. CINGARI, Giacobini e sanfedisti in Calabria nel 1799, ed. Casa del libro, Reggio Calabria 1978
[19] P. COLLETTA, Storia del reame di Napoli, Tip. Elvetica, Capolago, 1834; M. DONATIVI, F. CAVEDAGNA, C. COPPOLA, Manhès, un generale contro i briganti. Antologia di fonti, ed. Trabant, 2022; E. CICONTE, Storia della guerra al brigantgggio, Laterza, Bari 2020;
[20] AA.VV., Le insorgenze antifrancesi in Italia nel triennio giacobino (1796-1799), Ed. Apes, Roma 1992
[21] G. CINGARI, Brigantaggio, proprietari e contadini nel Sud (1799-1900) , Editori meridionali riuniti, 1976.
Carmela Maria Spadaro
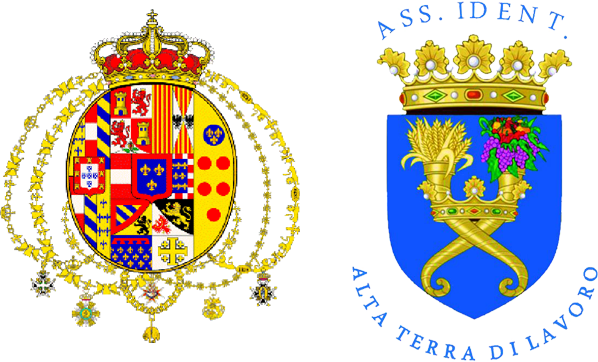


 invio in corso...
invio in corso...